Il nome di Lawrence Ferlinghetti (New York 1919) è il meno noto dei nomi noti della beat generation. La fama del poeta – di origini per metà italiane, il padre era nato a Brescia nel 1872 – è stata a lungo legata soprattutto a quella della celebre casa editrice, nonché libreria, City Lights Book, che fondò a San Francisco, nel 1953 con Peter Martin.
La City Lights, come noto, pubblicò la prima storica edizione di Howl & Other Poems, la raccolta di poesie di Allen Ginsberg che, assieme al romanzo di Jack Kerouac On the Road, rappresenta senza dubbio il titolo più noto dell’intera stagione beat. L’Urlo di Ginsberg portò al famoso processo a Ferlinghetti per pubblicazione di oscenità, che scatenò un grande dibattito nell’opinione pubblica americana e si concluse con l’assoluzione dell’editore, appellatosi al 21° emendamento2.
Ferlinghetti però è stato a sua volta artista di valore – poeta, innanzitutto, ma anche narratore, pittore – e poi appassionato testimone del suo tempo, dei suoi rivolgimenti, delle sue utopie. Mondadori ha dato alle stampe in questi giorni per la collana Lo specchio, Greatest Poems, curata da Nancy J. Peters, e tradotta da Leopoldo Carra.
Con questo libro Ferlinghetti torna quindi in un paese che ha molto amato e frequentato, l’Italia, dove nell’ottobre dell’anno scorso, nell’ambito del Premio di Arti Letterarie Metropoli di Torino, ha ricevuto il Premio alla Carriera per la sua attività letteraria, artistica e per l’impegno in favore della pace nel mondo. Solo l’ultimo dei tanti attestati di stima e di affetto che i lettori del Belpaese gli hanno tributato, nel corsi degli anni.
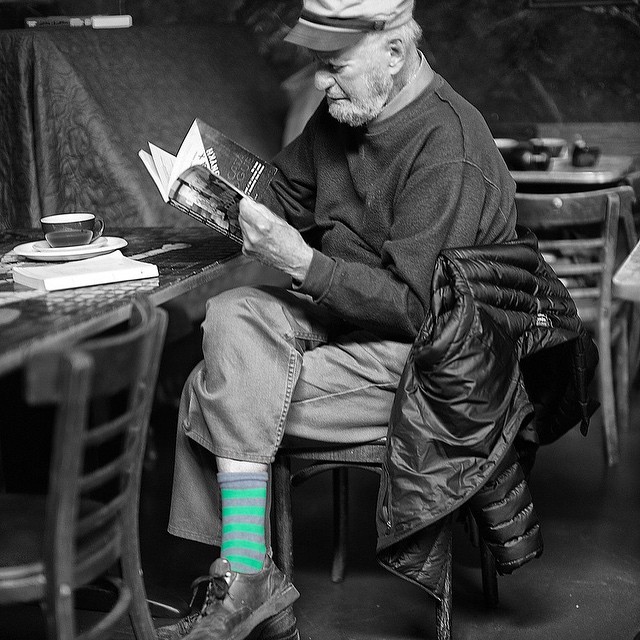
Nella sua appassionata postfazione, Carra sembra interessato soprattutto a sottolineare come la poesia apparentemente libera, giocosa, “anarchica” di Ferlinghetti contenga numerosi rimandi a una “complessa tradizione testuale, innanzitutto in lingua inglese”.
I riferimenti vanno da Dylan Thomas, il poeta gallese che nell’ultima parte della sua esistenza frequentò gli Stati Uniti e New York per i suoi indimenticabili cicli di letture, a Ezra Pound, coltissimo tessitore di rime e altrettanto raffinato “editor” (senza di lui uno dei più celebri poemi del 900, La terra desolatadi T.S. Eliot, non esisterebbe, almeno non nella sua forma definitiva), caduto in disgrazia alla fine della Seconda guerra mondiale per le sue simpatie politiche.
E poi, fra gli altri, Yeats e Whitman, poeti che, come Thomas, hanno cantato il sentimento panico della natura, quello stesso che Ferlinghetti ha inseguito sulla costa della California e nel suo ritiro di Big Sur, amato anche da tanti altri scrittori, fra cui Kerouac e prima di lui Henry Miller.
Il lettore di oggi, lontano dalle stagioni – più d’una – dei grandi fermenti poetici novecenteschi, intrappolato in una realtà poeticamente piuttosto ambigua (quella della rete, dei social), e politicamente desolante (Trump, Salvini, e chi più ne ha più ne metta), troverà in questi versi forse anche altro.
Perché, sì, i beat non erano solo simpaticamente “stoned“, aperti ad ogni influenza, dal buddismo alle droghe, dal rock alla psicanalisi. Erano artisti di valore, in tutto e per tutto affamati di letture e di cultura, spesso attenti alla forma almeno quanto lo erano al contenuto. Artisti colti, anche se non-accademici, e fa bene il traduttore a ricordarcelo.
Però, in queste pagine, ciò che sentiamo risuonare sono in primo luogo le parole di un nemico dell’ovvietà espressiva che non ha bisogno di inseguire i miti del passato o di confrontarsi incessantemente con i classici, né di coniare formule esoteriche, per far risplendere le cose che gli stanno attorno di nuova luce.
Ferlinghetti sembra un umile, allegro vignaiolo della poesia. Non se la tira mai. Cita i suoi numi tutelari, li loda apertamente, ma li cala spesso in uno scenario quotidiano, ordinario. Che diventa per suo tramite “meraviglioso”.
Leggendo Yeats non penso all’Irlanda/ma a New York di mezza estate/e a me stesso allora/mentre leggo quella copia trovata/sulla soprelevata della Terza Avenue/la soprelevata/con le sue ventole tappezzate di mosche/e i cartelli con scritto/VIETATO SPUTARE/la soprelevata/che traversava sbandando il suo mondo/[da terzo piano/con i suoi personaggi da terzo piano/dietro a porte da terzo piano (…).
È poesia che nasce dalla strada più che dalle biblioteche, fatta di illuminazioni, di squarci che si aprono all’improvviso e ci consentono di vedere “dietro al reale”, per citare Ginsberg. A volte coglie l’ironia implicita nell’esistenza, la sua levità.
Non far mangiare a quel cavallo/quel violino/esclamò la madre di Chagall/Ma lui continuò bel bello/a dipingere/E diventò famoso/E continuò a dipingere/Il cavallo con violino in bocca/E quando finalmente lo finì/saltò in groppa al cavallo/e se ne andò/agitando il violino.
A volte sembra inseguire i versi delle canzoni, ad esempio quelli di Bob Dylan, che fu dei beat un giovane compagno di strada, almeno in una delle sue tante vite.
Ancora accesi dalle stelle/siamo sdraiati sotto di loro/nella cupola della notte/mentre vanno ruotando/nelle loro rivoluzioni/formando e riformando/(oh non per noi!)/le loro mirabili/costruzioni di fosforo (…).
A volte ancora, è scopertamente autobiografica.
Fui concepito nell’estate del millenovecentodiciotto/mentre era in corso una qualche guerra/ma non impedì a due persone/di fare l’amore a Ossining quell’anno/Mi piace pensare a una riva di fiume assolata/a un picnic sull’Hudson (…).
E spesso rende omaggio agli amici.
Il poeta Jack con lo zaino leggero/che viaggia da solo/e lascia le signore sorridenti/ Dharma Jack con le beatitudini/che ubriaco su un bus attacca bottone con tutti/coi taciturni dalle facce gelide/che non parlano mai agli estranei (…).
Così lontana dall’universo terrorizzante di un William Burroughs, ma anche dai tormenti alcolici dell’ultimo Kerouac, meno inaccessibile di quella di Dylan Thomas e meno sofisticata di quella di Ezra Pound, la poesia di Ferlinghetti riconcilia con la lingua e con natura (compresa quella umana), pur non rinunciando a militare dalla parte “giusta”, quella che si oppone alla guerra, alla violenza, alla distruzione dell’ambiente, alla stupidità in genere.
Gentile anche quando denuncia il vuoto di senso del mondo, arguta, popolare, smagata: la voce di Ferlinghetti ci strappa un sorriso, sia pure nel mezzo dei nostro quotidiani naufragi. Non so quanti lettori possa incontrare, oggi, ma spero siano tanti. Spero che possa guarirne qualcuno, magari, come una sorta di preghiera laica.
E non ci indurre in tentazione/troppo spesso nei giorni feriali/Ma liberaci dal male
La cui presenza rimane inspiegata/Nel tuo regno di potenza e gloria/ Be’, Amen!












