Se n’è andato a 85 anni, in un ospedale di New York, circondato dell’affetto e dalla stima di milioni di lettori che si sono riconosciuti nei suoi romanzi, così americani eppure così universali, sparsi in ogni parte del mondo.
Non piangete Philip Roth. Ha avuto una vita felice. Ha avuto in dono un grande talento e la costanza necessaria per utilizzarlo al meglio. È non tirate fuori ancora la storia del mancato Nobel, tantomeno per lamentarvi di quello assegnato a Bob Dylan, che a causa delle regole non scritte dell’alternanza geografica – che sovra intendono all’assegnazione del premio – chiuse la partita una volta per tutte (cosi come il Nobel a Fo spense definitivamente le ambizioni di Luzi e di altri italiani). Il talento di Roth è lì nei suoi romanzi, tanti, pubblicati dagli editori più famosi, tradotti in tutte le lingue.
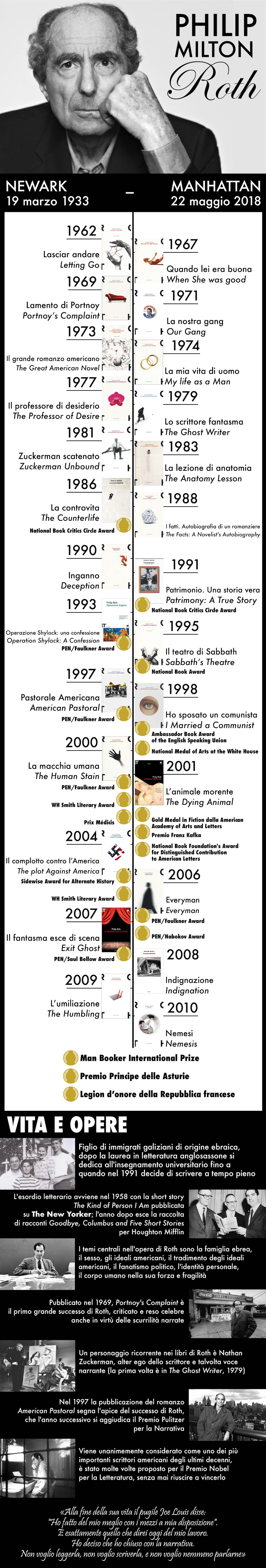
Roth ha scritto quasi fino all’ultimo; il suo ritiro dalla letteratura lo ha annunciato solo nel 2012, e anche questa decisione è stata molto commentata. In genere sono solo i grandi che decidono volontariamente di ritirarsi dalle scene, imbattuti, per usare la stessa metafora pugilistica adoperata dallo scrittore.
Roth, di Newark, New Jersey, ha dato voce ad un sentire diffuso. Raccontando la sua vita interiore e le sue esperienze di maschio bianco, ebreo-americano, di classe media, incline alla vita intellettuale e all’eros, ha costruito una galleria di specchi in cui moltissimi uomini e moltissime donne si sono guardati, e riconosciuti. Il tipo del borghese colto americano come modello idealtipico dell’occidentale contemporaneo? Guardando a Roth si direbbe di sì.
Roth ha messo d’accordo quasi tutti. La sua insistenza sui temi del sesso, fin dai tempi del Lamento di Portnoy, può avere disturbato qualcuno. Ma in definitiva la sua opera non è incorsa nelle spirali della censura e della pubblica esecrazione (come quella di un Henry Miller, per esempio). Vi sarebbe da riflettere sul perché. Forse perché in Roth non si percepisce una presa di posizione per così dire “ideologica” (quella che vediamo in filigrana, ad esempio, in Ultimo tango a Parigi di Bertolucci). Roth è stato un faro della cultura liberal ma non ha aderito ad alcuna moda culturale. Nel suo capolavoro, Pastorale americana, non parteggia per la giovane terrorista che uccide in nome di una nobile causa, il no alla guerra del Vietnam, e che poi abbraccia il radicalismo religioso orientale. Né simpatizza con l’humus culturale che ha favorito certe scelte. Roth sta dalla parte del dubbio, dello scetticismo e del dolore, anche se controbilanciati dall’esuberanza sessuale, dall’intelligenza pronta, da un’ironia che può trasformarsi in cinismo.
A volte Roth è stato accusato, secondo me a ragione, di essere un po’ monocorde, nei temi trattati così come nei suoi personaggi. Roth non è (stato) Safran Foer e forse neanche Malamud. Ma quello che doveva dire lo ha detto bene. Roth è stato quella voce che ci parla dall’altra parte del tavolo, in un bar notturno, non una bettola e nemmeno un club esclusivo. Un locale medio, frequentato da scrittori, professori universitari, quadri dirigenti, uomini e donne dalla vita apparentemente decorosa ma sempre sul punto di deragliare. Noi abbiamo ascoltato quella voce e continueremo a farlo, anche se a volte potremmo trovarla irritante. Ci incalza, ci diverte. Ci sorprende. A volte sembra proprio la nostra ma è lo scherzo che fanno i grandi, questo portarci ad esclamare: oh, god, l’ho pensato anch’io!












