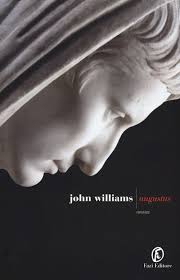 Luciano Canfora sul Corriere della Sera aveva stroncato questo libro perché, fra le altre cose, non rispetterebbe i canoni dell’epistolografia latina. Noi che invece abbiamo amato cose come il film della Coppola su Maria Antonietta, che faceva ballare la corte di Versailles sulle musiche della new wave anni 80, ci permettiamo di dire che la critica di Canfora è trascurabile e che “Augustus” di John Williams è un romanzo storico magnifico. Magnifico proprio per il suo essere cosa diversa da un testo storiografico, per la sua capacità di interpretare, rimodellare, se necessario tradire la verità storica. Non però per il puro piacere del gioco, né perseguendo l’estetica della contaminazione dei linguaggi. Williams non è un postmoderno, la sua intenzione è comunque quella di riportare un ritratto veritiero e comprensibile del grande imperatore romano e del suo tempo. Ma se per farlo deve ricorrere all’invenzione, bene, sta facendo solamente il suo mestiere di scrittore, e del resto, lo dichiara apertamente proprio in apertura: “Stando ad alcune fonti, un celebre storiografo latino dichiarò che avrebbe fatto vincere a Pompeo la battaglia di Farsalo, se gliel’avesse richiesto un bel giro di frase. Pur non essendomi concesso tanta libertà, alcuni errori contenuti in questo libro sono deliberati”. In ogni modo, si suppone che il lettore di un volume del genere, oltre 400 pagine, sia sufficientemente smaliziato: dopotutto, chi si accosta oggi a “La certosa di Parma” di Stendhal non lo fa prendendo per oro colato tutte le affermazioni contenute sulla presenza dei francesi a Milano all’epoca delle campagne napoleoniche.
Luciano Canfora sul Corriere della Sera aveva stroncato questo libro perché, fra le altre cose, non rispetterebbe i canoni dell’epistolografia latina. Noi che invece abbiamo amato cose come il film della Coppola su Maria Antonietta, che faceva ballare la corte di Versailles sulle musiche della new wave anni 80, ci permettiamo di dire che la critica di Canfora è trascurabile e che “Augustus” di John Williams è un romanzo storico magnifico. Magnifico proprio per il suo essere cosa diversa da un testo storiografico, per la sua capacità di interpretare, rimodellare, se necessario tradire la verità storica. Non però per il puro piacere del gioco, né perseguendo l’estetica della contaminazione dei linguaggi. Williams non è un postmoderno, la sua intenzione è comunque quella di riportare un ritratto veritiero e comprensibile del grande imperatore romano e del suo tempo. Ma se per farlo deve ricorrere all’invenzione, bene, sta facendo solamente il suo mestiere di scrittore, e del resto, lo dichiara apertamente proprio in apertura: “Stando ad alcune fonti, un celebre storiografo latino dichiarò che avrebbe fatto vincere a Pompeo la battaglia di Farsalo, se gliel’avesse richiesto un bel giro di frase. Pur non essendomi concesso tanta libertà, alcuni errori contenuti in questo libro sono deliberati”. In ogni modo, si suppone che il lettore di un volume del genere, oltre 400 pagine, sia sufficientemente smaliziato: dopotutto, chi si accosta oggi a “La certosa di Parma” di Stendhal non lo fa prendendo per oro colato tutte le affermazioni contenute sulla presenza dei francesi a Milano all’epoca delle campagne napoleoniche.

“Augustus” venne pubblicato all’inizio degli anni 70. Nel 1973 vinse il National book award, uno dei più importanti premi letterari negli Usa. In Italia era già uscito per Castelvecchi alcuni anni fa (è a quell’epoca che risale appunto il giudizio severo di Canfora) ma ora Fazi lo ha ridato alle stampe con una nuova traduzione. L’autore, classe 1922, ha vissuto quasi tutta la vita in America, a Denver, dove ha anche insegnato letteratura inglese all’università del Missouri e dove è morto nel 1994. La cosa più sorprendente però non è che un autore statunitense sia riuscito a restituire un ritratto così vivo e coinvolgente della Roma antica, ma che a farlo sia stato lo stesso autore di “Stoner”, uno dei successi letterari del 2012, quando quel romanzo, uscito negli anni 60, è stato riscoperto. “Stoner”, apparentemente, si colloca agli antipodi rispetto ad “Augustus”: racconta la vita in chiave minore di un oscuro professore universitario, una sorta di uomo senza qualità in terra americana, anche se personalmente non ho mai visto in lui la quintessenza del perdente (la cifra di quel romanzo è lo stoicismo, l’oggetto la vita stessa, con le sue sconfitte e le sue – modeste, sì – rivincite, perlopiù tardive e, questo lo concedo, tutt’altro che catartiche).
Insomma, avete capito: il libro che ha rilanciato Williams, autore peraltro non prolifico (solo 4 romanzi pubblicati nel corso della sua vita più un quinto incompiuto) è dedicato ad un’esistenza in sordina, che molti non esisterebbero a definire “grigia”. Di tutt’altro genere quella di Cesare Ottaviano Augusto, nipote di Giulio Cesare, che a soli 18 anni ereditò – non senza complicazioni – un potere enorme, con tutto il suo carico di responsabilità. Eppure la stranezza è solo apparentemente. Addentrandosi nella lettura, si ritrova in “Augustus” la stessa capacità di indagare la natura umana che è servita a raccontare la vita di un intellettuale timido inchiodato ad un’università “minore”. Cambia, invece, il registro. Qui è quello del romanzo polifonico, composto in gran parte da epistole e frammenti di diari scritti dalle persone che, per motivi diversi, hanno vissuto accanto ad Augusto. Alcuni, come il generale Marco Agrippa o il poeta (e sottile Metternick dell’antica Roma) Mecenate, non così noti al grande pubblico, nonostante il ruolo che ebbero a fianco dell’imperatore fin dall’inizio del suo cammino. Altri, come Cleopatra, la regina d’Egitto, che si schierò con Marco Antonio e al pari di quest’ultimo si diede la morte dopo la sconfitta patita ad Anzio, conosciutissimi. Le vicende di Augusto, quelle pubbliche – le sue imprese militari, le sue alleanze, spesso mutate a seconda delle circostanze – e quelle private – il suo intrattenersi con i grandi letterati dell’epoca, come Virgilio o Ovidio, il suo accompagnarsi anche a donne diverse dalla moglie Livia e così via – vivono tutte nelle corrispondenze e nei ricordi di chi ebbe modo di conoscerlo. Augusto di suo parla solo alla fine, in una lunga lettera scritta a Nicola di Damasco nell’agosto dell’anno 14 d.C. durante un ultimo breve viaggio per mare alla volta dell’isola di Capri. Di tutte le voci che compongono quest’opera di facile lettura, nonostante la mole (di facile lettura perché quasi sempre appassionante), spicca senz’altro quella di Giulia, figlia di Augusto e tre volte sposa, sempre per ragioni di Stato, dnna complessa, sensuale, attirata dai culti orgiastici che ebbe modo di conoscere in Grecia viaggiando al seguito del secondo marito, Agrippa, poi protagonista della “vita mondana” (la più licenziosa) di Roma e infine coinvolta in un complotto contro il padre, reale o presunto che fosse. Ma indimenticabili risultano anche i cambi di barricata di Cicerone, l’orgoglio ingenuo di Salvidenio Rufo, la testimonianza di Irzia, serva in casa di Augusto, che rivede il suo “Tavio” dopo 50 anni, al foro.
Ho già detto nelle mie classifiche di fine anno che alcuni dei libri più interessanti usciti ultimamente hanno a che fare con la storia. Anche quando, come nel caso di “Lincoln nel bardo”, essa è realmente manipolata e riplasmata per porsi al servizio della poetica dell’autore. Nel libro di Williams la cifra è il realismo, con le eccezioni che prima ricordavano e che potremmo ricondurre alla definizione “licenza letteraria”. Ma a volte fa capolino anche qualcosa di più. Così come in “Stoner” è impossibile non chiedersi quando l’autore parlasse di se stesso, essendo a sua volta un docente universitario, così qui è difficile non domandarsi ad esempio quante delle riflessioni sulla letteratura di Augusto o di altri personaggi del romanzo non siano in realtà meditazioni personali che Williams ha loro affidato. In ogni modo, niente risulta pretestuoso. E niente risulta vecchio, sorpassato, agli occhi del lettore odierno. Anzi, forse questa discesa nelle vicende di un grande uomo di stato, nonché nei mutevoli panorami politici del suo tempo (restituiti al lettore in ordine non strettamente cronologico) può risultare persino più appassionante oggi di allora. Beninteso: non che oggi vi sia un Augusto, all’orizzonte. Né in America, né in Italia.
Johnson Williams, Augustus, Fazio editore, 2017 (traduzione di Stefano Tummolini).
Prima edizione americana: 1971.












