Il giorno dopo l’attentato di Manchester, era previsto nella mia città – Trento – un incontro con Tariq Ramadan, il più famoso (e contestato) intellettuale musulmano, docente di islamistica ad Oxford, classificato dal Time Magazine una delle 7 teste pensanti più influenti al mondo, ma anche l’uomo che ha convinto Cat Stevens a tornare a cantare (dopo la conversione all’Islam il cantautore aveva smesso di farlo, considerando contrario alla sua religione l’esibirsi per denaro).
Ramadan, cittadino svizzero, di origini egiziane, imparentato con uno dei fondatori del movimento dei Fratelli Musulmani, esponente di un Islam – anche – europeo, era atteso in città per presentare un libro scritto a due mani con Riccardo Mazzeo, Il musulmano e l’agnostico, edito dalla casa editrice Erickson. L’evento ha un gustoso retroscena: la presentazione in realtà doveva tenersi a Bolzano, ma all’ultimo momento il sindaco della città, incalzato dalle destre locali, si è detto contrario, e così il tutto è stato spostato a Trento, dove ha sede appunto la Erickson, e dove peraltro Ramadan era già venuto qualche mese fa senza suscitare alcun clamore. Dove sta il problema? Per chi non lo conoscesse, Tariq Ramadan, pur essendo fra l’altro consulente in diverse commissioni collegate al Parlamento europeo di Bruxelles, viene accusato periodicamente di varie cose: dall’antisemitismo alla vicinanza con alcune forme di radicalismo islamico (l’accusa più infamante è forse quella di non condannare la lapidazione delle adultere).
Alla fine, chi a Trento si attendeva scintille è rimasto deluso. All’ultimo momento, adducendo problemi di salute, Ramadan non si è presentato di persona, ma in videoconferenza. Tuttavia, la sua è stata una presenza “reale”. Più di un’ora di conversazione, prima un monologo su alcune questioni di carattere generale, poi un botta e risposta con il pubblico. Questo è quello che ne è uscito, e lo offriamo ai lettori della Voce di New York come spunto di riflessione. Con una premessa, che è poi quella fatta da Mazzeo, l’agnostico del libro: riguardo al terrorismo (il tema non poteva non essere toccato viste le notizie che rimbalzavano in Italia da Manchester) non bisogna fermarsi al sintomo, ma ricercare le cause. Per Mazzeo jl problema non e l’Islam. I terroristi sono persone allo sbando. Il loro avvicinamento alla religione, specie nei suoi aspetti più radicali o distorti, è dovuto al fatto che non hanno alcun riferimento, né nella terra di origine (per l’attentatore di Manchester, nato in Inghilterra, la Libia) né in quella di accoglienza. Spesso i terroristi passano attraverso altre esperienze estreme, la droga, l’affiliazione ad una gang. La loro radicalizzazione non a caso a volte avviene in carcere.
Io penso ci sia del vero in quest’analisi, anche se non va dimenticato che esistono comunque delle centrali del terrore che cavalcano il disagio e lo spaesamento prodotti dalla globalizzazione. E queste hanno una loro specificità (se sono centrali del terrore islamiche non sono centrali del terrore “nero”, o “rosso”, e così via). Certo, alcuni di questi terroristi europei, probabilmente, se non fossero stati plagiati dall’Isis avrebbero trovato altro canali per sfogare la loro frustrazione. Non credo fosse molto diverso all’epoca delle nostre Brigate Rosse o dei nostri neofascisti, tolto lo “zoccolo duro” delle persone ideologicamente formate e motivate. Ed è in fondo come dice Lou Reed in quel brano bello e terribile che si intitola Street Hassle: “Certe persone non hanno scelta, e non riescono mai a trovare la voce per parlare, una voce che possano definire propria. Così, si aggrappano alla prima cosa che consente loro di continuare ad esistere. E questa si chiama: cattiva fortuna”.

Cosa ha detto Tariq Ramadan
Se qualcuno si aspettava un discorso polemico, è rimasto senz’altro deluso. Ramadan si è definito un musulmano di cultura pienamente occidentale, favorevole alla separazione fra religione e affari dello stato, quindi alla laicità. Ha parlato della necessità di dialogo, di confronto. Ha esortato i musulmani europei a non parlare sempre di Islam, di impegnarsi per le questioni importanti dei paesi in cui vivono, per la giustizia sociale, l’ambiente e così via. Si è detto contrario ad ogni razzismo e ad ogni dittatura. Ha glissato sul tema degli abiti delle donne, molto sentito in Europa, ma ha spezzato una lancia in favore delle pari opportunità fra uomini e donne, soprattutto in termini salariali. Un discorso, insomma, non dissimile da quelli che ho sentito fare tante volte da altri alfieri del dialogo interreligioso, anche cristiani o cattolici. Forse l’unico punto di incomprensione può essere dovuto al fatto che Ramadan parte dai testi, parte dalla religione islamica, pur opponendosi ad una interpretazione che definisce “letteralista” (usato come sinonimo del nostro “integralista”). Riguardo al velo totale, ad esempio, sostiene che sarebbe più efficace fare un lavoro culturale nelle comunità islamiche, spiegando che il “vero Islam” non lo prevede, piuttosto che vietarlo per legge, cosa che costringerebbe tante donne a rimanere chiuse in casa. Un occidentale potrebbe dire che è bene fare entrambe le cose, ma, in definitiva, questi sono dettagli. Non piccoli, ma neanche insormontabili.
Ecco di seguito alcune “pillole” del suo discorso, riportate in maniera quanto più fedele possibile.
Nel mondo musulmano come in occidente dobbiamo tornare all’interpretazione delle fonti, delle origini. Il lavoro consiste nel tornare alle radici per capire le sfide del presente.
Come musulmani abbiamo molte sfide da affrontare. La prima è l’ipertrofia della regola. A volte l’enfasi sulla regola inaridisce la dimensione religiosa.
La seconda è culturale: nelle società musulmane c’è un deficit educativo, un deficit di cultura e una mancanza di creatività. Ad esempio, i libri editi in lingua araba sono una percentuale veramente minoritaria.
C’è la questione della libertà della donna: Io faccio parte di coloro che da trent’anni si battono per la libertà della donna. Se una donna ha le stesse competenze e lo stesso profilo professionale deve avere anche diritto allo stesso stipendio. Non mi interessano particolarmente le polemiche sull’abbigliamento. Credo che il salario sia la chiave dell’autonomia.
Abbiamo poi il problema del razzismo. Vediamo arabi contrapporsi agli asiatici o agli africani. O che mescolano antisemitismo e critica a Israele. L’antisemitismo è anti islamico. Non può mai essere giustificato. Come nessun’altra forma di razzismo. Ma è giusto criticare gli stati e le loro politiche, come ad esempio io faccio con l’Arabia Saudita, che mi ha dichiarato persona non gradita.
Le contestazioni di Bolzano su cosa si sono basate? Sulla diffidenza, sulla paura e sulla non-fiducia. Se vogliamo vivere assieme, coesistere, bisogna che ci impegniamo in un dialogo di sostanza e non di facciata.
Quello che vorrei come cittadino europeo è continuare a battermi per una maggiore giustizia sociale. Non voglio privilegi ma uguaglianza davanti alla legge per i musulmani. Vorrei che ci aprissimo ad un vero, reale pluralismo. Io sono di religione musulmana ma tutta la mia cultura e conoscenza è europea e occidentale.
Dobbiamo rispondere alla paura con la rivoluzione della fiducia. Musulmani con atei, agnostici, ebrei, cristiani ecc. Abbiamo tutti qualcosa da dire specie sulla questione della giustizia sociale, sulle pari opportunità, sull’uguaglianza davanti alla legge.
So che non posso piacere a tutti, ma sarò sempre accanto agli oppressi e se il dittatore sarà musulmano io sarò contro quel dittatore. E se il boia che tortura e affama gli oppressi è africano sarò contro l’africano, se sarà americano sarò contro l’americano. E cosi via. Nella mia vita penso di avere fatto una scelta, stare dalla parte della giustizia e dell’uguaglianza. Questo mi ha insegnato la mia spiritualità. Sono più vicino ad alcune idee di Riccardo (Mazzeo) che è un agnostico rispetto a quelle di alcuni musulmani. Gli assassini di Manchester sono esseri indegni.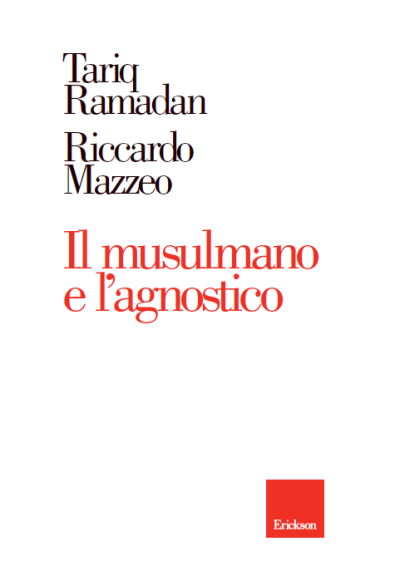
Laicità: ci sono diversi approcci alla questione. La corrente letteralista, presente ad esempio in Arabia Saudita, che dice che non c’e alcuna differenza fra stato e religione. Ma c’e anche un‘antica tradizione che parla di separazione netta fra dio e l’organizzazione della società. Essa dice, come ripetuto dal Corano, che i musulmani devono gestire i loro affari “nella deliberazione”, e quindi con un processo maggioritario. Viene sancita in questo caso la separazione fra l’autorità dello stato e quella religiosa. Ho detto e scritto che non c’e nulla nell’Islam che si opponga a questa separazione.
Sono impegnato nel dialogo intereligioso da 25 anni. Il problema è che partecipano sempre le stesse persone. Bisogna coinvolgere fasce sempre più ampie della società. Uno dei problemi che ho riscontrato non è che gli europei non conoscono l’Islam. Semmai molti europei non sanno quasi niente del cristianesimo.
Abbigliamento: io non credo che il velo integrale sia un obbligo previsto dalla religione. Possiamo scegliere: o proibirlo oppure impegnarci per una migliore interpretazione dell’Islam e per una migliore conoscenza di queste regole. Il problema è che proibendolo otterremo che le donne dovranno rimanere a casa e non potranno mostrarsi in pubblico. E non potremmo proibirlo in assoluto perche donne arabe ricche che vengono in Europa per turismo non vengono mai disturbate. Abbiamo proibito il velo nelle banlieue parigine ma non negli Champs-Élysée perché lì le signore saudite fanno shopping. Secondo me bisogna fare un lavoro di sensibilizzazione ed educazione dicendo che il velo integrale è un abuso dei principi dell’Islam.
Così è, se vi pare, Tariq Ramadan, perlomeno in questa circostanza. Onore alla casa editrice Erickson che promuove questo genere di eventi (e di libri).











