Anche se parla del futuro, l’ultimo romanzo del newyorchese – di origini italiane – Don DeLillo, Zero K, è molto anni ’70. Elenchiamo qualche elemento un po’ alla rinfusa. Il tema dell’ibernazione (oggi si dice criogenesi), il catastrofismo, cioè l’imminente fine del mondo causata dai cambiamenti climatici o altra analoga disgrazia, oppure in alternativa da una guerra o attacco terroristico definitivo; l’ambientazione claustrofobica, in una base sotterranea ipertecnologica ma sempre “vintage”, lunghi corridoi, ascensori, schermi, ferritoie e ingressi a scomparsa, persino opere d’arte concettuali, in genere di contenuto feroce o quantomeno inquietante, seminate ambiguamente qui e là come in un film di Jodorowsky (manichini, video, installazioni).
Sembrerebbe di essere dalle parti di uno di quei libri pubblicati in Italia nella collana Urania, ad esempio Livello 7 di Mordecai Roshwald, solo che là la gente si rifugia sottoterra a causa dell’atomica (il romanzo di Roshwald è stato scritto addirittura nel 1959, in effetti, ma in Italia arrivò più tardi).
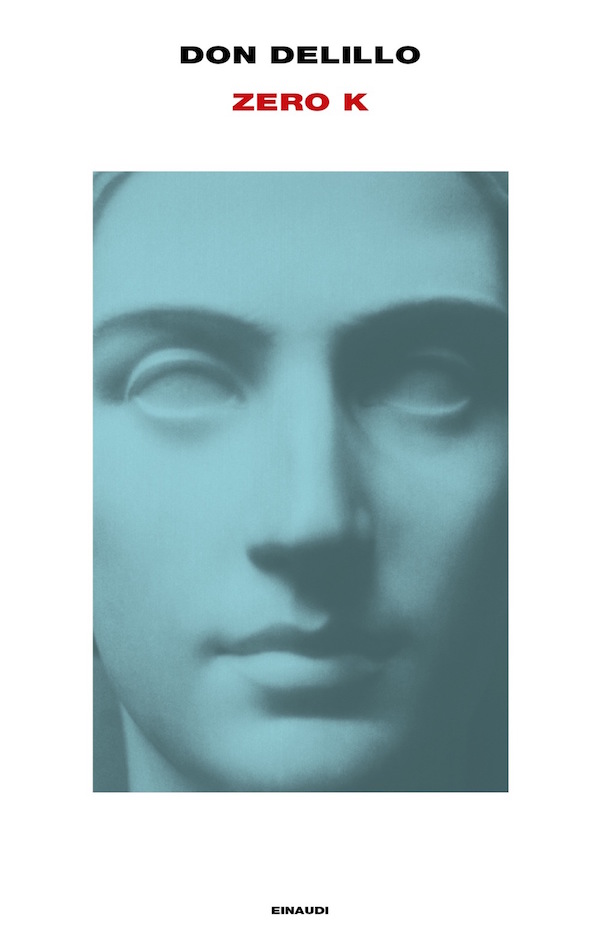 L’io narrante, Jeffrey Lockhart, giunge a Convergence, centro criogenico futurista nel cuore del nulla, su invito del padre Ross, un magnate della finanza. Ross è uno dei finanziatori della struttura, dove ha ricoverato la seconda moglie, malata terminale, al fine di congelarla, e darle una chance di rinascita. Il cuore della storia è qui, anche se c’è una seconda parte del romanzo che ci porta a New York e altrove.
L’io narrante, Jeffrey Lockhart, giunge a Convergence, centro criogenico futurista nel cuore del nulla, su invito del padre Ross, un magnate della finanza. Ross è uno dei finanziatori della struttura, dove ha ricoverato la seconda moglie, malata terminale, al fine di congelarla, e darle una chance di rinascita. Il cuore della storia è qui, anche se c’è una seconda parte del romanzo che ci porta a New York e altrove.
Situazioni e dialoghi virano sul filosofico, cosa inevitabile, immagino, quando si racconta di morte in uno spazio chiuso. Ma non sono esenti da una certa pretenziosità, ovvero dalla presunzione di evocare temi profondi con frasi ad effetto e situazioni caratterizzate da lunghi momenti di silenzio in cui i protagonisti bevono qualcosa o si voltano per constatare che la persona che li accompagnava è scomparsa all’improvviso, lasciandoli attoniti. Prendo un virgolettato a caso: “È una fuga dalla nostra personale mortalità. Dalla catastrofe. Qualcosa che sconvolge tutte le debolezze e le paure nel nostro corpo e nella nostra mente. Fronteggiamo la fine, ma non siamo soli. Ci perdiamo nell’occhio del ciclone”. Andiamo: se lo trovaste in un manoscritto anonimo, pensereste ad un esordiente che ce la mette tutta per mirare in alto, ma non ci arriva.
 DeLillo è considerato un maestro della narrativa e la sua fama è meritata anche se i suoi romanzi, compreso Rumore bianco, non sono esenti da imperfezioni e alcuni, come L’uomo che cade, mancano clamorosamente il bersaglio. C’è però un suo lavoro che svetta su tutti e rimane uno dei romanzi topici di fine XX secolo-inizio XXI: parlo ovviamente di Underworld. Lì, vuoi per lo scardinamento della consecutio (si salta senza soluzione di continuità da un’epoca all’altra, pur rimanendo entro il perimetro della seconda metà del ‘900), vuoi perché l’autore riesce a tenere a freno la sua tendenza alla deriva mistico-tecnologica, si raggiunge la perfezione.
DeLillo è considerato un maestro della narrativa e la sua fama è meritata anche se i suoi romanzi, compreso Rumore bianco, non sono esenti da imperfezioni e alcuni, come L’uomo che cade, mancano clamorosamente il bersaglio. C’è però un suo lavoro che svetta su tutti e rimane uno dei romanzi topici di fine XX secolo-inizio XXI: parlo ovviamente di Underworld. Lì, vuoi per lo scardinamento della consecutio (si salta senza soluzione di continuità da un’epoca all’altra, pur rimanendo entro il perimetro della seconda metà del ‘900), vuoi perché l’autore riesce a tenere a freno la sua tendenza alla deriva mistico-tecnologica, si raggiunge la perfezione.
Qui no, anche se l’ambientazione del romanzo riprende proprio la parte finale di Underworld: là avevamo un bunker sotterraneo in Asia centrale da dove i protagonisti, stravolti dal fuso orario, osservavano le atomiche sovietiche che venivano fatte detonare, ovvero la frontiera più avanzata dello smaltimento rifiuti. Qui abbiamo una cittadella sotterranea in Asia centrale dove il protagonista, stravolto dal fuso orario, cerca di farsi una ragione delle scelte del padre e al tempo stesso di decifrare la natura del luogo e dei suoi abitanti, un po’ scienziati, un po’ setta.
Su e giù per i vari livelli di questa struttura complessa e semivuota, circondata da imponenti misure di sicurezza ma il cui ingresso è presidiato da due sole guardie armate, compaiono e scompaiono strani, enigmatici personaggi. Il visitatore, deambulando fra un corridoio e una sala conferenze, a volte si intrattiene con loro (una gli si infila addirittura nel letto, non si sa bene perché), altre volte si perde nei meandri della sua stessa memoria, rispolverando tematiche che DeLillo ha già affrontato altre volte: il rapporto genitori-figli, la vecchiaia e la malattia, e naturalmente lo stato allucinatorio generato dallo stare rinchiusi in un luogo impermeabilizzato rispetto al mondo esterno, sia esso un’automobile o un appartamento del Village, in Great Jones Street.
Può sembrare solenne, può sembrare profetico, specie a chi non ha dimestichezza con la fantascienza. Chi scrive pensa che sul tema della ricerca dell’immortalità sia stato fatto di meglio con meno sforzo e meno prosopopea: ad esempio, tanto per dire un nome, da Hanif Kureishi, con uno splendido racconto lungo intitolato Il corpo; oppure, tanto per dirne un altro, questa volta appartenente al cinema, da Tarkovskij, con Solaris.
Don DeLillo, Zero K, Einaudi, 2016, traduzione di Federica Aceto (negli Usa il romanzo è stato pubblicato da Simon & Schuster).












