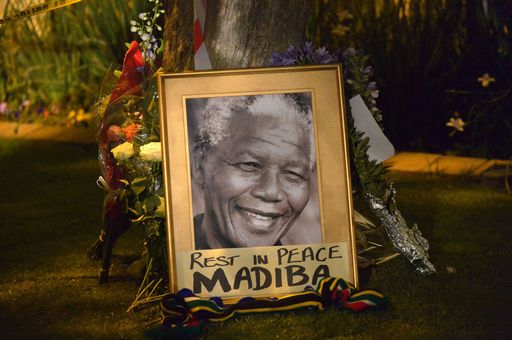Si chiude oggi, con la sepoltura tra gli Xhosa del Transkei, il ciclo storico del primo presidente nero del Sud Africa. Passato il clamore delle celebrazioni ufficiali, è possibile una riflessione non emotiva sulla questione centrale della sua vita politica: Mandela fu vero uomo di pace? E più in generale, si può lottare contro l’oppressione senza mezzi violenti?
Parlando ai funerali di Soweto (vedi video sopra), Obama ha correttamente accostato lo scomparso presidente a Gandhi e Martin Luther King, come campioni del metodo di lotta politica che, rifiutando la violenza, ha liberato tre grandi paesi dall’oppressione di una minoranza. Obama avrebbe potuto precisare che le tre icone del XX secolo hanno praticato in modo diverso l’opzione non violenta. Perché diverse erano le condizioni culturali di partenza e le condizioni materiali della lotta, diversa la capacità di reazione delle società nelle quali si erano trovati ad operare. Se King fu adamantino nella coerenza con la scelta non violenta e Gandhi evitò la violenza fisica senza rinunciare ad altre forme di uso della forza, Mandela dalla violenza si lasciò sedurre prima di apprendere a padroneggiarla e rifiutarla. Fu un percorso difficile e complesso, la cui tappa finale gli avrebbe meritato il titolo di padre della “patria arcobaleno” e il premio Gandhi/Luther King della non violenza, consegnatogli nel 1999 dalla nipote di Mohandas Gandhi.
Mandela accetta la violenza nazionalista e antirazzista, dopo la messa al bando dell’African National Congress, Anc, nel 1960: fonda “Umkhoto we Size” (la lancia di ferro della nazione), come braccio armato d’Anc, e ne diviene il comandante in capo. Esplodono bombe in centri commerciali e altri luoghi pubblici, ma senza spargimento di sangue. La tecnica preferita è il boicottaggio, unito a scioperi e marce. Il futuro presidente firma un piano che prevede, per costringere alla rimozione del regime di apartheid, il passaggio graduale alla guerriglia e alla lotta armata. Vi è, nella decisione, la frustrazione di una lotta civile che non ha condotto a risultati tangibili e guarda agli atti esemplari contro i simboli del regime (tribunali, caserme, uffici dei passaporti interni, corte di giustizia per i nativi) come all’ultima risorsa contro l’ingiustizia. Mandela studia Clausewitz, Mao, Guevara, gli specialisti della Seconda guerra dei Boeri, soggiornando in Algeria nel 1962, prima dell’arresto, per ricevervi addestramento militare. Sono 190, tra il 1961 e il 1963, le azioni di boicottaggio armato. A Washington l’Anc è classificata come organizzazione terroristica; Mandela e i capi dell’Anc sono banditi dagli Stati Uniti.
Guerriglia, terrorismo, insorgenza rivoluzionaria (sconfessando la componente comunista del movimento anti-apartheid) vengono presto scartate perché l’obiettivo è costruire per ogni sud africano senza distinzione di gruppi, ideologia, colore, una società di diritto fondata sulla giustizia tra neri (75% Zoulou, Xhosa, Sotho, Tszwana, Ndebele), bianchi d’origine europea, asiatici e meticci (10%). Si lotta per tutti i sud africani non per i neri. In Long Walk to Freedom, del 1994, Mandela racconterà le riflessioni che, nei quasi tre decenni di prigione, lo portano alla definitiva scelta non violenta e al rifiuto della vendetta contro l’oppressore bianco. La sua inattaccabile statura morale lo imporrà come Nobel per la pace insieme all’ultimo presidente razzista sud africano de Klerk, convertito dal grande spirito dell’avversario. Non bisogna chiedersi tanto perché il primo Mandela non avesse respinto la violenza, ma piuttosto quanto fosse violento il regime che lo costrinse a dubitare dell’opportunità di quella scelta rispetto al fine della pacificazione generale.