Il lettore si segni questo nome: Cesare Terranova. E’ il nome di una persona uccisa in anni lontani; il suo ricordo, come quello di tanti, si scolora nella memoria. Cesare Terranova, la prendo alla lontana, contraddice la tesi che cercherò di esporre e di cui sono alfiere convinto e disinteressato (non sono magistrato, avvocato, non sono – per il momento, almeno – impigliato in alcuna vicenda che abbia a che fare con tribunali, codici, amministrazione della giustizia).
Terranova, dunque. Palermo: il 25 settembre del 1979, verso le 8,30 del mattino, una Fiat 131 arriva sotto casa del giudice, per condurlo in ufficio. Il magistrato si pone alla guida; accanto a lui il maresciallo Lenin Mancuso. Terranova imbocca una strada secondaria: chiusa per “lavori in corso” che nessuno ha previsto e segnalato. Ecco che sbucano dei killer della Cosa Nostra, fanno fuoco con una carabina Winchester e con delle pistole. Terranova tenta una manovra di retromarcia; il maresciallo Mancuso impugna la Beretta di ordinanza. Niente da fare: il giudice viene massacrato, Mancuso muore in ospedale dopo qualche ora.
Un delitto “eccellente”, come s’usa dire. Terranova e Leonardo Sciascia si frequentavano, erano amici. Lo scrittore si interroga sul perché di quel delitto. Ipotizza. “Stava occupandosi di qualcosa per cui qualcuno ha sentito incombente o immediato il pericolo”. Anni dopo Tommaso Buscetta racconta a Giovanni Falcone, che Terranova è stato ucciso su mandato di Luciano Liggio; era “un obiettivo” fin dal 1975. Liggio ne vuole la morte per vendicarsi della sentenza della condanna all’ergastolo subita; ma non solo: ci sono anche gli “affari”. Terranova per qualche anno aveva deposto la toga del magistrato, ed era stato eletto come indipendente in Parlamento dall’allora Partito comunista. “Naturalmente” era diventato componente della Commissione parlamentare antimafia, mostrandosi troppo determinato nella lotta alla Cosa Nostra. Infine, una terza ragione: aveva deciso di non candidarsi più, era tornato in magistratura, e proprio a Palermo: in corsa per diventare capo dell’Ufficio Istruzione, dal quale avrebbe “perseguito con forza la strategia di recidere le trame tra la Cosa Nostra e la politica, obiettivo che contraddistingue sempre il suo operato, sia da magistrato che da politico”. Da questo punto di vista, un “omicidio preventivo“; a vederla con gli occhi dei mafiosi, pienamente giustificato.
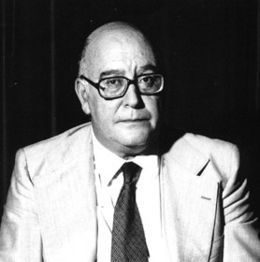
Il lettore abbia ancora un attimo di pazienza. Palermitano purosangue Terranova entra in magistratura nel 1946, appena tornato dalla guerra e dalla prigionia. Pretore a Messina. Nel 1958 si trasferisce dal Tribunale di Patti, poi a quello di Palermo: avvia i celebri processi nei confronti di Liggio e altri boss. Eletto deputato, in Commissione antimafia si distingue per impegno, intuito e professionalità, forte dell’esperienza accumulata come magistrato. Sono anche gli anni che vedono annullate alcune sentenze di condanna ai pericolosi appartenenti alla Cosa Nostra. Molti boss vengono lierati. Terminato il mandato parlamentare nel 1979, Terranova decide di tornare “a Palermo per terminare il lavoro cominciato“. Il 10 luglio, il Consiglio Superiore lo nomina Consigliere della Corte di Appello; scelta “transitoria”, lo sanno tutti. E’ scontato che entro breve tempo sarà alla guida dell’Ufficio Istruzione: per prestigio, anzianità, merito, competenza. Ecco dunque il delitto “preventivo”.
Terranova coglie la metamorfosi mafiosa, quella raccontata da Sciascia nei suoi romanzi: da agricola a imprenditrice, l’edilizia, e il traffico di droga. Terranova negli interventi e nei suoi scritti sollecita “leggi adeguate, polizia efficiente, giudici sereni” quali strumenti indispensabili nella lotta contro le mafie: “La mafia…è criminalità organizzata, efficiente e pericolosa, articolata in gruppi o famiglie e non c’è una mafia buona o cattiva perché la mafia è una sola ed è associazione per delinquere. E, tuttavia, è cosa diversa dalla comune delinquenza: è, per dirla come Leonardo Sciascia, un’associazione segreta che si pone come intermediazione parassitaria fra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato, con fini di arricchimento per i propri associati“.
Assassinato, scrive Sciascia nella prefazione a “Il coraggio e il candore di un giudice”, nella certezza che a Palermo “nell’amministrazione della giustizia, vi sarebbe stato un nemico accorto e implacabile della mafia; e, per di più, un nemico che, attraverso l’esperienza di membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla mafia, aveva acquisito una visione del fenomeno in tutta la sua complessità, in ogni sua diramazione…Ma per essere stato implacabile e acuto nemico della mafia, Terranova sarà sempre ricordato. O almeno fin tanto che in questo nostro paese ci saranno «dignitose coscienze e nette». Ma qui ed ora io voglio anche ricordare il suo essere giudice non solo nell’accusare e nel colpire ma anche nell’assolvere, nel liberare”.
Questa, in sintesi, la storia di Terranova. Oggi si direbbe parte lui pure, di quel fenomeno che con legittime punte di spregio si suol definire “delle porte girevoli”? Si badi; fenomeno deprecabilissimo agli occhi di scrive questa nota; ma antico.
I più avvertiti (chi questa “avvertenza” la volevano e sapevano cogliere), non avevano bisogno di attendere la fragorosa esplosione di casi sconcertanti come quello incarnato dall’ex magistrato Luca Palamara. Da tempo si sapeva cosa accadeva nelle stanze, nei corridoi e negli anfratti del Consiglio Superiore della Magistratura, e nei loro dintorni e appendici.

A scorrere gli annali delle varie legislature, sono una quantità i magistrati “entrati” e “usciti” in politica e che hanno fatto politica. Un presidente della Repubblica (che in verità in quanto magistrato ha operato molto poco), Oscar Luigi Scalfaro il 29 gennaio 2012 così viene ricordato dall’Associazione Nazionale dei Magistrati: “…Con voce flebile ma ferma seppe però trasmetterci tutto l’attaccamento che ancora conservava per la magistratura italiana. Ricordava con dovizia di particolari il suo inizio di carriera di magistrato risalente all’ottobre del 1942, i casi giudiziari da lui trattati e l’attaccamento alla toga che diceva di sentire ancora cucita addosso come avvenuto durante tutta la sua fulgida esperienza politica…”. Tantissimi i magistrati candidati, eletti, alla Camera dei Deputati, al Senato, ai consigli regionali, comunali; e senza distinzione di “colore”: destra, centro, sinistra, ogni partito ha fatto carte false per accaparrarseli: Claudio Vitalone, Luciano Violante, Anna Finocchiaro, Stefano Dambruoso, Silvia Della Monica, Tiziana Parenti, Antonio Di Pietro, Cosimo Ferri, Enrico Ferri, Michele Emiliano, Giuseppe Ayala, Pietro Grasso, Giacomo Caliendo, Roberto Centaro, Francesco Nitto Palma, Gianrico Carofiglio, Felice Casson, Gerardo D’Ambrosio, Franco Frattini, Alfredo Mantovano, Alfonso Papa, Donatella Ferranti, Lanfranco Tenaglia, Doris Lo Moro, Antonio Di Pietro, Federico Palomba, Luigi de Magistris, Gianfranco Amendola, Ferdinando Imposimato, Carlo Palermo… Sono solo i primi nomi che vengono in mente, tantissimi altri si “perdono”…
In astratto si può accogliere l’obiezione: sono cittadini come tutti, titolari di opinioni e della possibilità di esprimerle, manifestarle. Chi lo dice però a questo punto si ricordi anche dei doveri: quando sbagliano devono pagare; e fare carriera per merito. Ad ogni modo al magistrato non si chiede solo di essere obiettivo e credibile: si chiede anche di appare tali: la moglie di Cesare non solo doveva essere onesta; non doveva dare adito ad alcun sospetto.
Da questo punto di vista, c’è davvero tanto da fare; e sarebbe il caso di finirla con stanche giaculatorie: quella del fare attenzione a non gettare con l’acqua sporca il bambino; e l’altra: una mela guasta non pregiudica l’intero raccolto. La quotidiana cronaca dimostra purtroppo che nel cesto le mele sane sono una minoranza. E’ necessaria una profonda, incisiva opera di disinfestazione.

La riforma predisposta dal ministro della Giustizia Marta Cartabia costituisce un primo inizio: un primo sillabare di un discorso ancora tutto da pronunciare; per di più il Governo ha fatto proprie le linee guida della annunciata riforma, ma poi si rimette – come è giusto – alla volontà del Parlamento. Stante la situazione politica, con un Governo che è la sintesi di tante anime una in conflitto e contraddizione con l’altra (si pensi alle opposte pulsioni di Forza Italia, Italia Viva e Movimento 5 Stelle), quel tipo di compromesso era ed è l’unico possibile: un primo passo di un cammino che sarà lungo, faticoso, accidentato. L’inizio di una delle tante riforme necessarie e urgenti.
Alcuni dati possono chiarire il livello a cui si è arrivati, in Italia, nell’amministrare la giustizia: quasi il 64 per cento dei procedimenti che escono dalle Procure dopo la fine delle indagini preliminari non va a giudizio: viene archiviato. Quel 64 per cento corrisponde a circa 430mila fascicoli. Non finisce qui. Ci sono poi le assoluzioni in primo grado: 46 per cento circa. Superano il milione l’anno i procedimenti iscritti nelle Procure e altrettanti sono avviati in Tribunale, ma la grande maggioranza rischia di “inutilmente” impegnare gli uffici e gravare su chi è sottoposto a processo. Per una quota rilevante di notizie di reato, è proprio il Pubblico Ministero a chiedere l’archiviazione, che in genere viene in genere accolta: nel 2020-2021 sono stati emessi circa 430mila decreti di archiviazione su disposizione dell’ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari e del Giudice per l’Udienza Preliminare; per contro, i rinvii al giudice del dibattimento sono stati circa 81mila. Nell’ultimo anno giudiziario, il 54,8 per cento dei processi definiti nel giudizio ordinario si è concluso con un’assoluzione. Il 90 per cento delle ingiuste detenzioni non viene risarcito dallo Stato sulla base del presupposto che l’arrestato ha “contribuito” colposamente all’errore del giudice, avvalendosi, ad esempio, della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio. Una facoltà prevista del codice. Per poter fare domanda di risarcimento, poi, serve una sentenza definitiva di assoluzione. Se il reato si è prescritto prima, come capita spessissimo, il periodo trascorso in custodia cautelare è destinato a finire a tarallucci e vino.
Sono suonate come scudisciate, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso rivolto al Parlamento, dopo il giuramento per il suo secondo incarico: “I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l’Ordine giudiziario“.

Il Presidente Sergio Mattarella in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Superiore della Magistratura nella nuova composizione (Foto Quirinale.it)
Bene: quanti sono i magistrati chiamati a risarcire i propri errori? Dal 2010 al 2021 ci sono state solo otto condanne, con un solo magistrato chiamato a mettere mano al portafoglio. Cifra? 10mila euro. Per contro tra il 1992 e il 2020 sono state risarcite 29.452 persone per un totale che sfiora i 795 milioni di euro, una media di 27 milioni di euro all’anno. I maggiori “errori” giudiziari si consumano a Napoli; vengono poi Reggio Calabria, Roma, Bari, Catanzaro, Palermo, Lecce, Milano, Catania, Venezia. I sei referendum per una giustizia più giusta su cui, Corte Costituzionale permettendo, si voterà a primavera, servono anche per porgere un argine a tutto ciò.
E’ di tutta evidenza: il CSM non funziona, non assolve i delicati compiti assegnatigli dalla Costituzione. E’ luogo di contrattazione sfacciata tra correnti della magistratura e fazioni politiche, per carriere e conquista di postazioni di potere. Un “mercato” disgustoso. Come sanare questa mortifera infezione non è ben chiaro; improbabile che l’antidoto a questa “peste” possa essere trovato da questo Parlamento e forze politiche, che ne sono corresponsabili al pari di quanti li hanno preceduti.
Se la Corte Costituzionale darà il suo “OK” a primavera di potranno tenere sei referendum promossi da Partito Radicale e Lega: sei importanti questioni per una giustizia più giusta; si chiede, in sostanza, che il popolo italiano si possa esprimere su alcune questioni fondamentali che riguardano l’amministrazione della Giustizia in generale. Ove si potessero celebrare, e venissero accolte le tesi di chi propone i referendum, ecco che un bel passo nella giusta direzione verrebbe fatto.

Per tornare alla riforma Cartabia: almeno si pone un freno al fenomeno delle “porte girevoli”. E’ incredibile – eppure accade – che un magistrato si possa candidare a sindaco e presidente della regione dove ha esercitato la sua funzione – e resti ugualmente in magistratura; è incredibile che un magistrato si possa candidarsi a sindaco nella città dove ha operato, sia eletto consigliere comunale, e contemporaneamente faccia il magistrato… Sono incredibili (e tuttavia accadono), una quantità di episodi simili, ed è incredibile come tanti trovino la cosa “normale”; che siano sostenuti e appoggiati dai partiti a cui fanno riferimento… spesso gli stessi partiti che denunciano storture e mal funzionamento della macchina giudiziaria, e la perdita di credibilità della figura del magistrato.
Auguriamoci che almeno, e in tempi brevi, si scriva la parola “fine” a questo inqualificabile fenomeno delle “porte girevoli”. Anche se, come si è detto a inizio di questo articolo, ci sono state persone come Cesare Terranova, a cui occorre inchinarsi con rispetto.
Chiudiamo così, dunque: è un problema di norme, di leggi da elaborare in sostituzione delle esistenti; e poi da applicare; ma soprattutto il problema è di un “sentire” venuto meno. Quel “sentire” che si coglie nella lettera che il 1 marzo 1978 Terranova indirizza alla moglie Giovanna, e che può essere considerato il suo “testamento” morale:
“Ad onore dei miei genitori voglio ricordare che i principi che mi hanno guidato in tutta la vita sono frutto della educazione da loro ricevuta e che, se in qualche misura sono riuscito ad operare bene da uomo e da cittadino, ciò lo devo soprattutto agli insegnamenti e agli esempi costanti di mio padre e di mia madre, ai quali va la mia infinita gratitudine“.











