Prima della sua immatura quanto subitanea scomparsa, Filippo Di Forti ha mandato alle stampe un libro che si impone all’attenzione per contenuti ed onestà intellettuale. Edito da Solfanelli, Che cos’è questa crisi prende di petto la dimensione umana e sociale nella quale ci troviamo incapsulati da ormai un lustro, offrendone un’originale chiave di lettura, che sta alla larga dai luoghi comuni ai quali economisti e politici ci hanno abituato.
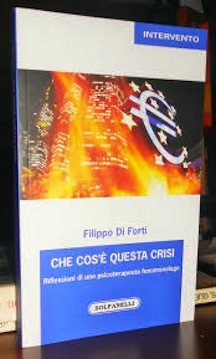 Di Forti, allievo di Cesare Musatti ed Emilio Servadio, espone la sintesi dei risultati ai quali è stato condotto dal percorso professionale di psicoterapeuta e dall’impegno civile, suggerendo atteggiamenti e comportamenti in grado di evitare al nostro paese il disastro generazionale al quale sembra inesorabilmente destinato. Per l’autore alla radice della crisi vi sono certo i vizi e la spregiudicatezza della finanza americana, purtroppo non adeguatamente contrastati da un’ingenua e quindi colpevole Europa. C’è, insieme, l’attacco concentrico al reddito dei ceti medi, da parte dei rapaci appetiti dei politici politicanti collusi con mafie e centri del malaffare finanziario globale. Ma, analizza l’autore, la tenaglia finanza/malapolitica ha potuto efficacemente stringersi sulle sue vittime e generare impoverimento e disoccupazione, perché ha trovato di fronte a sé popolazioni la cui soggettività era stata disinserita da consumismo e tecnologia, attraverso manipolazioni progressive verso “reificazione” (rendere le persone oggetto) e massificazione. Una crisi la cui natura, evidentemente, è culturale ed etica, oltre che economica, e che si è resa possibile, sempre nell’analisi dell’autore, nell’assenza di “buoni maestri e modelli di riferimento”.
Di Forti, allievo di Cesare Musatti ed Emilio Servadio, espone la sintesi dei risultati ai quali è stato condotto dal percorso professionale di psicoterapeuta e dall’impegno civile, suggerendo atteggiamenti e comportamenti in grado di evitare al nostro paese il disastro generazionale al quale sembra inesorabilmente destinato. Per l’autore alla radice della crisi vi sono certo i vizi e la spregiudicatezza della finanza americana, purtroppo non adeguatamente contrastati da un’ingenua e quindi colpevole Europa. C’è, insieme, l’attacco concentrico al reddito dei ceti medi, da parte dei rapaci appetiti dei politici politicanti collusi con mafie e centri del malaffare finanziario globale. Ma, analizza l’autore, la tenaglia finanza/malapolitica ha potuto efficacemente stringersi sulle sue vittime e generare impoverimento e disoccupazione, perché ha trovato di fronte a sé popolazioni la cui soggettività era stata disinserita da consumismo e tecnologia, attraverso manipolazioni progressive verso “reificazione” (rendere le persone oggetto) e massificazione. Una crisi la cui natura, evidentemente, è culturale ed etica, oltre che economica, e che si è resa possibile, sempre nell’analisi dell’autore, nell’assenza di “buoni maestri e modelli di riferimento”.
Guardando alla politica, l’autore sostiene che essa, invece di porsi come “honest broker” tra le varie esigenze, si è schierata decisamene dal lato della finanza, contro gli interessi di ceti medi (da spolpare per rifondere le perdite della finanza) e fasce di meno abbienti (non più assistiti, o meno assistiti, dal welfare). E’ una posizione oggi condivisa da larghe fette di elettorato, certamente in Spagna, Grecia, Polonia, dove neonati movimenti politici su questo tipo di analisi hanno sviluppato il consenso che li ha condotti alla presa del potere, a livello centrale e/o locale.
Se quei movimenti sapranno risolvere la crisi, lo dirà il futuro. De Forti non si occupa di formule partitiche: dice però cose utili alla costruzione di scenari politici, quando passa a suggerire gli strumenti per uscire dalla crisi. Al primo posto la necessità di ricreare condizioni di empatia e “intersoggettività”, di alzare il livello delle relazioni tra le persone. La ripresa di intensità nello scambio tra personalità, a scapito dello scambio tra oggetti (denaro e tecnologia inclusi) genererebbe condizioni di socialità nelle quali l’essere tornerebbe a prevalere sull’apparire, la sostanza dei comportamenti sulle fantasmagorie delle forme. La vendita del sé, anche del consenso politico, avviene nella società dell’apparire non in quella della cultura e della consapevolezza. Il riprendere se stessi da parte delle persone, il riappropriarsi del profondo (incluse affettività ed emozioni), ha tra gli effetti quello di togliere spazio alla politica politicante perché le oppone persone consapevoli del sé e della capacità di relazionarlo liberamente agli altri.
E’ un processo che verrebbe immediatamente a riguardare anche l’uso che si fa di denaro e tecnologia, restituibili alla natura di banali strumenti di lavoro e scambio, non, come sta accadendo in modo generalizzato, fini ai quali si sacrificano la persona e le sue capacità di relazione.












