Manlio Graziano i lettori de La VOCE di New York lo conoscono bene, è il columnist di “Geopolitico”. 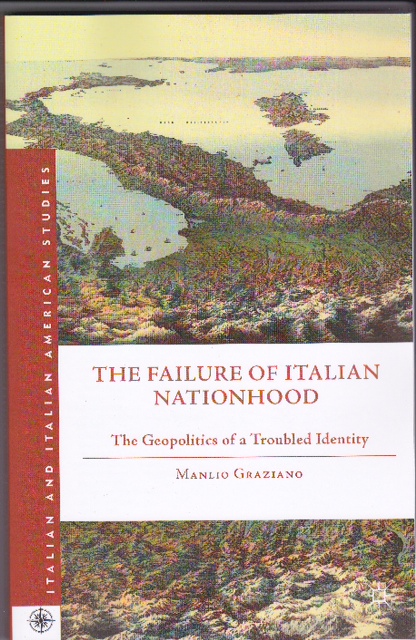 Proprio in questi giorni esce in edizione paperback un libro con cui Graziano, professore di geopolitica alla Sorbona di Parigi, già tre anni fa fece discutere molto: The Failure of Italian Nationhood: The Geopolitics of a Troubled Identity (Palgrave, 2013). Graziano venne anche negli Stati Uniti a presentare il suo saggio che ha avuto molta attenzione all’estero e che però, come ci farà notare lui stesso, in Italia a quanto pare è stato quasi ignorato. In occasione della seconda edizione americana del “Fallimento della nazione italiana” e alla luce degli ultimi avvenimenti politici accaduti in Italia, abbiamo voluto intervistare il Prof. Graziano per riprendere le fila delle sue tesi presentate proprio due anni fa a New York.
Proprio in questi giorni esce in edizione paperback un libro con cui Graziano, professore di geopolitica alla Sorbona di Parigi, già tre anni fa fece discutere molto: The Failure of Italian Nationhood: The Geopolitics of a Troubled Identity (Palgrave, 2013). Graziano venne anche negli Stati Uniti a presentare il suo saggio che ha avuto molta attenzione all’estero e che però, come ci farà notare lui stesso, in Italia a quanto pare è stato quasi ignorato. In occasione della seconda edizione americana del “Fallimento della nazione italiana” e alla luce degli ultimi avvenimenti politici accaduti in Italia, abbiamo voluto intervistare il Prof. Graziano per riprendere le fila delle sue tesi presentate proprio due anni fa a New York.
Professor Graziano, il suo libro è uscito tre anni fa. Ora esce in paperback. Tutti gli sconvolgimenti che sono successi da allora, incluse le dimissioni di Berlusconi dal governo e ora l’imminente decadenza, chi aveva letto il suo libro allora non dovrebbe sorprendersi adesso? O forse è successo qualcosa che anche lei non avrebbe mai previsto?
All’origine, il mio progetto era di cercare di spiegare Berlusconi ai francesi. Strada facendo, è diventato un libro sul “berlusconismo”, visto come ultima “autobiografia dell’Italia”, un po’ come lo era il fascismo agli occhi di Gobetti. Quindi, nel libro c’è poco, pochissimo, su Silvio Berlusconi; c’è piuttosto un tentativo di spiegare come e perché la crisi di internazionalizzazione degli anni Novanta abbia prodotto, tra l’altro, un leader politico di tal fatta. È l’Italia di quel periodo – con la sua nuova ricchezza accumulata nel decennio precedente, e con la sua paura di perderla – che ha creato Berlusconi a sua immagine e somiglianza, non il contrario.
Da allora – da quando il signor Berlusconi vinse le elezioni nel 1994 – quel che è accaduto, sostanzialmente, è che i suoi avversari si sono occupati solo ed esclusivamente di lui, delle sue televisioni, delle sue vicende giudiziarie, delle sue donne etc., e hanno smesso di occuparsi di politica. Cioè ne hanno fatto un gigante, e al tempo stesso hanno rinunciato a capire in che paese (e in che situazione internazionale) vivevano e vivono: questo li ha portati ad inanellare una serie di sconfitte una più penosa dell’altra. Il signor Berlusconi aveva su di loro un vantaggio inestimabile: lui non aveva bisogno di capire il paese, lui personificava il paese. Il “berlusconismo” è un dato di fatto, è una psicologia sociale (anche se molto cambiata rispetto a vent’anni fa) che esiste e che è largamente maggioritaria in Italia, e che esiste anche senza il suo eponimo: mettete Berlusconi agli arresti domiciliari, a preparare la pappa a Dudù, o dove vi pare, il berlusconismo sarà sempre lì. Il berlusconismo può essere anche contro il suo eponimo: una parte della Lega, il movimento Cinquestelle, e una parte della sinistra (penso al signor Renzi in particolare) interpretano un berlusconismo anti-berlusconiano.
Nel “fallimento della nazione” italiana, lei individua il “peccato originale” nelle circostanze in cui avvenne l’Unità. In ordine di importanza, ci può dire quali furono i maggiori errori di allora e di cui paghiamo ancora le conseguenze?
Non parlerei di errori. Anzi, penso che la via del “peccato originale” (la formula è di Sergio Romano) fosse l’unica percorribile per “fare l’Italia”. Se Cavour non avesse avuto la suprema abilità di cogliere un fascio di relazioni internazionali favorevoli (la rivalità tra Francia e mondo germanico sul continente e tra Francia e Inghilterra nel Mediterraneo), e di unirle ad alcune circostanze fortuite (l’attentato di Orsini, la spedizione di Garibaldi), l’Italia non si sarebbe fatta per niente. O forse sì, in altre circostanze, più tardi, ma sempre e comunque come sottoprodotto delle lotte politiche delle grandi potenze.
Cavour è morto troppo presto, si dice. E ci si immagina quale meravigliosa sorte avrebbe incontrato il paese se fosse vissuto più a lungo. In particolare, si pensa alla guerra civile nel Sud, alla colonizzazione piemontese, etc. A me non piace molto la storia controfattuale. Preferisco cercare di capire perché le cose sono andate come sono andate: il Piemonte si è trovato con un boccone troppo grosso, e non aveva i mezzi economici, politici e culturali per digerirlo. Ma il problema centrale è che l’Italia è stata costruita non sulla rivalità tra il Nord e il Sud, ma sulla rivalità tra Torino e Milano: se vogliamo parlare di “peccato” – come sostantivo e come esclamazione – credo che il vero “peccato originale” stia proprio lì.
Per lei l’Italia nasce grazie “alla tutela di potenze” straniere, quindi è destinata a rimanere tale per sempre? Anche con l’Europa un giorno più unita?
Molti altri paesi sono nati non da una rivoluzione nazionale ma in seguito alle lotte politiche internazionali: la Grecia, la Romania, l’Italia, l’Albania, etc. Il limite dell’Italia e di quasi tutti i governanti dopo Cavour è stato di fare finta che l’Italia si fosse fatta da sé, di inventare il Risorgimento, le guerre di indipendenza e giù giù fino alla Terza Roma, all’impero, e via cianciando. Tutte smargiassate che hanno prodotto solo grandi catastrofi. Il limite dell’Italia è stato di aver avuto, alla sua testa, pochi realisti (Cavour, Sella, Giolitti, De Gasperi e Andreotti: non me ne vengono in mente altri) e tanti parolai, tanti venditori di fumo.
Il signor Berlusconi, per tornare a lui, ha spontaneamente incarnato l’Italia in una fase del suo recente sviluppo, ma non per questo è stato un realista. Anzi. Proprio lui ha cominciato la sua carriera di capo del governo pensando di poter sfidare l’Unione europea con la minaccia di tornare in grembo allo zio Sam. È quest’assenza di realismo che ha portato alla caduta quasi immediata del suo primo governo.
Il problema della cessione di sovranità all’Europa è più ampio, e come si sa non riguarda solo l’Italia. Quello che vedo è che l’Italia potrebbe riprendere un ruolo che aveva perso dopo la crisi del 2005, di “apripista” per le soluzioni politiche in Europa: la formula delle “grandi intese” potrebbe infatti indicare il profilarsi di una ricomposizione del panorama politico intorno alla sola questione che conta oggi davvero per i ventotto – e in particolare per i diciassette dell’eurogruppo: l’Europa, appunto. Da una parte i “sovranisti”, dall’altra gli “europeisti”. In nove paesi su diciassette (contando anche la Germania, in fieri) le cose stanno andando in questa direzione. L’Italia può, teoricamente, mettersi alla testa di questo processo sfruttando il suo “vantaggio democristiano”: cioè il fatto che sia il capo degli europeisti di sinistra che il capo degli europeisti di destra siano entrambi democristiani.
Anche il fenomeno Grillo e il movimento Cinquestelle fanno parte di questo “peccato originale”? O potrebbe essere un sussulto che va in direzione opposta alla tradizione italiana “del tutto deve cambiare per rimanere com’è”?
Non so se il signor Grillo e il suo movimento riusciranno ad occupare un posto stabile nel panorama politico italiano oppure no. Alcuni anni fa esplose il “fenomeno Bonino”, che durò lo spazio di un’elezione europea. Vedremo. Quel che è certo è che il successo elettorale del signor Grillo e dei suoi guru segnala due aspetti del berlusconismo che reclamano una rappresentanza politica: da una parte il solito, annoso, e alla lunga anche un po’ noioso, bisogno di un “uomo della provvidenza”, a cui molti italiani si aggrappano nei momenti di confusione e di crisi; dall’altra un “berlusconismo antieuropeo” sempre più radicale, che vede in tutto quello che è successo negli ultimi vent’anni (piattaforme virtuali escluse) il male da combattere: non solo il signor Berlusconi, ma anche e soprattutto l’euro, la cessione di sovranità, l’apertura dei mercati e delle frontiere, la crescita della Cina, l’alta velocità, etc. Non è un fenomeno solo italiano: in Francia è ben rappresentato dalla signora Le Pen e dal signor Melenchon, i quali, insieme, hanno raccolto nel 2012 appena un po’ meno di quanto non abbia raccolto il signor Grillo alle ultime elezioni. E non è un fenomeno nuovo: da che mondo è mondo, i laudatores temporis acti, i “si stava meglio quando si stava peggio”, i “ai miei tempi queste cose non succedevano”, sono sempre stati legione. Ma di solito si trattava di vecchi borbottoni: il successo di Grillo rivela che molti giovani crescono già vecchi, e borbottoni.
Per tornare alla politica: l’Italia (ma neppure la Francia, la Germania, o la Grecia) non ha alternative all’Europa. Quindi, quale che sia la decisione degli elettori, sono gli europeisti che devono governare. Se Grillo vuole governare, un giorno, deve diventare europeista. Non è impossibile: in Italia, il PCI è diventato europeista, i fascisti son diventati europeisti, e anche Berlusconi è diventato europeista. Ce la può fare anche il signor Grillo.
In due parole: perché il suo libro merita di essere letto?
Inaspettatamente, il mio libro ha avuto dei riconoscimenti tanto autorevoli quanto lusinghieri: negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, un poco anche in Francia. In Italia, invece, quasi nessuna eco. Da meditare.
Per rispondere alla sua domanda, direi che merita di essere letto per andare a vedere se questi riconoscimenti sono giustificati. Il vantaggio del mio punto di vista è che è quello di un italiano, cresciuto dentro alle lotte politiche italiane, ma che è andato a vivere fuori dall’Italia, che ha analizzato il suo oggetto di studio dall’esterno, senza essere distratto né tantomeno coinvolto dalle polemicuzze romane (o brianzole). Non è un libro di attualità politica, ma un libro sull’identità politica italiana, come (non) si è venuta costruendo nel corso dei secoli, dalla fine del medio evo a Berlusconi. È senza dubbio un punto di vista diverso da molto di quello che si è abituati a leggere sull’argomento. Se non lo avessi scritto io, quest’ultima ragione mi basterebbe per andarlo subito a comprare.












