
L’episodio in sé è poca cosa, ma significativo. Lo racconta un operatore di antico pelo, ha girato il mondo, per lui la telecamera è una specie di protesi, un’amica inseparabile. Un giorno il giornalista gli chiede di fare un certo tipo di inquadratura, un movimento particolare, per ottenere un effetto visivo che gli preme. “Impossibile”, ribatte sicuro l’operatore fidandosi avventatamente della sua esperienza. “Ti sbagli, si può fare”, replica paziente il giornalista. L’operatore insiste, e insiste anche il giornalista. Non litigano, è solo che ognuno è sicuro del fatto suo. “Va bene”, taglia corto il giornalista. “Dammi la telecamera, che ti faccio vedere”. Erano gli anni in cui ancora si usava la pellicola, la telecamera una specie di kalashnikov, non una roba leggera come oggi che la può usare anche un bambino. Il giornalista afferra con naturalezza quel quintale di roba ed ecco che la sequenza voluta è fatta. “Roba da non crederci”, dice ammirato l’operatore. “Per la prima volta mi trovo a lavorare con un giornalista che ne sa più dell’operatore in fatto di telecamera e trucchi di immagine”. Quel giornalista carico di “conoscenza”, frutto di esperienza sul “campo” si chiamava Sergio Zavoli.
Di aneddoti simili su Zavoli se ne possono raccontare a decine, una leggenda in RAI; e anche quando capitava di canzonarlo (“Commosso viaggiatore”, “Lotto continuo”, perché investiva i guadagni in terra), o si imitava quella sua voce solenne (che però era sua, non impostata come, per fare un esempio, Vittorio Gasmann), c’era sempre un sottofondo di rispetto, di riconoscimento al merito. Zavoli e la televisione (più propriamente la RAI) erano un tutt’uno: socialista senza un vero partito; cristiano di una sua particolare chiesa; aziendalista fino al midollo.

Giornalista di altra epoca. La televisione a cui approda, per esempio: il potere democristiano la fa da padrone; un Vaticano assai più potente e influente detta legge sul costume e la morale; parole come “membro”, sono vietate. Scoppia un casino, letterale, quando, proprio ai microfoni di Zavoli un campione del ciclismo si lascia scappare: “E’ un casino”. Poi il clima si mitiga con l’arrivo dei socialisti e di qualche laico: si chiamava “lottizzazione”: dieci assunti, quattro democristiani, tre socialisti, un paio di laici, uno bravo. Capitava, comunque, che anche tra i “politici” ci fosse qualcuno che il suo mestiere lo sapeva fare. Una generazione fatta di Piero Angela e Gianni Bisiach, Tito Stagno; e tra quelli che se ne sono andati, Brando Giordani, Carlo Mazzarella, Giuseppe “Joe” Marrazzo, Arrigo Petacco, Emilio Ravel, Sergio Telmon… I loro lavori oggi si studiano nelle università di giornalismo: avevano il gusto della notizia, ma soprattutto del “racconto”: bastava una certa parola detta in un certo contesto, un gesto, anche “piccolo”, catturato senza che il protagonista se ne rendesse conto…
Può aiutare a capire il racconto, da lui stesso fatto, di una delle sue prime inchieste, sul mondo dei malati di mente, i “matti”. Sergio viene a sapere che a Gorizia c’è un ospedale psichiatrico il cui direttore coltiva un’idea diversa del rapporto con queste persone con problemi di sofferenza “dentro”. Fino ad allora venivano isolati, nascosti, le famiglie se ne vergognavano. Quel direttore si chiamava Franco Basaglia. Lui e i suoi collaboratori, anche grazie a un’amministrazione locale illuminata, trattano i malati come persone, come esseri umani che vanno compresi e aiutati. Occorre fare in modo che non arrechino danno a loro stessi e al prossimo, ma vanno anche rispettati, e hanno bisogno di qualcuno che voglia loro bene, li comprenda. I risultati non mancano, senza bisogno, se non in casi estremi, di psicofarmaci e camicia di forza, letto di contenzione. E’ il 1968, e per la prima volta l’Italia conosce “i matti”, il loro dolore, la loro tragedia. Zavoli ne ricava un’inchiesta, “I giardini di Abele” che ancora oggi fa scuola.
Siamo nel 1968, le immagini sono in bianco e nero. Zavoli intervista Basaglia. Non è la classica domanda uno seduto davanti all’altro. Zavoli è solo una voce, ogni tanto. Basaglia in piedi, cammina su e giù, cogitabondo, riflette ad alta voce; pause, si ferma, ripete in concetto, come se lo volesse imprimere bene in mente, fissa la telecamera, insegue un pensiero… A un certo punto una domanda di Zavoli: “E’ più importante la malattia o il malato?”. Sembra inutile, banale. Basaglia risponde secco, quasi senza pensare: “Il malato”.
Era il 1968: con quella semplice risposta, a quella domanda “banale” Basaglia e Zavoli spazzano via anni di psichiatria intesa come persona persa, irrecuperabile, da tenere lontano, prigioniera in luoghi ignoti e ignorati, dove regna solo dolore, sofferenza, solitudine. Basaglia e Zavoli dicono: è la persona che conta, sempre e comunque. Una piccola grande rivoluzione.
Zavoli era il giornalista “capace” di apparenti domande “banali”; e dell’ascolto. Meticoloso nel gioco delle inquadrature; maniacale nella scelta delle immagini; instancabile nella saletta di montaggio; protagonista di pause sapienti nelle “dirette”, capace di silenzi eloquenti, la voglia di scandagliare e capire, perché solo così si arriva “primi”. Perché è importante dire la cosa “giusta” nel momento”giusto, nel luogo “giusto”. Ma più importante ancora è il testimone che ti racconta cose che neppure per lui sembrano importanti e si rivelano invece essenziali per capire, quel gesto a cui non presti attenzione: il grattarsi, o una carezza, che rivelano invece tensione, paura, tenerezza. Sono doti, capacità che vengono con il tempo, si possono forse trasmettere con l’esempio, non insegnare.
Zavoli queste doti le aveva: un sedimento forse frutto dei lunghi anni in provincia a Rimini, con l’amico di sempre Federico Fellini. Maturate poi con il girare nei quattro angoli del mondo, e scorazzando in un’Italia che gli stessi italiani scoprivano con lui…
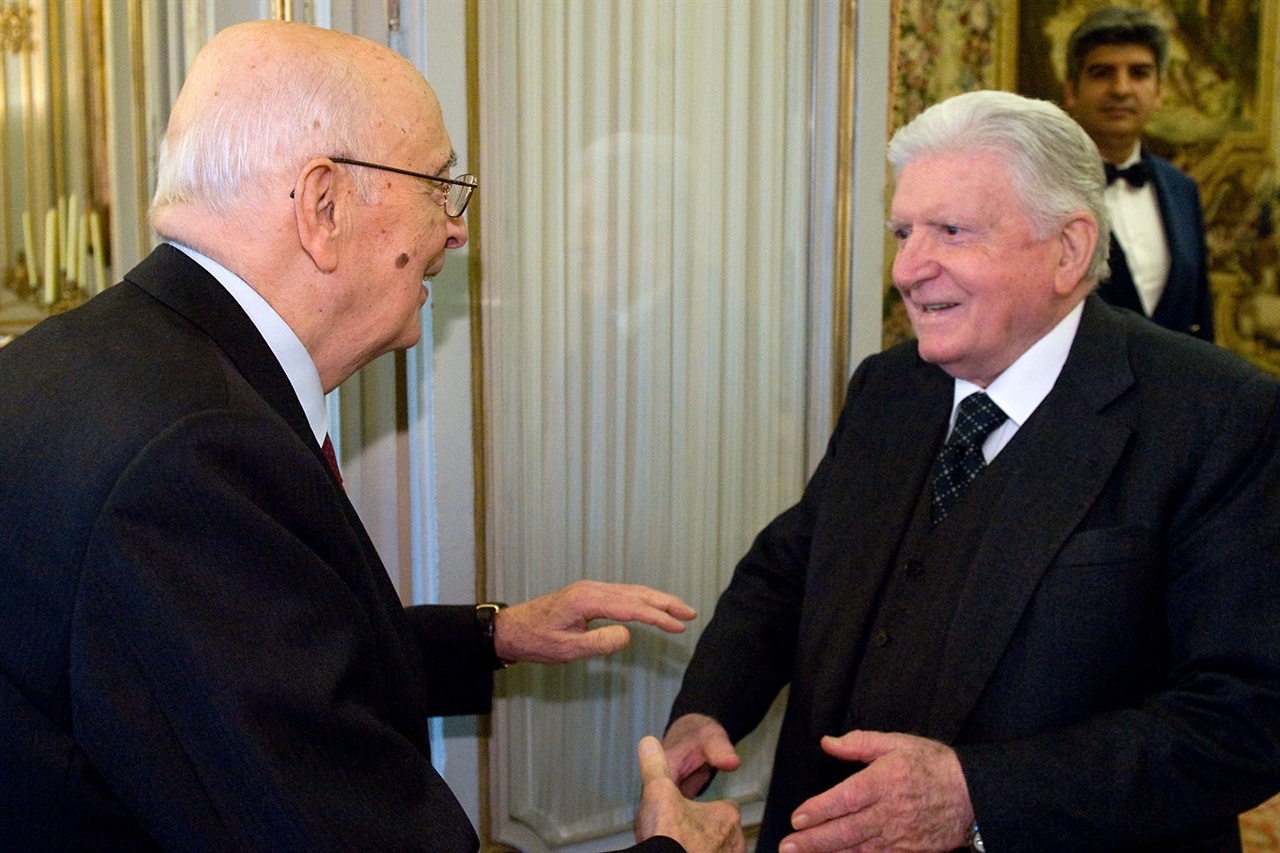
Si dice che di personaggi come Zavoli si è persa la matrice. Certo di questi tempi se ne “stampano” pochi. Lui stesso ammetteva d’essere come una foglia d’autunno che basta un soffio di vento e si stacca dal ramo, destinata a ingiallire e morire. Tuttavia, fino all’ultimo, la voglia di capire e sapere, per poi raccontare. Gli chiedevi: “Come va?”; finiti per raccontagli la tua vita.
Da qualche parte riderà del nostro pasticciare, con gli altri della sua “banda”; e penso che alla fine un po’ scuoterà la testa, malinconico, per i tempi sguaiati e volgari che viviamo e che a lui non sono mai piaciuti.












