Gary Becker, premio nobel per l'economia e professore della University di Chiacago, teorico del capitale umano che ha rivoluzionato il modo di pensare l'economia del 900, si è spento il 3 maggio a 83 anni. Questo contributo per La VOCE è dedicato alla sua memoria.
Studiare i problemi attraverso chiavi di lettura differenti dalla propria impostazione culturale può rivelarsi un’esperienza estremamente arricchente ed interessante che ho avuto modo di sperimentare per la prima volta nel 1996, quando incontrai Gary S. Becker, in occasione di un convegno tenutosi a Chicago sul ruolo dei virus e dell’amianto nell’insorgenza del mesotelioma.
Già in quell’occasione avemmo modo di confrontarci sulla questione ambientale in Campania sotto l’aspetto economico perché per Gary Becker, Premio Nobel scomparso solo qualche giorno fa, le questioni sociali (i comportamenti criminali e discriminatori, l’istruzione, la famiglia) si risolvevano in una razionale analisi tra costi e benefici, capace di affermare il ruolo dei fattori economici in ambiti che si pensavano ad essi estranei.
In qualche modo, un’operazione intuitivamente simile era stata compiuta già negli anni settanta nel primo libro bianco sulla mappa della nocività in Campania da alcuni studiosi, i quali avevano osservato come ad maggiore esposizione a sostanze tossiche corrispondesse una maggiore possibilità di contrarre patologie rispetto agli abitanti di zone meno industrializzate.
L’indagine si focalizzava sull’inquinamento della città di Napoli, prefigurando la catastrofe per l’uomo qualora l’avanzata tecnologica dell’industria in genere non fosse stata opportunamente regolata.
In altre parole, come evidenziava il Prof. Giorgio Nebbia, ordinario di Merceologia ed incaricato di Ecologia all’Università di Bari, risultava evidente la necessità di amministrare il pianeta e le sue risorse con una attenzione di pari misura sia all’aspetto economico che a quello ecologico in considerazione degli effetti delle attività umane sull’ambiente inorganico e vivente circostante.
“Tale attenzione” – scriveva nel libro Ambiente e Salute – “non si traduce in una vita povera o triste, non comporta il rifiuto della tecnologia, ma impone anche eliminazione di ingiustizie economiche; alcuni soggetti economici, infatti, nel corso della loro attività e col loro comportamento, arrecano danni ad altri e alla collettività sfruttando le risorse naturali collettive, provocando inquinamenti, erosioni del suolo, frane, congestione, rumore, deturpazione del paesaggio, stragi di animali; in qualche caso questi danni derivano dall’uso e dall’abuso di risorse naturali su cui essi hanno un diritto di proprietà (come il suolo edificabile), ma più spesso derivano dall’uso e dall’abuso di risorse naturali collettive (aria, fiumi, mare, animali allo stato naturale, ecc.), il cui diritto di godimento da parte della collettività viene ad essere impedito a vantaggio di pochi”.
Quel testo di quaranta anni fa appare come una malefica profezia.
Quel quadro minaccioso si è fatto evidente realtà della correlazione tra ambiente ed incremento dell’incidenza delle neoplasie per la presenza di sostanze cancerogene (vapori e fumi di idrocarburi; additivi delle benzine; coloranti azoici, benzene, cicloxano, toluene, xilene, pigmenti al cromo esavalente, ossido di piombo, polveri di asbesto).
Studi più recenti, invece, hanno evidenziato come la bonifica di siti contaminati in alcune regioni degli USA, abbiano portato alla riduzione del 20-25 per cento di anomalie congenite nei residenti di quelle aree dove la bonifica ha avuto luogo, tanto da far rilevare ai ricercatori autori dello studio che i benefici netti monetari derivanti dalla bonifica dei siti pericolosi presenti in Campania sarebbero notevolmente superiori ai costi previsti.
In quest'ottica è allora evidente come in una società che cambia profondamente si renda necessaria una analisi delle situazioni a trecentosessanta gradi che integri la scienza alla sociologia, all'economia, nel tentativo di risolvere le sfide provenienti da una società complessa come la nostra.
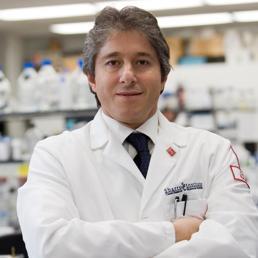 *Antonio Giordano, napoletano e tifoso del Napoli, vive a Philadelphia ed è un medico ricercatore di fama internazionale. Allievo del premio Nobel J. Watson, oncologo, dirige lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia e insegna anche all'Università di Siena. Con il collega Giulio Tarro, ha scritto il libro denuncia Campania, Terra dei veleni (Denaro Libri, 2012).
*Antonio Giordano, napoletano e tifoso del Napoli, vive a Philadelphia ed è un medico ricercatore di fama internazionale. Allievo del premio Nobel J. Watson, oncologo, dirige lo Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine della Temple University di Philadelphia e insegna anche all'Università di Siena. Con il collega Giulio Tarro, ha scritto il libro denuncia Campania, Terra dei veleni (Denaro Libri, 2012).












