“Come nasce Pantelleria?”- chiedo a Pierino Belvisi, il geologo emeritus dell’isola.
“Accadde circa 500.000 anni fa” – mi racconta Pierino – “ci fu una tremenda esplosione nel centro del Mediterraneo che causò la frattura del rift del Canale di Sicilia, e una massa di magma incandescente venne proiettata verso l’alto da una profondità di oltre duemila metri.”

“Poi, la lava infuocata a contatto con l’aria si consolidò in forme dirompenti e infernali, frantumandosi in volumi prismatici, creando archi e piscine naturali, aprendosi in grotte profonde, e acquistando una crosta coriacea che ricorda gli animali preistorici”.
“Ah, come avrei voluto esserci!”- si lascia sfuggire Pierino visibilmente emozionato.
“Da allora, sono avvenute molte altre spettacolari eruzioni che hanno modificato la forma dell’isola, aggiungendo, sottraendo e modificando i vari strati lavici. La più vistosa avvenne circa 45.000 anni fà, la più intrigante nel 1831, quando apparve e poi scomparve l’isola Ferdinandea, e quella più misteriosa e recente nel 1891, quando l’eruzione avvenne sott’acqua, di fronte al centro portuale dell’isola”.

Il risultato è che, oggi, le coste di Pantelleria offrono straordinari paesaggi vulcanici che costituiscono eccezionali opere di “land art”, create nei millenni dal fuoco, dal mare e dal vento.
Ma se l’involucro dell’isola è unicamente selvaggio, il suo interno è stato modellato nel corso dei secoli dagli abitanti a loro uso e consumo, e rivela l’armonia di un ambiente caparbiamente umanizzato.

Quest’anno, avendo scoperto un piccolo caffè sulla piazza di Tracino che serve una squisita spremuta di melograno, ne approfitto ogni mattina. Lì, incontro spesso Franco, un’istituzione locale e vecchio amico degli anni ‘70, quando faceva il fotografo durante l’estate e il “tombeur des femmes” nei periodi invernali a Cortina d’Ampezzo.
Franco ha fatto di tutto nella sua vita senza mai perdere la convinzione di essere sempre nel giusto. Da complice nel concepimento de Il Panteco, ex-Direttore della Pro Loco, ex-ristoratore, è diventato nella sua terza età anche filosofo, ed è per questo che, coerentemente con le tradizioni locali, è stato ribattezzato “Socrate”.
“Ho letto il tuo articolo su Filopanti e Barbapanti”– mi dice, -“e trovo che questo conflitto sia solo la manifestazione locale di quello più ampio tra civiltà e barbarie. Ma, a Pantelleria, i barbari non sono i locali, ma gli outsiders”.

Gli chiedo come differenzi questi due comportamenti e mi regala una lezione di filosofia pratica.
“Le persone civili” – mi dice -“hanno una visione positiva e altruistica della società e del pianeta, mentre i barbari hanno un approccio spietato, individualista e materialista”.
“Spiegati meglio”.
“Detto con parole semplici, ‘civiltà’ è rispetto per la vita e la natura in tutte le loro manifestazioni e, quindi, espressione di fiducia, speranza e cooperazione; il barbarismo, al contrario, è violenza, aggressività e sopraffazione nei riguardi del prossimo e dell’ambiente”.
“Parli come Papa Francesco”- osservo, -“ma quali pensi siano le motivazioni dei barbari a questi comportamenti negativi?”
“Attenzione”- mi corregge, “sono negativi per la società, ma positivi per i loro interessi”- e continua:
“Barbari è un termine usato storicamente per definire gli stranieri, sempre percepiti come nemici e saccheggiatori. Per gli antichi Romani, i barbari erano i Vandali e gli altri invasori del Nord Europa che, a loro avviso, non avevano il minimo livello di educazione civica. Oggi, il barbarismo non è solo dovuto a ignoranza civica, ma agli effetti del culto del denaro. Quando tutto viene mercificato in funzione del suo valore quantitativo, il pianeta si sfascia, i rapporti umani si volgarizzano, e si perde anche il rispetto della vita”.
Gli ricordo che, 40 anni fà, aveva chiamato il suo ristorante “Ho Chi Minh” (senza nessun riferimento alla cucina vietnamita), una referenza al fatto che questa sua visione della società possa essere condizionata dal suo passato marxista.

“Macché”- mi risponde, -“il comunismo è ancora più barbarico e materialista del capitalismo; io sono convinto che, per vivere meglio, bisogna svincolarsi da queste caratterizzazioni ideologiche. Oggi, le persone si identificano ingenuamente (o ipocritamente) con le denominazioni più diverse, per cui si dichiarano liberali o comunisti, conservatori o progressisti, nazionalisti o globalisti, relativisti o nichilisti senza comprendere appieno quello che questi “tatuaggi” ideologici significhino. E’ un modo per sentirsi parte di un gruppo ma la realtà è che la maggioranza delle persone, indipendentemente dal loro presunto credo ideologico, ha in comune il fatto di essere incazzata con la realtà politica, economica e sociale in cui vive”.
“E perché?”- domando.
“Io credo che le ragioni principali siano due: mancanza di rispetto, e frustrazione crescente per l’incapacità di ottenere ciò che si desidera”.
“Mancanza di rispetto?”

“In realtà, per ‘rispetto’ intendo ‘giustizia’, una nozione soggettiva ma molto popolare nella retorica politica ed economica dei nostri giorni. Per millenni, la maggior parte degli abitanti del nostro pianeta è stata discriminata per il colore della pelle, il sesso, la religione e le condizioni economiche. Mentre in passato queste discriminazioni erano accettate come immutabili determinazioni divine, oggi i neri non vogliono più essere subordinati ai bianchi, le donne ne hanno piene le scatole di venire abusate sessualmente ed economicamente dagli uomini, e i poveri non vogliono essere considerati inferiori per il fatto di avere meno soldini a disposizione. Oggi, malgrado queste palesi manifestazioni di ingiustizie sociali, economiche e culturali continuino ad esistere, non sono più tollerate, e vengono considerate come una mancanza di rispetto da parte delle classi sociali privilegiate”.
“E per quanto riguarda le aspettative mancate?”- chiedo.
“Con il dilagare delle informazioni, le aspettative degli individui sono aumentate in modo sproporzionato rispetto alla possibilità che vengano soddisfatte. Persino il lusso è diventato oggi un diritto a cui nessuno vuole rinunciare. Il risultato è un’insoddisfazione crescente verso l’organizzazione della nostra società, e il consolidarsi di quei movimenti politici che speculano su questa insoddisfazione. Questo è, secondo me, un rigurgito barbarico e, voi per primi, in America, ne subite le conseguenze!”

Sorvolo sul fatto che in Italia, la situazione non sia certo migliore, mentre Socrate continua:
“Pantelleria, grazie al suo isolamento insulare, è ancora in gran parte immune, da questo barbarismo. Qui viviamo in armonia con la terra e la sua comunità, e siamo appagati dalla nostra condizione esistenziale, specie quando, finita l’estate, si spegne la contaminazione turistica. In breve la natura dei panteschi riflette umanità e saggezza ma, soprattutto, gratitudine”.
“Non mi sembra che siate veramente appagati,”- ribatto -“non sento in giro che lamentele per la mancanza d’acqua, le interruzioni ai collegamenti aerei o marittimi, l’esaurimento della fauna ittica, le lacune dell’ospedale….”
“ Roberto!” – mi blocca subito –“Queste sono minuzie, e proprio perché tu vivi in una città barbarica dove la vita è al servizio del dio-denaro, dovresti capire quello che cerco di dirti”.
“New York, una città barbarica………?”- rispondo con stupore, -“ ma se è la città in cui la maggior parte degli abitanti del pianeta sogna di poter vivere…”

Ma Socrate non disarma: “New York è la città più emblematica di un certo modo di vivere basato sulla competitività e la sopraffazione, sul desiderio di vincere sempre, arricchirsi e primeggiare. E’ un modo di vivere che sta prendendo piede dovunque nella società occidentale, e la verità è che tu torni a Pantelleria per sfuggire a questa realtà barbarica, per rifarti una verginità, e per rigenerarti in uno dei pochi luoghi rimasti dove la gente è ancora sana di mente, e la natura è di una straordinaria bellezza”.
-Forse ricorderai che Pantelleria Internet del 1mo aprile 2016 riportava la notizia che Barack Obama stava cercando una sistemazione sull’isola per disintossicarsi dopo le elezioni; questa notizia, per quanto fosse un ‘Pesce d’Aprile’, era molto verosimile”.
“Mi fai pensare al ‘Ragazzo della Via Gluck’-, gli rispondo benevolmente, -“non è una colpa vivere a New York, e neppure venire su quest’isola per, come dici tu, rifarsi una verginità. Anche a New York si può vivere di idee, arte e poesia, senza farsi strumentalizzare dalla dinamica competitiva e consumista; inoltre, il denaro non è un fine ma solo un mezzo di scambio, ed è anche un mezzo estremamente democratico che non discrimina tra bianchi e neri, donne e uomini, cristiani e mussulmani,…”- ma mi accorgo che le mie parole mancano di convinzione.
Rifletto sul sermone di Socrate, e concordo che Pantelleria sia ancora un’isola sorprendentemente autentica, ma mi sembra che il senso di appagamento e di gratitudine che i panteschi portano verso il loro “modus vivendi” sia dettato principalmente dalla mancanza di alternative (“chi si contenta, gode”, dice il proverbio).

L’accenno alla gratitudine, mi fa tornare in mente un’avventura degli anni 70. Quel giorno, in un pomeriggio d’agosto, mi trovavo con due amici milanesi e due panteschi a discutere dei rapporti tra Pantelleria e la costa tunisina, che dista solo 40 miglia, e che diventa visibile a occhio nudo nelle giornate di Maestrale.
-“Pantelleria è sempre stata culturalmente legata alla Tunisia e molti panteschi vanno avanti e indietro frequentemente per visitare parenti ed amici.” – mi racconta uno degli amici panteschi –“Inoltre, non pochi tra i miei amici mantengono un’amante tunisina”.
E così, quasi per scherzo, decidemmo di fare un salto in Africa, e progettammo di traversare il Canale di Sicilia con i nostril due canotti gonfiabili.
In quegli anni, non c’erano pericoli di pirateria e i controlli doganali erano ridotti al minimo. Ma per traversare il Mediterraneo era comunque necessario un permesso dalla Capitaneria di Porto, e noi temevamo che le nostre fragili imbarcazioni con motori fuoribordo di limitata potenza non venissero autorizzati.
Decidemmo dunque di prendere il largo alla chetichella all’alba del giorno seguente, così da arrivare in Tunisia dopo circa cinque ore, navigando a vista durante le ultime due.
Il gruppetto dei milanesi era elettrizzato dal rischio dall’avventura, mentre i due panteschi sembravano più interessati ad esplorare i bordelli di Tunisi. Tra questi, uno era sposato, e sua moglie era una siciliana gelosa.
Al momento della partenza, il pantesco sposato si presentò con la cugina di sua moglie, una splendida diciannovenne dai grandi occhi neri e una capigliatura “afro”.
“Si chiama Valentina – ci disse – “ma non parla perché è muta dalla nascita”.
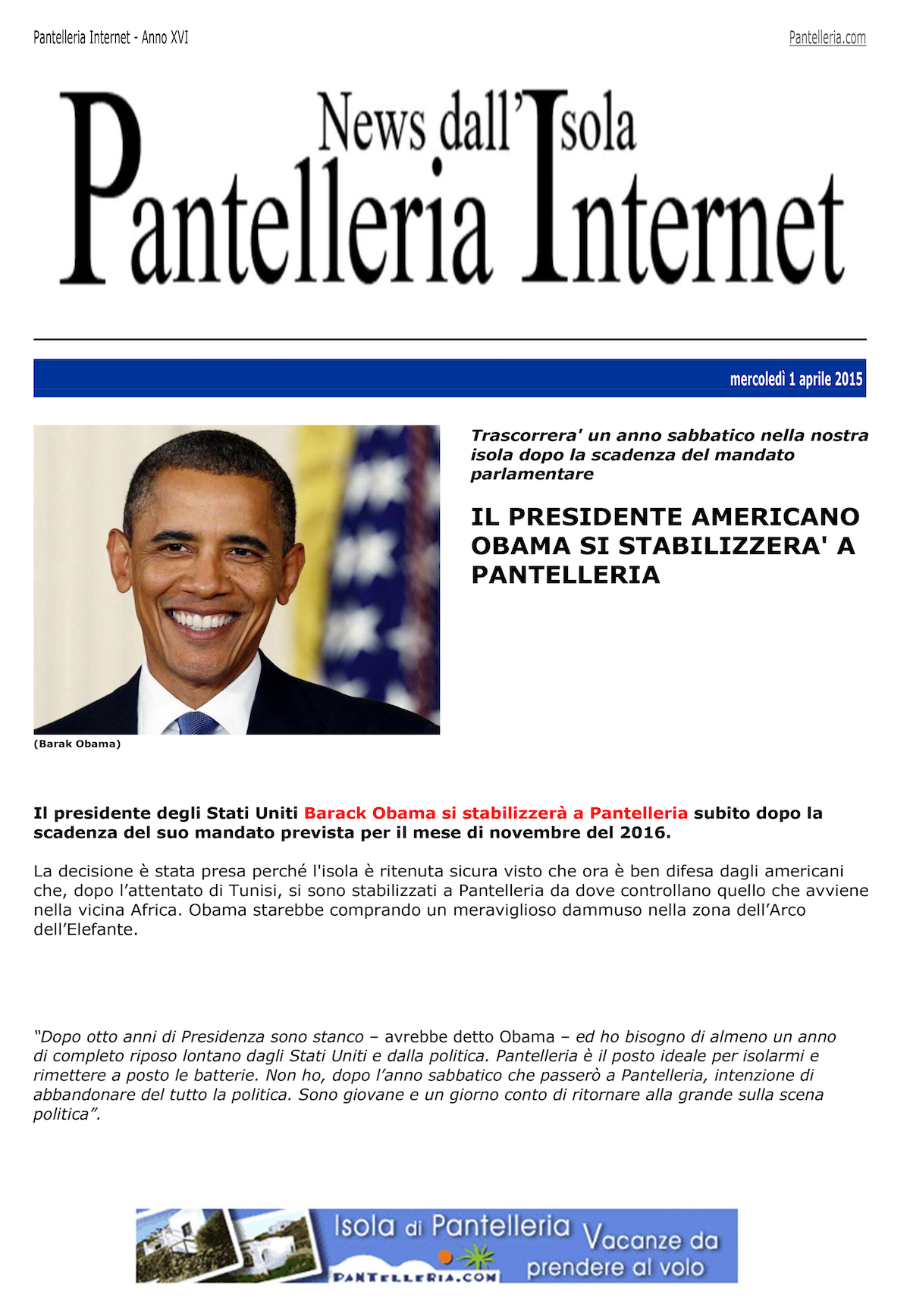
Aggiunse che gliela aveva imposta sua moglie per controllarlo, e che non aveva potuto rifiutare.
Non sollevammo obiezioni e salpammo con due canotti, una piccola bussola, 50 litri di benzina di scorta e qualche provvista. Non avevamo dubbi che, andando verso sud, prima o poi avremmo incontrato l’Africa, e tutto andò come previsto con una piccola eccezione. Eravamo in pieno Ramadam, per cui, arrivati nel porticciolo di Kelibia, non trovammo neppure un doganiere.
Qualche muezzin, però, doveva averci avvistati perché, dopo circa mezz’ora, fummo incastrati da due poliziotti a bordo di una grossa berlina nera.
Sorvolarono sul fatto che non avessimo alcun permesso per circolare in acque internazionali e ci timbrarono i passaporti. Poi, il più giovane dei due, chiaramente attratto da Valentina, ci chiese gentilmente in francese se potevamo dargli un passaggio in gommone fino a Hammamet.
Acconsentimmo, e lo sistemammo sul canotto dei panteschi, mentre il cugino di Valentina si eclissava furtivamente nelle stradine del porto.
Navigammo fino al tramonto con mare piuttosto agitato, e il poliziotto soffrì il mal di mare. Per rimediare, gli offrimmo della grappa di zibibbo e parte delle nostre provviste. Ma il nostro passeggero finì per ubriacarsi e cominciò ad importunare Valentina.
La situazione stava diventando insostenibile per cui, arrivati sulla spiaggia di Hammamet, gli chiesi di andarsene.
Ma il tunisino non aveva alcuna intenzione di lasciare la preda, e cominciò a diventare violento.
“A mali estremi, estremi rimedi”, pensai, e lo spinsi bruscamente in mare (dove si toccava), per poi prendere nuovamente il largo. Mi urlò dietro qualcosa che penso fosse molto offensivo ma, non conoscendo l’arabo, non mi offesi.
Eravamo in piena stagione turistica e tutti gli alberghi di Hammamet erano stracolmi. Decidemmo così di dormire sulla spiaggia, tra le dune di sabbia, non lontano dai nostri canotti, ma fuori dai sentieri che cammelli e cammellieri amavano percorrere avanti e indietro.
Eravamo stanchissimi e ci addormentammo quasi subito.
Nel mezzo della notte venni svegliato da un corpo femminile che mi si strofinava addosso. Era Valentina che voleva esprimermi la sua gratitudine per il pericolo scampato.
All’alba Valentina se ne tornò nella sua duna ma, prima di allontanarsi, ricordo distintamente che mi disse Grazie! Quella notte compresi l’importanza della gratitudine nella scala dei valori dei personaggi dell’isola.

La mattina dopo Valentina si comportò come se non fosse successo nulla, e continuò a non proferire parola. Suo cugino ci aveva nel frattempo raggiunti e, qualche giorno dopo, tornato il mare piatto, decidemmo di rientrare a Pantelleria.
Questa volta il rischio era notevole in quanto dovevamo trovare una piccola isola al centro di un grande mare, con soltanto una minuscola bussola come strumento nautico. Ma tutto andò per il meglio e arrivammo felicemente a casa portando come ricordo una bandiera tunisina sottratta di notte a un avamposto di polizia.
Sono passati alcuni decenni e non ho più rivisto Valentina. Voci pantesche mi dicono che viva nella contrada di Bugeber, e che sia sposata con 3 figli grandi e 7 nipoti. Ma mi dicono anche che sia sempre muta, per cui devo concludere che, quella notte a Hammamet, io sia stato vittima di un miraggio acustico.
Ma la vanità non ha limiti, per cui nutro sempre la speranza che il senso di gratitudine dei panteschi, descritto con tanto orgoglio da Socrate, fosse stato in quell’occasione così intenso da concederle per un’istante il dono della parola.
(Fine)











