Ogni giorno che passa, il Mar Mediterraneo somiglia sempre di più ad un groviglio di gasdotti e tubazioni che portano gas, petrolio e altro da un continente all’altro.
Ultimo arrivato, a quasi quattro anni e mezzo dall’inizio dei lavori, il gasdotto Trans-Adriatico realizzato dal consorzio TAP (Trans Adriatic pipeline A.G.) che ha sede centrale a Baar, in Svizzera. Azionisti Snam (al 20%), l’inglese BP (20%), l’azera SOCAR (20%), la belga FLUXYS (19%), la spagnola Enagàs (16%) e la svizzera Axpo (5%). A pieno regime questo gasdotto dovrebbe trasportare almeno 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno all’Italia e un miliardo di metri cubi a Grecia e Bulgaria partendo dal giacimento azero Shah Deniz II nel mar Caspio, lungo un percorso di 878 chilometri. Il TAP è stato presentato come strategicamente ed economicamente importante per l’Europa dal momento che rappresenta un’offerta energetica alternativa al gas russo di Nordstream 2 di Gazprom. Alcuni analisti, però, ritengono che l’apertura del nuovo gasdotto meridionale potrebbe avere ricadute in termini di prezzo sul mercato del gas europeo.
Il Tap non è l’unico progetto in fase di sviluppo. In cantiere c’è anche Baltic Pipeline, un gasdotto che partendo dalla piattaforma norvegese nel Mare del Nord raggiungerebbe la Polonia attraverso la Danimarca. E poi il Nabucco, il Blue Stream, il Gasdotto Igig Italia Grecia, il Galsi Pipeline project, Il Green Stream e il Medgaz. A breve ci sarà anche il progetto di Igi Poseidon per la realizzazione di un altro gasdotto lungo 1.900 km dal Mediterraneo orientale alla Penisola Ellenica e di qui all’Italia.
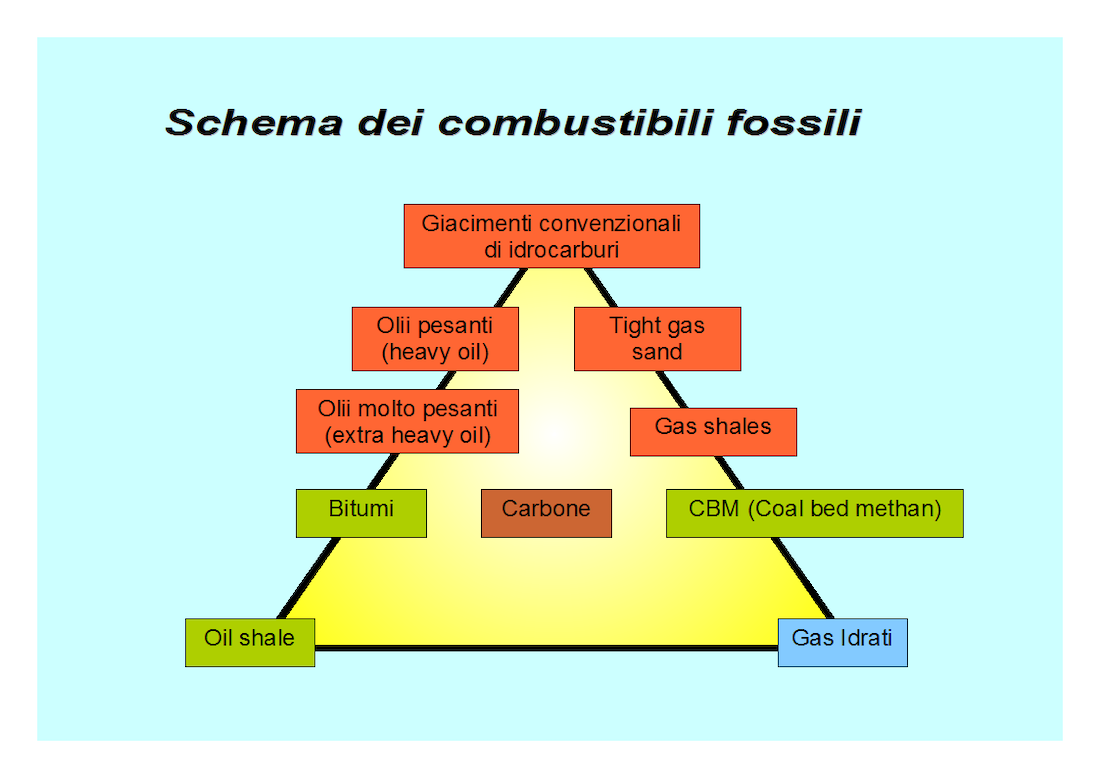
Eppure, secondo la società di dati Artelys, l’UE riceverebbe già da Norvegia, Russia, Turchia, Asia centrale e Nord Africa una quantità di gas naturale sufficiente a soddisfare la domanda. Anche quella futura (anche nel caso in cui dovesse verificarsi uno shock dell’offerta per un anno da parte di uno dei fornitori). Qual’è, allora, il motivo di questa corsa sfrenata a costruire gasdotti nel Mar Mediterraneo?
Non bisogna dimenticare che il gas naturale non è ecologicamente sostenibile come, da anni, si cerca di far credere. Questa miscela di metano, butano, propano, etano, anidride carbonica e azoto, impiegato in diversi ambiti (oggi circa la metà dell’energia elettrica prodotta in Italia deriva da centrali alimentate proprio a gas naturale), è facilmente reperibile e relativamente conveniente dal punto di vista economico (rispetto ad altri combustibili come il petrolio). Ma, per contro, come gli altri combustibili fossili, ha delle controindicazioni: se finisce nell’atmosfera prima di essere trattato può causare un effetto serra addirittura superiore all’anidride carbonica. Confrontato con gli altri combustibili fossili, impiegati in modo massiccio nelle industrie o per alimentare i mezzi di trasporto, il gas naturale è meno inquinante ma la sua combustione genera comunque gas serra, quindi non si può dire che non inquini. Per questo motivo, prima di essere utilizzato, il gas naturale deve essere trattato.
Secondo alcuni analisti, i gasdotti che stanno invadendo il Mar Mediterraneo non solo costituirebbero un rischio per il clima, ma sarebbero inutili. Nei giorni scorsi, Global Witness ha pubblicato un rapporto che lo dimostra partendo da due considerazioni di base: l’impatto che gasdotti come EastMed o TIP avrebbero sull’ambiente (le emissioni causerebbero un danno pari a quelle annuali di Francia, Italia e Spagna insieme) e il fatto che il gas destinato ai mercati dell’UE, realmente non è necessario (“Oggi l’UE ha abbastanza gas per soddisfare la domanda esistente. E l’UE prevede che la domanda dovrebbe presto diminuire rapidamente se vuole combattere con successo il cambiamento climatico, diminuendo del 90% entro il 2050. I paesi dell’UE non hanno bisogno di gas dal Mediterraneo orientale”, si legge nel rapporto).

Per contro, l’aumento dell’utilizzo di gas naturale renderebbero impossibile raggiungere gli obiettivi della COP di Parigi del 2016 ovvero contenere entro 1,5°C il surriscaldamento del pianeta, come richiesto dall’IPCC.
Eppure stando alle previsioni, entro il 2040 il gas naturale dovrebbe diventare la seconda risorsa energetica (dopo le rinnovabili) e la sua domanda potrebbe crescere di oltre il 40% nel prossimo ventennio. Nel futuro più prossimo, le fonti rinnovabili non saranno ancora in grado di soddisfare la domanda di energia. Per questo è necessario trovare una alternativa durante questa fase di transizione. Sarebbe questo il motivo che giustificherebbe la decisione (concettualmente discutibile) di considerare il gas naturale una risorsa sostenibile, incentivandone l’utilizzo anche con “investimenti verdi”. Come quelli previsti dal Green Deal europeo, parte essenziale dell’agenda politica della nuova Commissione europea, che ha promesso di rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro, ovvero a zero emissioni di CO2. Peccato che per farlo si sia deciso concedere miliardi di aiuti all’industria del gas sta continua a promuovere il gas naturale come combustibile “pulito” e si propone come “partner ideale” per il suo utilizzo. È per questo che l’UE sostiene e promuove la realizzazione di nuovi gasdotti presentandoli come “progetti di interesse comune” (PIC), che godono di vantaggi significativi non solo in termini di procedure di approvazione insolitamente rapide, ma anche di aiuti economici: 1,5 miliardi di euro sono già stati assegnati dalla Commissione europea a progetti PCI del gas naturale. A questi si sono aggiunti gli aiuti concessi dalla Banca europea per gli investimenti che ha definito i PIC come una priorità e ha stanziato 2,8 miliardi di Euro per la realizzazione di condutture del Mar Mediterraneo. In totale, per le infrastrutture del gas proposte nei PIC dell’UE sono previsti 45 miliardi di euro, in gran parte per la realizzazione di nuovi gasdotti e terminali per l’importazione di gas naturale liquefatto su navi cisterna.

La realizzazione di questi gasdotti potrebbe rendere l’Europa dipendente dai combustibili fossili più a lungo di quanto si immagina. A dimostrarlo la decisione di sostituire il limite di ridurre le emissioni entro il 2030 (previsto dagli accordi di Parigi) con la promessa di azzerare le emissioni ma non prima del 2050. Una scelta poco di ambientalista e giustificata solo dalla necessità di tempi più lunghi per poter ammortizzare gli enormi investimenti richiesti per la realizzazione degli impianti appena completati nel Mar Mediterraneo. Anche, come ha dimostrato l’ultimo rapporto dell’IPCC, col rischio di un farsi carico di un “vincolo economico e istituzionale in infrastrutture ad alta intensità di carbonio, vale a dire il continuo investimento e l’uso di tecnologie ad alta intensità di carbonio che sono difficili o costose da eliminare gradualmente una volta implementate”.
É questo che sono gasdotti come il TAP e gli atri gasdotti sul fondo del Mar Mediterraneo: un groviglio di tubazioni pericolose (nessuno ha detto cosa succederebbe se una di queste dovesse scoppiare) e potenzialmente inutili che costringeranno i cittadini europei ad utilizzare fonti energetiche “naturali” ma inquinanti e tutt’altro che rinnovabili.












