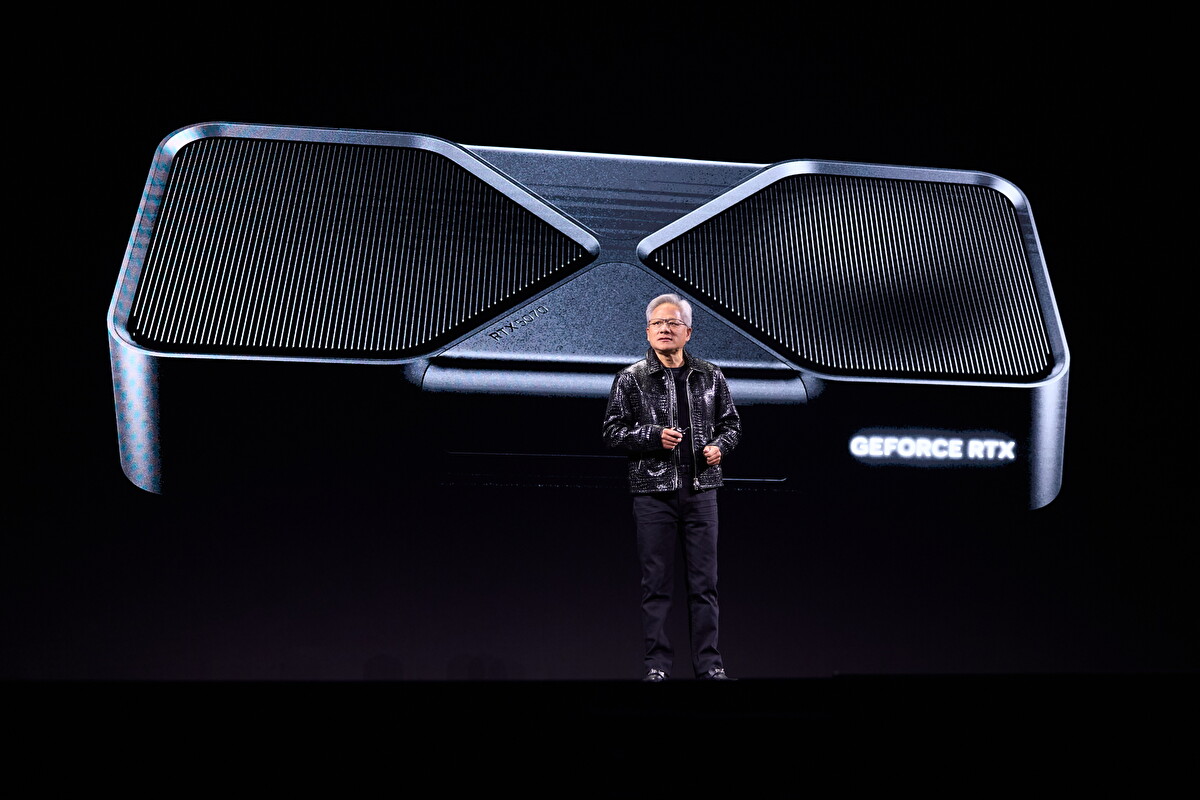Davide Barletti e Lorenzo Conte presentano La guerra dei cafoni al Bif&st, il Festival Internazionale del Film di Bari arrivato alla sua ottava edizione. L’idea del film – nelle sale italiane dal 4 maggio 2017 – è nata dal libro omonimo di Carlo D’Amicis, un racconto di formazione che vede protagonisti da una parte i figli dei ricchi, i signori, e dall’altra i figli di pescatori, contadini, braccianti, ovvero i cafoni. Siamo nella Puglia anni ’70 in un villaggio della costa salentina dal nome evocativo “Torrematta”. Un non-luogo senza asfalto, auto né palazzi e senza adulti, fatta eccezione per Claudio Santamaria e Ernesto Mahieux, che compaiono nei primi minuti del film per ricordare, addirittura in greco bizantino, che tutto è iniziato nel Medioevo, quando si profila per la prima volta una sorta di lotta di classe degli umili contro i potenti.
La guerra dei cafoni offre interamente la scena a una ventina di adolescenti, chiamati non solo a riempire uno schermo, ma anche a formarsi come uomini adulti attraverso l’esperienza della recitazione. “La produzione ha fatto una scelta coraggiosa – ci hanno spiegato i registi – realizzare un vero laboratorio di formazione psico-educativo e attoriale. Per imparare il mestiere del cinema, i giovani protagonisti, selezionati dalla strada attraverso un faticoso e lungo lavoro di casting, hanno vissuto a stretto contatto per due mesi senza la presenza dei genitori”.

A guidare la banda dei benestanti c’è il fascinoso Francisco Marinho/Maligno il Signore dei Signori interpretato dal barese Pasquale Patruno, mentre Donato Palermo è il torvo Scaleno, il capo dei cafoni. Ogni estate si affrontano per conquistare il territorio, il mare, una partita a flipper, la spiaggia, le ragazze. Al divario sociale si somma anche quello linguistico. I signori parlano un italiano perfetto, mentre i cafoni si esprimono in uno strettissimo dialetto, intellegibile grazie ai sottotitoli in italiano.
“Il film prova a rileggere un’epoca ormai stereotipata”, precisa Barletti, di origine salentina. “Gli anni ’70 non sono solo pantaloni a zampa d’elefante e telegiornali d’epoca che parlano del sequestro Moro, ma un abito mentale che faceva degli italiani (perfino dei piccoli, marginali italiani di questo film) delle persone diverse da quelle di oggi, con un sistema di valori e con un’idea dei rapporti personali e sociali assai specifica”.
L’Italia tra gli anni ’50 e ’60 conobbe un periodo di crescita economica accelerata (che sarà soprannominata il “miracolo economico” o, ancora più sinteticamente, “il boom”), che ne trasformò in maniera profonda il volto, trasformandola da un Paese con un’economia prevalentemente agricola in una delle principali potenze industriali dell’Occidente.
Nella concezione di questi quattordicenni, la realtà è caratterizzata da una linea divisoria che separa i ricchi dai poveri, i signori dai cafoni. In quell’estate, però, i cafoni decidono di ribellarsi alla supremazia dei signori: i simboli del potere vengono presi di mira e poi letteralmente attaccati. Così mentre i giovani si affacciano alla vita adulta, alle spalle di tutti i protagonisti di questa storia, muore un’epoca, quella in cui si era convinti che lo sviluppo avrebbe risolto le differenze sociali.

La guerra dei cafoni è ben realizzato, è commovente quando serve e si propone attraverso i toni della commedia come una potente allegoria del passaggio dall’Italia di ieri, caratterizzata al Sud dal sistema del latifondo, dove i grandi proprietari terrieri sfruttavano il lavoro dei braccianti, a quella di oggi, dominata dai consumi, dall’ambizione e dove la crisi sociale ha frammentato e disconnesso la forza-lavoro.
Ma ha più senso parlare di lotta di classe? Intellettuali di sinistra come Chantal Mouffe e Jean-Claude Michea recentemente hanno dichiarato che il concetto di lotta di classe deve essere ripensato. Gli stravolgimenti socio-economici del capitalismo finanziario, la distruzione del welfare e le tecnologie digitali che stanno trasformando l’industria e il mercato del lavoro sono lì a dimostrarlo. Dal conflitto di classe siamo così passati a una serie di gruppi sociali posti in contrapposizione. Ad esempio, laici contro cattolici, giovani contro vecchi, precari contro lavoratori garantiti, lavoratori immigrati contro residenti, esclusi contro inclusi. Per dirla con Zygmunt Bauman: addio umanità, schiavizzata da un’élite di parassiti.
“Alla fine, che la si veda dalla parte dei signori o da quella dei cafoni, diventa l’indistinto, il vuoto, il senso di disappartenenza l’oggetto di questa guerra”, rivelano Conte e Barletti. “I protagonisti della storia sono in guerra soprattutto contro la finta riconciliazione delle diverse appartenenze, contro il politicamente corretto, contro l’ipocrita acquiescenza delle coscienze”.
Come si fa a non essere d’accordo con l’economista e filosofo Lapo Berti quando dice che il conflitto fa anche parte del normale metabolismo sociale, attraverso cui la società nel suo insieme trova di volta in volta i propri equilibri transitori? In una democrazia sana il conflitto è il costo che dobbiamo pagare perché essa viva.
È forse quello che sta accadendo in Francia? I risultati del primo turno delle elezioni presidenziali mostrano chiaramente che gli operai hanno votato per la candidata populista di destra Marine Le Pen, mentre la maggior parte dei francesi che appartengono alla categoria dei professionisti del terzo settore o svolgono le cosiddette professioni intermedie hanno votato per l’ex banchiere Emmanuel Macron.