
Abbiamo intervistato Pietro Trifone, professore ordinario di Storia della lingua italiana nell’Università di Roma Tor Vergata, per sapere a quale posto si colloca l’italiano nella classifica delle lingue più studiate nel mondo. Nel 2010 il professor Trifone ha condotto l’indagine, Italiano 2010 con Claudio Giovanardi, per il Ministero degli Affari Esteri, documentata nel volume L’italiano nel mondo, pubblicato nel 2012. L’indagine ha contribuito a far conoscere la condizione dell’italiano all’estero negli Istituti Italiani di Cultura e nelle università e avevano dimostrato che l’italiano si collocava tra le prime cinque lingue più studiate dopo l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco, e l’ascesa del cinese.
La sua attività di ricerca abbraccia diversi ambiti, dall’analisi delle strutture grammaticali dell’italiano contemporaneo alla storia della lingua letteraria e comune, con particolare attenzione ai rapporti tra mutamento linguistico e realtà sociale. Trifone ha messo in risalto l’importanza di tradizioni linguistiche e culturali alternative facendo studi sul teatro, sulla stampa popolare, sulle scritture irregolari dei semi-alfabeti, e sui filoni eccentrici della letteratura italiana. Al professor Trifone si deve anche la scoperta dell’unica confessione di una “strega” del Cinquecento scritta di proprio pugno dalla stessa interessata e non trasmessa attraverso un verbale giudiziario.
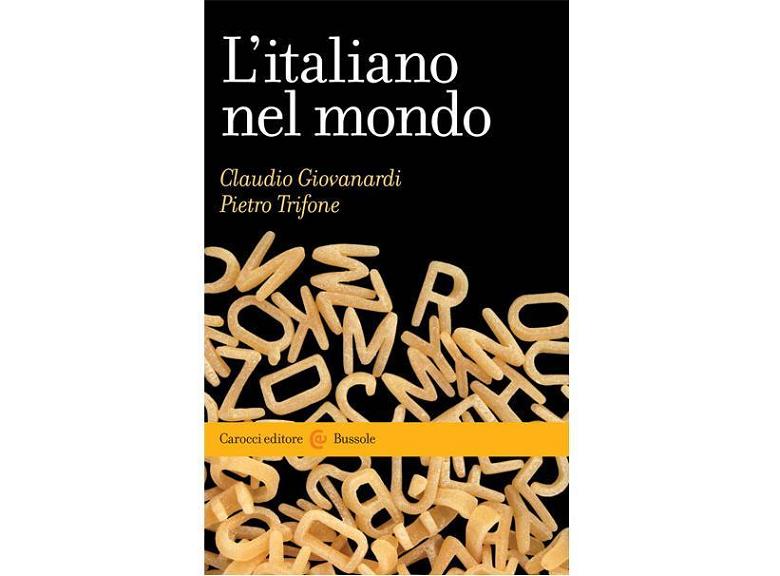 Trifone è membro di varie associazioni di studiosi e accademie, tra cui l’Accademia della Crusca, l’Accademia dell’Arcadia, e l’Istituto Nazionale di Studi Romani. Trifone è anche condirettore delle riviste La lingua italiana. Storia, strutture, testi, e Carte di viaggio Studi di lingua e letteratura italiana. Durante la sua illustre carriera Trifone è stato rettore dell’Università per Stranieri di Siena dal 1996 al 2004 ed è autore di numerosi libri, tra questi ricordiamo: Malalingua L’italiano scorretto da Dante a oggi (2007); Storia linguistica di Roma ( 2008); Storia linguistica dell’Italia disunita (Il Mulino, 2010); La lingua del teatro (2015, con Claudio Giovanardi), Pocoinchiostro. Storia dell’italiano comune (2017); ha curato i volumi Lingua e identità; Una storia sociale dell’italiano (II ed. 2009), e Città italiane, storie di lingue e culture (2015). Con Maurizio Dardano ha scritto una grammatica di riferimento della lingua italiana, e con Luca Serianni ha curato Storia della lingua italiana in tre volumi.
Trifone è membro di varie associazioni di studiosi e accademie, tra cui l’Accademia della Crusca, l’Accademia dell’Arcadia, e l’Istituto Nazionale di Studi Romani. Trifone è anche condirettore delle riviste La lingua italiana. Storia, strutture, testi, e Carte di viaggio Studi di lingua e letteratura italiana. Durante la sua illustre carriera Trifone è stato rettore dell’Università per Stranieri di Siena dal 1996 al 2004 ed è autore di numerosi libri, tra questi ricordiamo: Malalingua L’italiano scorretto da Dante a oggi (2007); Storia linguistica di Roma ( 2008); Storia linguistica dell’Italia disunita (Il Mulino, 2010); La lingua del teatro (2015, con Claudio Giovanardi), Pocoinchiostro. Storia dell’italiano comune (2017); ha curato i volumi Lingua e identità; Una storia sociale dell’italiano (II ed. 2009), e Città italiane, storie di lingue e culture (2015). Con Maurizio Dardano ha scritto una grammatica di riferimento della lingua italiana, e con Luca Serianni ha curato Storia della lingua italiana in tre volumi.
Prof. Pietro Trifone, lei ha diretto una ricerca sulla diffusione dell’italiano nel mondo, secondo i suoi dati quanti studenti lo studiano e a quale posto si qualifica l’italiano?
“Le nostre istituzioni nazionali tendono ad accreditare l’idea che l’italiano sia oggi la quarta lingua straniera più studiata al mondo, dopo l’inglese, lo spagnolo e il cinese, e prima del francese e del tedesco. I cultori della nostra lingua sarebbero numerosi anche negli Stati Uniti, dove peraltro il successo dell’italiano non trova conferma da altre fonti, che promuovono il giapponese al quarto posto e fanno retrocedere l’italiano al quinto. Già il censimento eseguito nel 2013 dall’autorevole MLA (Modern Language Association) sull’insegnamento delle lingue straniere nelle università statunitensi registrava un significativo declino dell’italiano, che perdeva più del 10% delle iscrizioni rispetto al 2009, pur continuando a mantenere il quarto posto nella classifica delle lingue più studiate, dopo lo spagnolo, il francese e il tedesco. Ovviamente la quarta posizione tra le lingue straniere studiate nei Paesi anglofoni equivale alla quinta in tutti gli altri, data la generale e incontrastata preminenza dell’inglese nei Paesi non anglofoni. E’ interessante notare che la graduatoria statunitense del 2009 corrisponde perfettamente alla graduatoria mondiale risultante dall’indagine realizzata da me e Claudio Giovanardi nel 2010”.
Secondo la sua ricerca quali sono le motivazioni che spingono gli studenti a scegliere lo studio dell’italiano all’estero? E in quale paese c’è il maggior numero di iscritti nelle classi di italiano?
“Nella nostra inchiesta del 2010 la classifica delle lingue straniere più studiate nel pianeta vede l’italiano tra le prime cinque, preceduto a grande distanza dall’inglese, in gara più combattuta con il francese, lo spagnolo, il tedesco, e davanti a una lingua in forte ascesa come il cinese. Ancora oggi, quanto e più di ieri, la motivazione principale che spinge ad apprenderlo è il legame con una cultura in cui il mondo identifica uno dei vertici della civiltà occidentale. La tradizionale motivazione culturale rimane quindi la nostra carta migliore. Se è vero, per esempio, che in America Latina le radici familiari non smettono di pesare sul piatto della bilancia, mentre in Africa assumono un ruolo di primo piano le prospettive occupazionali, è altrettanto vero che questi moventi e obiettivi più particolari che inducono ad accostarsi all’italiano sono comunque accompagnati e sostenuti anche dagli interessi di tipo culturale e dalle richieste di formazione universitaria.
L’italiano non figura in nessun caso come prima lingua straniera studiata, mentre ottiene il secondo posto in cinque Paesi: tre si trovano in Europa (Austria, Malta, Romania), uno in Argentina (alla pari con il francese), uno in Australia (di nuovo alla pari con il francese). Il buon risultato in queste aree è facilmente spiegabile: in Austria e a Malta la circolazione dell’italiano viene favorita dalla contiguità geografica. In Romania influisce il fenomeno della massiccia immigrazione di rumeni in Italia soprattutto a partire dal 2007, anno in cui questa nazione è entrata a far parte dell’Unione europea. Per l’Argentina e l’Australia vale il discorso già accennato sulla consistente presenza di storiche comunità di immigrati di origine italiana”.
I docenti negli USA dicono che lo Stato italiano dovrebbe destinare maggiori risorse finanziarie per la diffusione della lingua italiana nelle università. Quali sono le sfide maggiori da superare affinché l’italiano sia più sponsorizzato nel mondo accademico USA?
“I dati statistici raccolti dalla citata MLA nel 2016 evidenziano un vero e proprio tracollo delle iscrizioni ai corsi universitari di italiano, che negli USA calano di un ulteriore 20%, passando da 70.892 a 56.743. La nostra lingua subisce quindi il netto sorpasso del giapponese, che conta invece 68.810 iscritti; mentre al sesto posto si piazza il cinese, che si avvicina molto all’italiano con 53.069 iscritti. è un campanello di allarme che gli organismi preposti alle sorti dell’italiano nel mondo farebbero bene a non sottovalutare. Spetta in particolare alle istituzioni italiane individuare le ragioni delle criticità che si stanno manifestando, al fine di prendere iniziative mirate a favorire il loro superamento. Come il mio collega e amico Hermann Haller, sono convinto che bisognerebbe puntare soprattutto sull’ampliamento dell’offerta di lingua italiana nelle High Schools e sul potenziamento della formazione linguistica e glottodidattica degli insegnanti”.

La lingua italiana è una ricchezza ma spesso le strutture politico-istituzionali non colgono le sue potenzialità. Quali suggerimenti può darci per valorizzare di più la nostra lingua italiana all’estero?
“La richiesta di italiano dipende soprattutto da motivi di prestigio culturale, ma non esclusivamente, visto che uno studente straniero su tre sceglie la nostra lingua per scopi professionali, comprendendo tra questi la stessa formazione scolastica e universitaria. Occorre quindi sensibilizzare gli studenti e gli amministratori sull’utilità pratica e sui vantaggi economici derivanti dalle competenze nelle varie lingue straniere, tra cui anche l’italiano. È di fondamentale importanza che le istituzioni politiche accompagnino e sostengano con accresciuto impegno, anche finanziario, la domanda di italiano che continua a salire, dove più dove meno, da ogni parte del pianeta. Ne consegue che i poli di italianità linguistica e culturale nel mondo vanno preservati e se possibile rafforzati, migliorandone l’efficienza e il coordinamento, non solo per tenere fede a imprescindibili esigenze di decoro istituzionale, ma anche perché si tratta di organismi in grado di svolgere un’importante funzione di stimolo e di rilancio dell’economia nazionale”.
Quali sono “i sani condimenti popolari e regionali che insaporiscono il nostro idioma mediterraneo” che Lei afferma di aver voluto riabilitare nel suo libro “Malalingua. L’italiano scorretto da Dante a oggi”?
“Le alternanze e le commistioni di lingua e dialetti trovano da sempre un terreno fertile nella policroma realtà linguistica italiana, ma sembrano conoscere oggi nuove e maggiori ragioni di interesse. Tra le varie motivazioni e finalità della tendenza al recupero dei dialetti, assegnerei un posto di rilievo alla volontà degli scrittori, dei giornalisti e dei semplici parlanti di vivacizzare e rinvigorire un uso medio appiattito sui modelli ripetitivi e incolori dell’imperante codice televisivo e dei suoi derivati. Di qui la fortuna nazionale di parole romane come abbiocco ‘sonnolenza improvvisa’ e sbroccare ‘perdere la brocca, la testa’, o come lo sgroppino settentrionale e l’inciucio meridionale, che indicano rispettivamente un aperitivo alcolico e un accordo segreto. Sono appunto questi i saporosi condimenti popolari e regionali a cui alludevo”.
La lingua cambia ed evolve. Come è cambiato l’italiano al tempo del web e cosa ne pensa degli inglesismi degli italiani?
“Rispondo sinteticamente a queste domande di ampia portata osservando che le preoccupazioni sull’uso della lingua hanno motivo di nascere allorché chi parla o scrive rivela, per un limite culturale prima ancora che linguistico, la difficoltà di passare dagli usi pratici e quotidiani dell’italiano a elaborazioni testuali articolate e complesse, oppure quando applica le modalità di un discorso di tipo tecnico o specialistico a un ambito comunicativo diverso. Una volta, anni fa, rischiò di caderci anche Silvio Berlusconi, con la sua singolare dichiarazione «mia madre dice che non ho il know-how per odiare»; ma forse si trattava di un uso spiritoso del termine know-how, e se fosse così l’inserimento dell’anglicismo tecnico nella frase di registro familiare sarebbe giustificata dalla ricerca di vivacità espressiva. Il ruolo del web, da questo punto di vista, è ambivalente: da un lato la rivoluzione digitale riflette e amplifica la fortuna dei linguaggi più eterogenei; dall’altro permette agli utenti di riconoscere e censurare i loro eventuali limiti, intervenendo con commenti critici o ironici”.












