Sul siciliano scritto e parlato c’è molto interesse da diversi studiosi nazionali ed internazionali, come dimostrano i numerosi libri e saggi che continuano ad essere scritti sia in Italia sia all’estero. Sappiamo che la “Poesia Siciliana”, scritta nel 1230 in siciliano presso la corte di Federico II di Svevia, è la prima documentazione in lingua non latina della letteratura italiana. Gli interpreti della Scuola Poetica Siciliana furono molto attivi nel periodo fra il 1230 e il 1266. Sin da allora possiamo affermare che il siciliano è una lingua che ha resistito nei secoli ed è tuttora presente e vitale nella realtà e nella cultura popolare.
A New York, l’organizzazione culturale Arba Sicula, gestita da Gaetano Cipolla, nel corso degli ultimi 33 anni ha dedicato ogni sua energia alla promozione della lingua e della cultura siciliana nel mondo. Il professore Cipolla non solo ha scritto libri in siciliano, ma ha anche creato un corso “Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu” per studenti americani, un programma che ha attirato l’attenzione di altri studiosi, come il Prof. Alfonso Campisi dell’Università di Tunisi, che nel 2018 ha adattato le lezioni in versione italiano-siciliano.
Per saperne di più su questa antica e intrigante lingua ho intervistato lo scrittore siciliano Marco Scalabrino, poeta, saggista e traduttore con interessi culturali per lo studio del dialetto siciliano e la poesia siciliana. Nato a Trapani, Scalabrino ha tradotto molte opere di autori stranieri contemporanei sia in siciliano che in italiano.
Per lo scrittore, usare il siciliano come lingua di scrittura diviene una scelta di cultura e di stile, un’operazione che riguarda il letterato colto. Alcune delle sue pubblicazioni in siciliano sono: Palori, Aschi e maravigghi; con traduzioni in francese, inglese, italiano, latino, spagnolo e tedesco; Canzuna di vita di morti d’amuri; La casa viola, con traduzioni in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e scozzese. Ha tradotto in siciliano e in italiano Nat Scammacca e nel 2008 ha adattato in italiano la riedizione di Quattru sbrizzi di Salvo Basso.
Scalabrino ha collaborato con periodici culturali, cartacei e in rete, nazionali e internazionali, tra i quali Lumie di Sicilia, Il convivio, Poiein, Parole di Sicilia, Literatura(Brasile), Farapoesia,Terza pagina world, Seixo review, Interromania, Per la Sicilia e Arte e folklore di Sicilia. È stato infine componente della équipe regionale del progetto L.I.R.e.S. promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, per lo studio del Dialetto Siciliano nella Scuola.
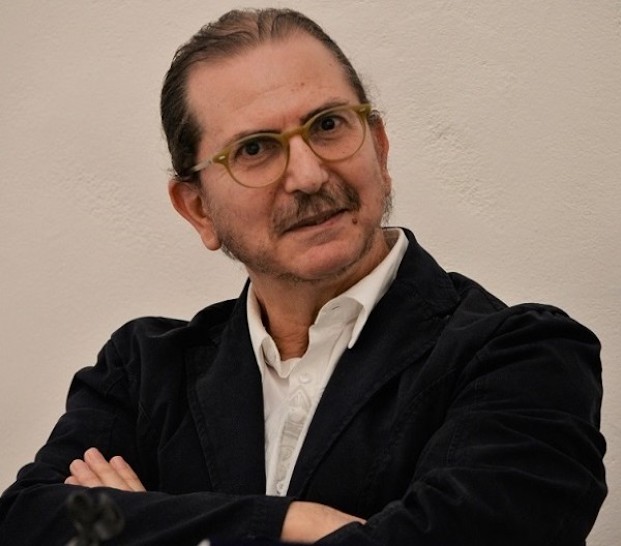
Professore Marco Scalabrino cosa ne pensa del corso “Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu” per studenti americani? Quali possono essere le difficoltà che, secondo Lei, gli studenti affrontano imparando questa antica lingua?
“Professoressa Filomena Sorrentino, ringrazio sentitamente sia Lei che i Suoi lettori per la graditissima attenzione. Lei dice bene allorché definisce “antica lingua” il siciliano. Il siciliano è tuttora un linguaggio che in Sicilia viene adoperato con naturalezza, con proprietà di significato, con il quale gli isolani assolvono egregiamente l’esigenza sociale della comunicazione. Ciò detto, non ci si rende forse più conto – perché magari non ci si interroga in tal senso – che i suoi lemmi, che a pieno titolo fanno parte del nostro odierno parlare, sono antichi di secoli quando addirittura non di millenni. Lucio Apuleio, scrittore siciliano del II secolo d.C., ci tramanda che i siciliani parlavano tre lingue: il greco, il punico e il latino. Ma da allora, e fino al XIX secolo, ne sono passati di “ospiti” sui nostri lidi! Le radici – diciamo così ufficiali – del siciliano affondano nel lontano 424 a. C. con la virtuale costituzione ad opera di Ermocrate della nazione siciliana (“Noi non siamo né Joni né Dori ma Siculi”) e, benché nel tempo si siano avvicendati il greco-siculo, il latino-siculo, l’arabo-siculo, il franco-siculo, l’ispano-siculo, eccetera, sostanzialmente sempre uno, un solo idioma ne è stato a fondamento: il siciliano. E, tuttavia, esso deve fare i conti col proprio ultra-millenario spendersi, col fronte magmatico dei tempi moderni, con l’arrembante tecnicizzazione. “La sua sopravvivenza – ci ammonisce Ottavio Lurati – è legata alla capacità di adeguarsi al mondo che evolve”. Quanto al corso “Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu”, il Prof. Gaetano Cipolla ha fatto un ottimo lavoro, ha realizzato un pregevole strumento didattico destinato sì all’insegnamento nelle scuole, ma che può altresì essere proficuamente utilizzato da quanti al siciliano desiderino comunque avvicinarsi. Le difficoltà ci saranno e saranno le medesime che si presentano a ciascuno di noi ogniqualvolta si appresta a studiare e a imparare una lingua straniera; ma – ripeto – lo strumento didattico è ottimo e gli studenti … ce la faranno”.
Ci può dire se il siciliano parlato dagli emigrati negli States è diverso da quello parlato in Sicilia?
“Io vivo in Sicilia e non negli USA; non ho contezza di quanto Lei mi chiede e nondimeno ritengo di sì! Per la semplice ragione che ogni lingua, notoriamente, viene contaminata dall’ambiente che lo circonda e il siciliano non può sottrarsi a tale ordine naturale”.
Nel 2011 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato una legge che promuove il patrimonio linguistico e la letteratura siciliana nelle scuole. Lei sa se questa iniziativa stia avendo successo nelle scuole siciliane?
“Non è superfluo ribadire – e Lei opportunamente ne riporta la corretta dizione – che la legge regionale siciliana n°9 del 2011 detta le “Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole” e non restringe il campo unicamente all’insegnamento del dialetto. Ciò precisato, zoomando noi sul dialetto, a iniziativa di taluni illuminati docenti, nelle scuole siciliane non è mancata nel tempo la presenza a vario titolo del dialetto o per meglio dire dei dialetti, perché molteplici sono le parlate che esistono e resistono nell’Isola. Pertanto, anche per riappropriarsi un po’ delle proprie radici, agli studenti siciliani un’ora alla settimana di insegnamento della loro storia, della loro letteratura e del loro patrimonio linguistico non potrà di sicuro fare male. Di recente le istituzioni regionali hanno ribadito tale proposito”.
Nel 2018 il Prof. Alfonso Campisi, che insegna all’Università di Tunisi, ha adattato il corso “Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu” in versione italiano-siciliano. Ci può dire la sua opinione su questa iniziativa?
“Conosco di fama Alfonso Campisi. So che nell’Università La Monouba di Tunisi, dove egli è Professore, è stata istituita la “Cattedra Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo di Culture e Civiltà” della quale mi risulta sia il direttore. Il suo odierno adattamento bilingue italiano-siciliano – dall’originario testo inglese-siciliano Learn Sicilian / Mparamu lu sicilianu di Gaetano Cipolla, pubblicato da Legas (2013) negli Stati Uniti – nasce dalla constatazione che in Sicilia le nuove generazioni parlano ormai in prevalenza l’italiano, capovolgendo la situazione di qualche decennio fa allorché il siciliano si parlava comunemente e l’italiano si imparava a scuola”.
Essendo una lingua molto antica da dove discende il siciliano? Dal latino oppure da altre lingue come il greco e l’arabo? Possiamo definirla una lingua sicula-araba oppure un idioma fuso con lingue indo-europee?
“La risposta a questa domanda, in buona misura, è già stata data sopra, ma la questione “Quali sono le origini del siciliano?” è assai intrigante e merita comunque, impone anzi, una ancorché succinta trattazione. Annota Giovanni Ragusa: “I Siculi erano un popolo indo-europeo. Dall’India essi vennero verso l’Europa e quelli che giunsero nella nostra Isola, guidati da Siculo, furono chiamati Siculi. La loro lingua pertanto doveva essere, se non la sanscrita, una che certamente ne derivava. Alcuni vocaboli: il nostro pùtra (puledro) nel sanscrito è pùtrache vuol dire figlio; il nostro màtri non deriva dal latino mater, ma dal sanscrito màtr; il nostro bària(balia) nel sanscrito è bhâryâe vuol dire moglie”. E prosegue: “I Siculi, sottomessi dai Greci, furono costretti per necessità a far proprio il lessico dei dominatori, ma lo espressero con la fonetica che era a essi congenita. Ciò avviene anche a noi che, dovendo parlare l’italiano, lo esprimiamo (foneticamente e sintatticamente) come ci è naturale; e ciò fa sì che veniamo riconosciuti “siciliani” in ogni luogo e da tutti. Sappiamo che la nostra lingua ha, come il sanscrito e le lingue semitiche che ne sono derivate, soltanto vocali a, i, u. Sappiamo che la lingua siciliana rifiuta in modo assolutola “e” e la “o”atone. Sappiamo anche che ha suoni cacuminali non esistenti nel latino (ggh, dd, tr, str) e che si esprime con regole diverse da quelle delle lingue latina e italiana. Di essa non dobbiamo vergognarci, perché non ci rivela, come dicono i concittadini del Nord Italia, terroni, ma gente di antica e nobile civiltà””.
Secondo Lei, la lingua siciliana dovrebbe essere riconosciuta come patrimonio culturale del popolo siciliano e dell’umanità? E perché?
“Prima di formulare la risposta a questa domanda (e anzi giusto per darvi maggiore vigore) cogliamo l’opportunità per registrare, oltre al volume di cui alla nostra odierna dissertazione, talune altre importanti opere sul medesimo argomento: la ben nota Grammatica Siciliana di Giuseppe Pitrè del 1875, la Introduction to Sicilian Grammar di J. Kirk Bonner del 2001, la Grammatica Siciliana di Salvatore Camilleri del 2002, i volumi Sicilian the oldest romance language di Joseph F. Privitera del 2004 e Per lo studio del siciliano di Rosalba Anzalone del 2006. Questi studi dimostrano irrefutabilmente quanto l’interesse degli studiosi, nazionali e internazionali, sia tuttora vivissimo nei confronti del siciliano e al contempo quanto questo sia tuttora presente e vitale nella realtà e nella cultura del popolo siciliano, sia tuttora parlato e capito dalla grande maggioranza degli isolani. D’altronde, per venire adesso alla Sua domanda, l’importanza del siciliano trova implicita consacrazione a motivo della sua collocazione nel rapporto ATLAS del 2009, relativo alla “salute” delle lingue del mondo, rapporto il quale ha situato il siciliano nella V categoria, quella ossia delle “lingue vulnerabili”, rimarcandone il peggioramento rispetto alla precedente posizione rilevata nel Libro Rosso dell’UNESCO del 1999, che il nostro idioma aveva incluso nella VI categoria, ovvero “Lingue non in pericolo [di estinzione] con una trasmissione sicura alle nuove generazioni”. L’essere esso stato riconosciuto dall’UNESCO e dagli studiosi più avvertiti quale “patrimonio linguistico” mi pare un ottimo motivo, no?”
Dante ha vissuto in un periodo quando la Sicilia aveva molto prestigio e all’epoca il volgare siciliano fu il primo delle varie parlate dell’area italica a prendere forma scritta a scapito del latino. Ci può dire perché la poesia siciliana non è studiata nelle università alla pari di quella toscana?
“Con la domanda appena posta, Lei fa sì di rievocare a me stesso e ai nostri lettori che il siciliano fu la prima delle lingue regionali d’Italia a guadagnarsi la qualifica di lingua di poesia. Nella prima metà del tredicesimo secolo infatti, i poeti che appartennero alla Scuola Poetica Siciliana, tanti di loro non nativi della Sicilia, scrissero nel linguaggio parlato a Palermo alla corte imperiale, la Magna Curia, di Federico II. Fu esso, quindi, il linguaggio usato per redigere gli atti ufficiali del parlamento siciliano fino alla metà del 16.mo secolo, allorché il toscano gli subentrò. Vale dunque il caso di rammentare, giacché Lei a buon diritto lo tira in ballo, che il sommo Dante, nel De Vulgari Eloquentia, attestò che “tutto ciò che gli italiani poeticamente compongono si chiama siciliano”; che nella Sicilia del Cinquecento operavano due Università, quella di Catania e quella di Messina; che nel 1543 il siracusano Claudio Mario Arezzo propose di istituire “il siciliano come lingua nazionale”; che il siciliano può vantare vocabolari, non ultimo il monumentale in cinque volumi a cura di Giorgio Piccitto, Giovanni Tropea e Salvatore C. Trovato, testi di Ortografia, di Grammatica, di Critica, come pure autori di levatura assoluta. Ciò detto il siciliano ha “semplicemente” mancato l’appuntamento con la Storia a favore del fiorentino di Dante e della sua Commedia, da Boccaccio poi appellata “Divina”.”
Il Prof. Giovanni Ruffino in una mia intervista dice che il siciliano non si dovrebbe chiamare “lingua” e che il termine “dialetto” secondo lui è più appropriato. Lei è d’accordo su questo con il Prof. Ruffino?
“All’interrogativo secco “il siciliano è lingua o dialetto?” reputo opportuno abbinare – al fine di approfondire – quell’altro che viene posto sovente da taluni: “non esistendo un siciliano codificato nel quale scrivere, ha senso dannarsi sulla corretta trascrizione delle parole?” Premesso che il termine dialetto è voce ripresa dal tardo latino dĭălectŏs, prestito dal greco διάλεκτος, letteralmente colloquio, parlare ordinario, pronuncia particolare, che esso è cioè una varietà linguistica usata da abitanti originari di una particolare area geografica, affrontiamo complessivamente i due quesiti, tramite le autorevoli valutazioni di Mario Sansone e di Salvatore Camilleri: 1) dal punto di vista glottologico ed espressivo non c’è alcuna differenza essendo la lingua letteraria un dialetto assurto a dignità nazionale e a un ufficio unitario per complesse ragioni storiche; 2) il siciliano, con la poesia alla corte di Federico II, è stato determinante per la nascita della poesia italiana; 3) il siciliano è stato strumento letterario di poesia e di prosa: nella seconda metà del sec. XV diede vita alle Ottave o Canzuni, nel sec. XVIII a un autentico poeta come Giovanni Meli e nel XIX secolo a Nino Martoglio, ad Alessio Di Giovanni, al Premio Nobel Luigi Pirandello. Riportiamo oltre a ciò l’avviso di Guido Barbina: “Tralasciamo, perché puramente accademico e fuorviante, il pretestuoso problema della differenziazione fra lingua e dialetto”, e un passo tratto dal pezzo Le lingue minoritarie parlate nel territorio dello Stato italiano di Roberto Bolognesi: “Tecnicamente i termini lingua e dialetto sono interscambiabili … il loro uso non implica nessuna precisa distinzione genetica e/o gerarchica. Tutti i cosiddetti dialetti italiani sono lingue distinte e non dialetti dell’Italiano”. “Il dialetto – assevera Salvatore Riolo – non è una corruzione né una degenerazione della lingua e non potrebbe mai esserlo, perché i dialetti non sono dialetti dell’italiano, non derivano cioè da esso ma dal latino e soltanto di questo potrebbero eventualmente essere considerati corruzione”. Ulteriori considerazioni potrebbero passare attraverso la presenza di Vocabolari, di testi di Ortografia, di Grammatica, di Critica, eccetera. Tanto per enunciare che il siciliano, se proprio vogliamo impuntarci su questo termine, potremmo appellarlo lingua, giacché ne ha tutta la dignità; l’appellarlo, tuttavia, dialetto nulla gli sottrae e niente affatto lo sminuisce”.
Oggi il siciliano si usa solo in privato o in famiglia e non si adopera in pubblico o nei rapporti ufficiali; è forse questo che tende a smantellarne l’uso tra i giovani?
“Mi consenta di aggiustare un po’ il Suo tiro. Il siciliano è tuttora in Sicilia lingua vivissima di Poesia! È inoltre diffusissimo e proprio delle rappresentazioni di teatro tradizionale e popolare; è felicemente integrato nel cinema, nelle fiction televisive, nella pubblicità; è infine cifra corrente delle canzoni di tanti artisti e gruppi neo-etnici. È pacifico che nella parlata dei giovani di oggi tante commistioni di linguaggio finiscono per confluire e funzionalmente integrarsi: l’italiano, l’inglese, il telematico in massima parte. Ma nel loro conversare amicale il dialetto siciliano torna con prepotenza a riguadagnare il suo ruolo di strumento primario della comunicazione, della trasmissione dei sentimenti, della ancestrale autenticità, ruolo che spesso i ragazzi non disdegnano di spendere anche in famiglia. La ragione che adduce Lei è ben oggettiva, è una attendibile concausa, è una palpabile congiuntura, ma la realtà delle cose – a mio avviso – è assai più complessa e nel contempo assai più semplice ed è legata all’ineluttabile volgere dei tempi. Grazie.”












