L’Ambasciata italiana e l’Istituto Italiano di Cultura mi mandano di tanto in tanto inviti ad eventi scientifici e culturali presso la nostra prestigiosa sede diplomatica a Washington DC. Arrivare dal mio ufficio di Reston, Virginia, a Whitehaven Street richiederebbe meno di mezz’ora, se non fosse che i tempi raddoppiano durante le rush hour, spesso facendomi pentire di aver ceduto alle lusinghe dei nostri addetti scientifici e culturali “dispiegati” in USA. Ieri, 17 Ottobre, non mi sono pentito. E non perché non ci fosse traffico (c’era, eccome!), ma perché la presentazione si preannunciava di sicuro interesse e non ha tradito le attese.
Il titolo della presentazione era “L’Italiano è la lingua dei doppiatori” e il curriculum della presentatrice, Caterina d’Amico, era francamente impressionante: da CEO di RAI Cinema a ruoli di rilievo nell’industria cinematografica internazionale, alle amicizie con gli attori e i registi che hanno definito il cinema italiano degli ultimi 80 anni.
Questa si presentava come l’occasione per colmare certe mie lacune su film neorealisti italiani che io, cresciuto con i film di Hollywood doppiati, non avevo mai guardato, oppure avevo guardato solo distrattamente, non avendo gli strumenti per coglierne il valore reale. Infatti, tre erano sempre stati, ai miei occhi, i problemi dei film del neorealismo italiano: il fatto che fossero in bianco e nero e con audio di scarsa qualità, il fatto che fossero spesso girati in dialetto e, soprattutto, il fatto che si trattasse per lo più di storie incredibilmente tristi (e quindi deprimenti) della guerra o di disastratissimi dopoguerra.
Mi chiedevo: ma se il cinema non è divertimento, che senso ha?
Alcune risposte sono arrivate dalla lecture della Dottoressa d’Amico, che è partita parlando dei film muti con le didasacalie redatte da Gabriele D’Annunzio, per poi passare ai primi film italiani non-muti realizzati negli anni ’30 (“La Canzone dell’Amore”). La d’Amico ha spiegato come Mussolini e il regime fascista avessero identificato nel cinema lo strumento principe per rendere l’italiano la lingua comune di una nazione. Fino a quel momento, solo il 2,5% della popolazione, prevalentemente a Firenze, vedeva nell’italiano la propria lingua. Tutti gli altri parlavano il loro dialetto. Il cinema ai tempi del regime ebbe l’incarico di insegnare l’italiano, imponendo una lingua comune alla nazione.
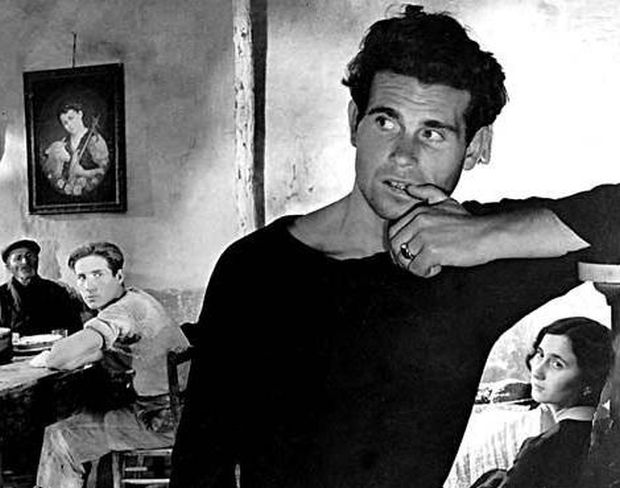
Naturalmente il Fascismo aveva tutto l’interesse a proiettare un’immagine rassicurante del paese. Tutto e tutti apparivano rifiniti, benestanti e borghesi nel cinema dei “telefoni bianchi”, con riferimento ai telefoni bianchi che si vedevano sul grande schermo, ma che nessuno realmente possedeva all’epoca. Gli attori arrivavano immancabilmente dal teatro per garantire recitazione di qualità e perfetta dizione. Un esempio su tutti “Gli uomini che mascalzoni” che ha lanciato De Sica senior (e ci ha lasciato la famosa “Parlami d’amore, Mariù”).
Con l’arrivo della seconda guerra mondiale cambia un po’ tutto. Non c’è più l’ordine superiore di ridere. Non c’è la necessità di presentare esclusivamente situazioni leggere e fasulle. Spiega la d’Amico che la gente vuole vedere al cinema una realtà in cui si può riconoscere. Questo apre la strada a film quali quelli di Rossellini, “Roma Città Aperta” prima e “Paisà” poi. Lì si vedono per la prima volta attori non professionisti che parlano dialetto. Paisà è fatto da sei episodi, ognuno dei quali si svolge in una regione d’Italia diversa in cui si parlano dialetti diversi. La d’Amico ammette che quel genere di film non fu inizialmente un grande successo in Italia, anche perché la gente non li capiva. Ironicamente, la situazione era migliore all’estero dove i film neorealisti erano proiettati con i sottotitoli e quindi “comprensibili” da parte del pubblico.
È l’inizio del Neorealismo, anche se il termine Neorealismo è arrivato col film “Ossessione” di Luchino Visconti. A questo punto la presentatrice racconta di Scorsese che si accorse del Neorealismo sentendo gli italoamericani di Little Italy a New York raccomandarsi a vicenda i film gridando dalle finestre di casa, segno di un nuovo tipo di cinema in cui finalmente la gente si riconosceva. Fu quello il momento in cui ci si rese conto che la tecnologia dei fratelli Lumiere poteva percorrere due strade: quella del sogno e della fantasia e quella della documentazione e del realismo.
In tutto questo, però, continuava a rimanere un problema di fondo. Che lingua fare parlare agli attori nei film italiani? Era chiaro che il dialetto non fosse comprensibile a livello nazionale. Ma il ricorso all’italiano, la lingua degli alto borghesi, non era compatibile con le necessità di un cinema neorealista (con l’eccezione di Antonioni, chiosa la d’Amico). Nel film del ’48 “La Terra Trema”, gli attori non professionisti parlano un dialetto stretto a cui si provò ad ovviare con una voce di attore fuoricampo (Mario Pisu) che spiegava la scena prima che si svolgesse. Anche questo esperimento non fu coronato da particolare successo.
La soluzione fu trovata doppiando gli attori. Magari questi ultimi erano ancora dei non professionisti, ma, una volta al cinema, le loro voci erano state sostituite da quelle di attori professionisti. Anziché il dialetto, i doppiatori parlavano un italiano che del dialetto di riferimento conservava solo alcune espressioni e cadenze, rendendo quindi i protagonisti finalmente intellegibili ad un paese intero. La presentatrice mostra un brano del film “Ladri di Biciclette” in cui un attore non professionista ha la voce riconoscibilissima di un non ancora famoso Alberto Sordi.
Ancora più significativi sono gli estratti dal film “La Grande Guerra” (Mario Monicelli) in cui tutti attori professionisti parlano dialetti diversi, ma tutti in qualche modo “falsi” in quanto comprensibili da qualsiasi italiano. Solo più tardi arriverà una generazione di attori italiani, quali Volontè e Giannini, che metteranno nello studio dei dialetti una passione quasi maniacale, ci spiega la d’Amico.
Nel 1954 arriva la televisione. Siamo davanti a un’altra svolta epocale. Assumendo ora la TV su di sé il compito di insegnare l’italiano agli italiani, il cinema é finalmente libero di tornare ai dialetti a suo piacimento. È questo che permette l’affermarsi di attori regionali (toscani, pugliesi, siciliani, napoletani, ecc…) sul sipario nazionale. Il dialetto esprime ora identità: Fellini, Olmi, Tornatore sono i nomi dei registi che incarnano meglio questa nuova situazione. “Amarcord” è il film preso a esempio di questo periodo dalla presentatrice.
Nel frattempo, spiega ancora la lecturer, si osserva anche un’altra trasformazione. Mentre inizialmente il film in dialetto o simil-dialetto era un fenomeno legato essenzialmente ad un mondo cinematografico gestito dalla sinistra, si comincia a osservare come il dialetto arrivi ora a essere simbolo di identità, di appartenenza e quindi, essenzialmente, un simbolo conservatore e di destra. Mi sarebbe piaciuto approfondire questo discorso, ma non era il caso in un contesto in cui gli astanti erano prevalentemente statunitensi e si parlava inglese.
A che punto è arrivato oggi il rapporto tra lingua e film? Oltre alle situazioni già descritte, si vede con chiarezza che il dialetto è quasi obbligato nei gangster movie italiani. L’esempio riportato è quello del film “Gomorra”. A domanda specifica, la d’Amico non spiega bene il perché, forse perché non vuole apparire poco politically correct davanti a un pubblico in maggioranza statunitense.
Per me che sono italiano la spiegazione è ovvia (e coerente con quanto ha già spiegato l’esperta): può essere credibile un criminale che parla l’Italiano corretto di chi ha completato con successo almeno un paio di cicli scolastici? “Ma che cazzo stai addì?” reagirebbe il Dandy di “Romanzo Criminale”, l’ultima ottima serie TV italiana che ho visto prima di trasferirmi in USA alcuni anni fa.
Torniamo alla lecture. Se i film italiani ricadono sempre in un qualche tipo di dialetto, quali film parlano il vero italiano puro e pulito? La risposta a questa domanda la offre la d’Amico chiudendo il cerchio: “L’italiano puro e pulito è quello dei film stranieri doppiati!”.
Come volevasi dimostrare: “L’Italiano è il linguaggio parlato dai doppiatori”.












