E’ il 6 dicembre 1952. Beppe Fenoglio, già da qualche anno in contatto con Italo Calvino, scrive da Alba a Elio Vittorini, che lavora tra Torino e Milano. Calvino e Vittorini pubblicano con Einaudi: leggono e soppesano con attenzione i manoscritti che arrivano alla casa editrice. Sono prodighi di consigli e suggerimenti, elaborano schede, dirigono collane. “Esaminatori” di peso; si chiamano Attilio Bertolucci, Calvino, Pietro Citati, Natalia Ginzburg, Cesare Pavese, Vittorini: le loro sono fitte riunioni con lunghe discussioni, e scambi di relazioni, lettere dense di giudizi: un materiale prezioso per gli studiosi, “racconta” l’evoluzione e la “maturazione” di tanti autori del ‘900 letterario italiano; il come e il perché certi libri sono valorizzati, altri invece sacrificati, pur se il loro pregio viene riconosciuto; gli intuiti e le capacità rabdomantiche di individuare talenti, e anche le “cantonate” (più d’una, per esempio, ne prende Vittorini, qualcuna forse, volutamente).
Fenoglio e Calvino col tempo entrano in confidenza, anche se ci vorrà tempo, prima di passare dal “Signor Calvino” al “Caro Calvino” e infine al “Caro Italo” (idem per quel che riguarda il “Caro Fenoglio”, e poi “Caro Beppe”).
Per tornare alla lettera a Vittorini (che per Einaudi cura personalmente la collana dei “Gettoni”: 58 volumi, due di Fenoglio: “I ventitrè giorni della città di Alba”, nel 1952; “La malora, nel 1954): Fenoglio lo ringrazia per averlo informato di una recensione di Giovanni Bonalumi alla “Radio di Lugano”, e di un lusinghiero giudizio di Gianfranco Contini. Aggiunge poi, come se la cosa fosse per lui di marginale interesse: “Non so a quali attacchi Ella alluda: di che si tratta? Io ne sono perfettamente all’oscuro…” (ma qualche informazione gli è pur giunta, tramite l’amica scrittrice Anna Banti, che lo difende).
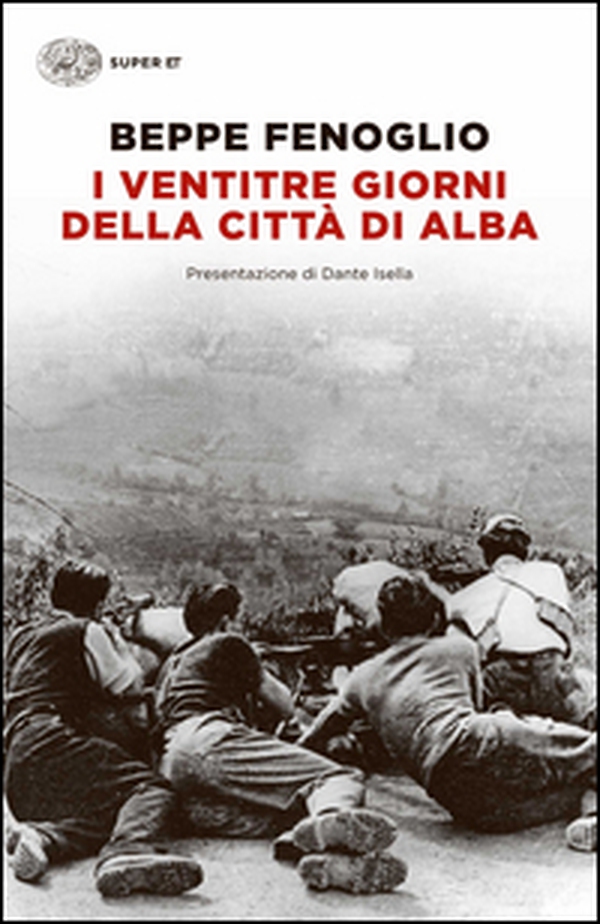 Sono attacchi, informa Vittorini in una lettera del 6 maggio 1953, “tutti di parte comunista”; sono apparsi sulle quattro edizioni in cui allora viene stampata l’Unità; in successione, scritti da mani diverse ma di analogo contenuto: il 12 agosto 1952 sull’edizione torinese; il 3 settembre in quella romana; il 13 settembre nella genovese; infine il 19 ottobre nella milanese. Prendono di mira “I ventitrè giorni della città di Alba”. Un attacco feroce: “un gioco di parole, e di brutte parole…un gioco che può essere facilitato dalla novità che consiste nel fatto di vedere le cose dall’altra sponda”… Fenoglio sarebbe colpevole di aver assunto un’ottica simile a quella di chi ha combattuto con i repubblichini di Salò. Velenosissima accusa: Fenoglio, dopo l’8 settembre combatte fascisti e nazisti; prima si aggrega con le brigate Garibaldi; ma i comunisti gli stanno stretti: non combatte i “neri” per poi farsi mettere la mordacchia dai “rossi”; raggiunge con gli “autonomi” del Gruppo Divisioni Alpine comandate dal maggiore Enrico Martini “Mauri”, che opera nelle Langhe, tra Mango, Murazzano e Mombarcaro.
Sono attacchi, informa Vittorini in una lettera del 6 maggio 1953, “tutti di parte comunista”; sono apparsi sulle quattro edizioni in cui allora viene stampata l’Unità; in successione, scritti da mani diverse ma di analogo contenuto: il 12 agosto 1952 sull’edizione torinese; il 3 settembre in quella romana; il 13 settembre nella genovese; infine il 19 ottobre nella milanese. Prendono di mira “I ventitrè giorni della città di Alba”. Un attacco feroce: “un gioco di parole, e di brutte parole…un gioco che può essere facilitato dalla novità che consiste nel fatto di vedere le cose dall’altra sponda”… Fenoglio sarebbe colpevole di aver assunto un’ottica simile a quella di chi ha combattuto con i repubblichini di Salò. Velenosissima accusa: Fenoglio, dopo l’8 settembre combatte fascisti e nazisti; prima si aggrega con le brigate Garibaldi; ma i comunisti gli stanno stretti: non combatte i “neri” per poi farsi mettere la mordacchia dai “rossi”; raggiunge con gli “autonomi” del Gruppo Divisioni Alpine comandate dal maggiore Enrico Martini “Mauri”, che opera nelle Langhe, tra Mango, Murazzano e Mombarcaro.
Il recensore, anonimo, conclude la sua stroncatura accusando Fenoglio di “impudenza e pubblicare e diffondere questo tipo di letteratura significa non solamente falsare la realtà, significa sovvertire i valori umani e distruggere quel senso di dirittura e onestà morale di cui la tradizione letteraria italiana può farsi vanto… Noi non sappiamo se questo mestiere (il procuratore in una ditta vinicola, ndr) lo esercita onestamente oppure vende del vino annacquato. Certo è che in fatto di racconti non possiamo parlare di onestà”. Non manca la vera e propria intimidazione: “Stupisce che un editore come Einaudi pubblichi roba del genere, con partigiani che stanno tra la caricatura e il picaresco”.
Lo stesso giorno Davide Lajolo, piemontese come Fenoglio (ma di Vinchio), anche lui un passato di partigiano, scrittore e dirigente del PCI, direttore dell’edizione milanese de l’Unità, annota sul diario: “Ho letto ‘I ventitrè giorni della città di Alba’ di Fenoglio. Non mi è piaciuto. Mentre perdura la propaganda antiresistenziale e i partigiani vengono buttati in carcere come delinquenti, questo racconto di Beppe che ha fatto la Resistenza accanto a me, sulle Langhe, mi è parso aiutare chi s’affanna a denigrarci. Noi garibaldini avevamo osteggiato la decisione di Mauri, il comandante dei badogliani, di voler occupare la città di Alba. Le nostre forze partigiane non erano ancora in grado di difendere la città e avremmo certo riperduto portando scoramento nei combattenti e nella popolazione, come sosteneva Fenoglio in quelle pagine. Ma perché descriver l’occupazione come una carnevalata? I partigiani come soldati di ventura e l’abbandono delle città come una fuga di fronte ai fascisti? Ho scritto un articolo sul libro con tono aspro”.
Sul momento, stroncatura senza appello. Una ventina d’anni dopo Lajolo si cosparge il capo di cenere; si riaccosta a Fenoglio con ben altro approccio; scriverà: “In un primo tempo…eravamo tra quelli che si sono adontati e non riconoscemmo in Fenoglio il cantore della Resistenza…”.
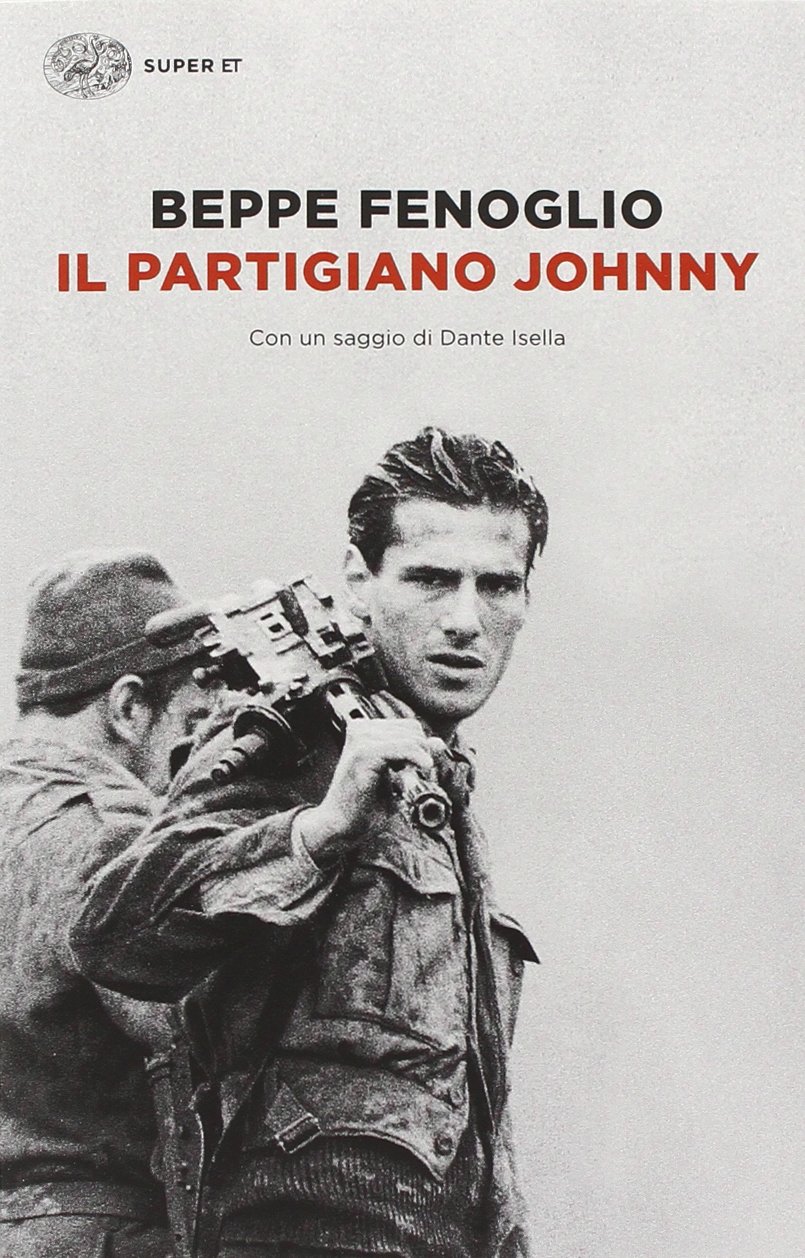 Figurarsi se non si può mutare d’opinione. Tuttavia il “caso” di Lajolo presenta aspetti che legittimano qualche riflessione sugli umani comportamenti. Fenoglio è sempre stato antifascista: per Mussolini e il regime non ha mai nutrito simpatia, fin da adolescente. Lajolo al contrario non disdegna d’esibire la camicia nera. Si iscrive al GUF, partecipa volontario alla guerra di Spagna dalla parte dei franchisti; nella sua biografia anche l’esser stato vice-segretario federale del Partito Fascista ad Ancona, fino al 25 luglio 1943. Dunque non una cosa passeggera. Solo dopo l’8 settembre (non è più un ragazzino che ha preso un abbaglio, ha già 31 anni) si unisce ai partigiani, e milita attivamente nel PCI; un suo libro del 1963, nel quale fa un po’ di conti con se stesso, non per un caso lo intitola “Il voltagabbana”. Per farla breve: l’ex fascista, diventato comunista, su l’Unità del 1952 accusa Fenoglio, antifascista da sempre, di mostrare le cose “dall’altra sponda”. Su l’Unità del 10 ottobre 1978 il comunista ormai messo ai margini dal partito, elogia Fenoglio, autore di libri “più vivi, più semplici, più reali di tutta la letteratura partigiana”. Fine. Il cerchio si chiude; sarebbe da riderne, sia pure con amarezza.
Figurarsi se non si può mutare d’opinione. Tuttavia il “caso” di Lajolo presenta aspetti che legittimano qualche riflessione sugli umani comportamenti. Fenoglio è sempre stato antifascista: per Mussolini e il regime non ha mai nutrito simpatia, fin da adolescente. Lajolo al contrario non disdegna d’esibire la camicia nera. Si iscrive al GUF, partecipa volontario alla guerra di Spagna dalla parte dei franchisti; nella sua biografia anche l’esser stato vice-segretario federale del Partito Fascista ad Ancona, fino al 25 luglio 1943. Dunque non una cosa passeggera. Solo dopo l’8 settembre (non è più un ragazzino che ha preso un abbaglio, ha già 31 anni) si unisce ai partigiani, e milita attivamente nel PCI; un suo libro del 1963, nel quale fa un po’ di conti con se stesso, non per un caso lo intitola “Il voltagabbana”. Per farla breve: l’ex fascista, diventato comunista, su l’Unità del 1952 accusa Fenoglio, antifascista da sempre, di mostrare le cose “dall’altra sponda”. Su l’Unità del 10 ottobre 1978 il comunista ormai messo ai margini dal partito, elogia Fenoglio, autore di libri “più vivi, più semplici, più reali di tutta la letteratura partigiana”. Fine. Il cerchio si chiude; sarebbe da riderne, sia pure con amarezza.
Oggi a Fenoglio si riconosce il giusto: autore ruvido, e al tempo stesso epico, tra i massimi prosatori del secondo ‘900 italiano. Muore quarantenne nel 1963, stroncato da un tumore ai polmoni; al pari di Guido Morselli, “autore postumo”. In vita pubblica tre volumi: “I ventitrè giorni della città di Alba”; “La malora”; e “Primavera di bellezza” (i primi due da Einaudi; il terzo da Garzanti nel 1959). Lasciate nel cassetto dell’azienda vinicola di cui lui è procuratore, quasi per caso, a morte avvenuta, si recuperano duemila cartelle: l’incompiuta (e nel suo non esser conclusa, sta la sua grandezza, il suo restare “sospeso”) “Una questione privata”; e un racconto chiaramente autobiografico “Il partigiano Johnny”; si recupera poi “La paga del sabato”, di cui Fenoglio parla e scrive diffusamente con Calvino e Vittorini, ma che da quest’ultimo rifiutato, decide di non pubblicare.
Si può provare a fantasticare per un momento. Si immagini se Vittorini, a proposito de “La paga del sabato”, avesse condiviso l’opinione di Calvino. Dopo aver letto il manoscritto, quest’ultimo scrive a Fenoglio: “…il tuo racconto mi ha preso dalle prime pagine e ho dovuto andare sino in fondo. Ti dico subito quello che ne penso: mi sembra che tu abbia delle qualità fortissime, certo anche molti difetti…molte cose sono buone nel tuo racconto e sono molto contento d’averlo letto. Non ultimo merito è quello di documento della storia di una generazione, l’aver parlato per la prima volta con rigorosa chiarezza del problema morale di tanti giovani ex partigiani…” (lettera del 2 novembre 1950).
Il romanzo piace anche a Natalia Ginzburg. Vittorini è di diverso, opposto avviso. A Calvino dice che “i difetti del romanzo mi sembra che risultino confermati nella seconda versione. Il cartonaccio del cinematografo non lo leva più nessuno di là dentro…”. Un mortificato Calvino, il 26 settembre, scrive a Fenoglio: “Vittorini s’è sempre più deciso che nel romanzo c’è troppo cinematografo, e vuole fare solo i racconti, pensando che per il romanzo troverai di sicuro un altro editore. Io non sono del suo parere perché come sai il romanzo mi piace, ma la collana la dirige lui e pubblica solo cose che lui si sente di difendere fino in fondo…”.
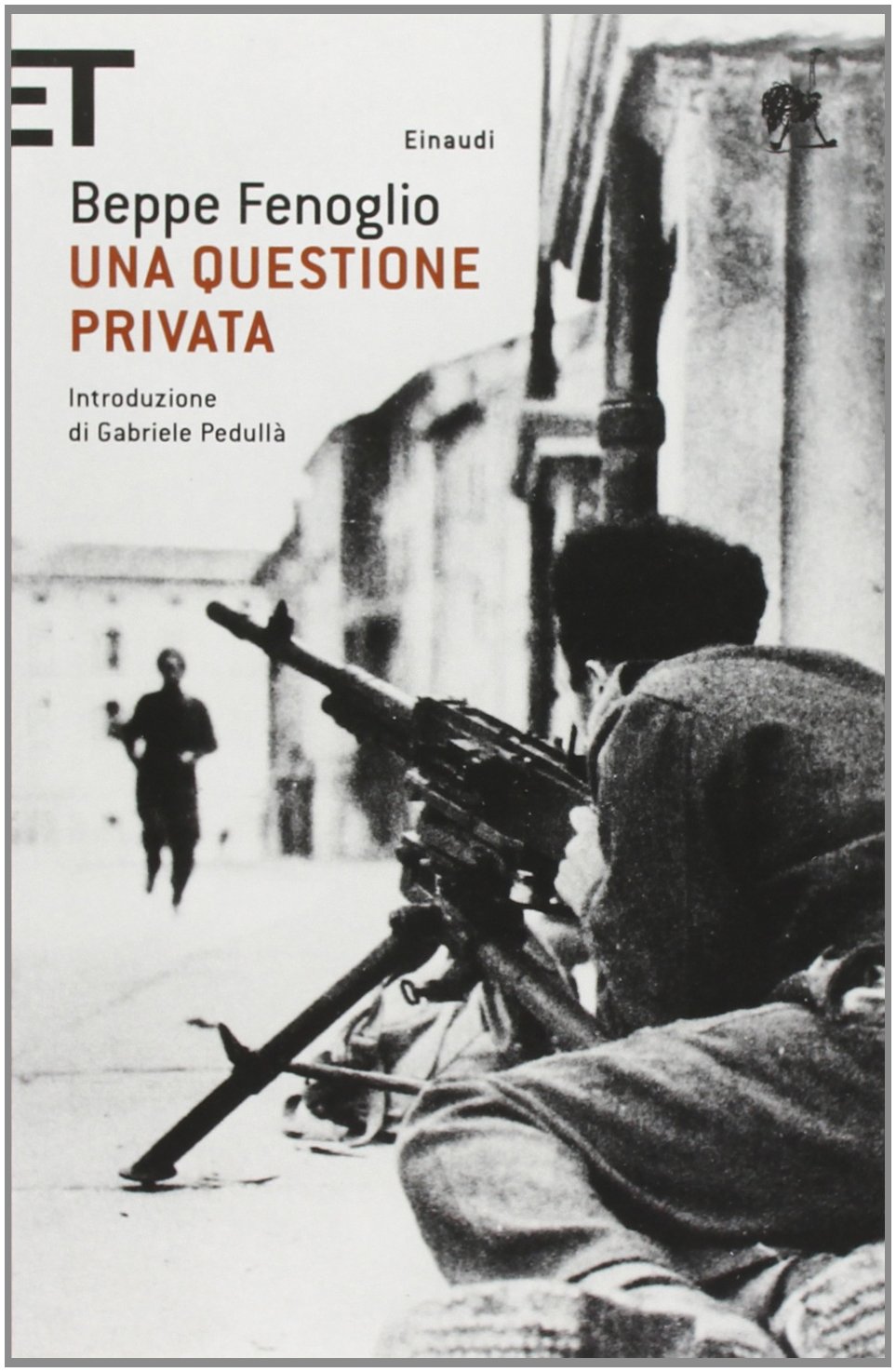 Se il “No” di Vittorini fosse stato un “Sì” non si sarebbe dovuto attendere il 1969 per poter leggere la storia di Ettore: ex partigiano disadattato, scontroso, incapace di inserirsi nella vita civile e rassegnarsi nella routine di un lavoro subordinato. Ettore finisce con l’invischiarsi in un giro di ex partigiani diventati malviventi. Quando decide di sistemarsi e mettere su famiglia con la ragazza che ha messo incinta e si organizza per un lavoro onesto, un beffardo incidente mette la parola fine a illusioni e speranze. E’ un racconto duro, spigoloso: ci sono un padre sostanzialmente fallito e appena once residue di dignità; una madre verghianamente legata alla “roba”; Vanda è una bella e sfortunata figura di ragazza innamorata; Bianco e il fedele stupido Palmo, sono gli ex partigiani che hanno preso una “cattiva strada”.
Se il “No” di Vittorini fosse stato un “Sì” non si sarebbe dovuto attendere il 1969 per poter leggere la storia di Ettore: ex partigiano disadattato, scontroso, incapace di inserirsi nella vita civile e rassegnarsi nella routine di un lavoro subordinato. Ettore finisce con l’invischiarsi in un giro di ex partigiani diventati malviventi. Quando decide di sistemarsi e mettere su famiglia con la ragazza che ha messo incinta e si organizza per un lavoro onesto, un beffardo incidente mette la parola fine a illusioni e speranze. E’ un racconto duro, spigoloso: ci sono un padre sostanzialmente fallito e appena once residue di dignità; una madre verghianamente legata alla “roba”; Vanda è una bella e sfortunata figura di ragazza innamorata; Bianco e il fedele stupido Palmo, sono gli ex partigiani che hanno preso una “cattiva strada”.
Non ha tutti i torti, Vittorini; è un racconto molto cinematografico: un regista di polso ne avrebbe potuto ricavare un bianco e nero strepitoso. L’essere un racconto “molto cinematografico” è un pregio, non difetto. Davvero curioso che, quando ancora si facevano film di un certo livello, nessun regista o produttore abbia pensato di trasportare la storia sullo schermo. Oppure no, non è strano: forse Vittorini non se la sente di pubblicare, nella “sua” collana, un libro che, a differenza di altri, non “partecipa” alla costruzione del mito antifascista e resistenziale; non se la sente di “raccontare” quegli anni come intreccio e impasto di contraddittorie pulsioni, il tanto “grigio” che domina tra il “bianco” (o se si vuole, il “rosso”) e il “nero” degli anni che ci si è appena lasciati alle spalle. E’ pur sempre il Vittorini dell’oggi indigesto “Uomini e no”.
Calvino, meno “ingabbiato” di Vittorini si dice sicuro che Fenoglio avrebbe trovato un altro editore; lui però preferisce non farne nulla. Prima di Einaudi gli hanno detto di no Bompiani, De Silva, Mondadori; evidentemente non vuole altre delusioni. A Calvino il 30 settembre del 1951 confida che “La paga del sabato” è “il frutto, piuttosto difettoso anche se magari interessante, di una mia cotta neoverista che ho ormai superata…”.
Chissà come l’avrebbero presa i feroci custodi dell’ortodossia, se il racconto fosse stato pubblicato allora. Li si può immaginare, i Salinari e gli Alicata, lo stesso Palmiro Togliatti, che sia pure celato con nom de plume, imbracciava la penna come un kalashnikov, e ne sanno qualcosa André Gide, Ignazio Silone, Richard Wright, anni dopo lo stesso Vittorini; quel PCI e quel Togliatti che non hanno remora a definire “autori di scarabocchi” Carla Accardi, Ugo Attardi, Pietro Consagra, Piero Dorazio, Mino Guerrini, Achille Perilli, Antonio Sanfilippo, Giuseppe Turcato…
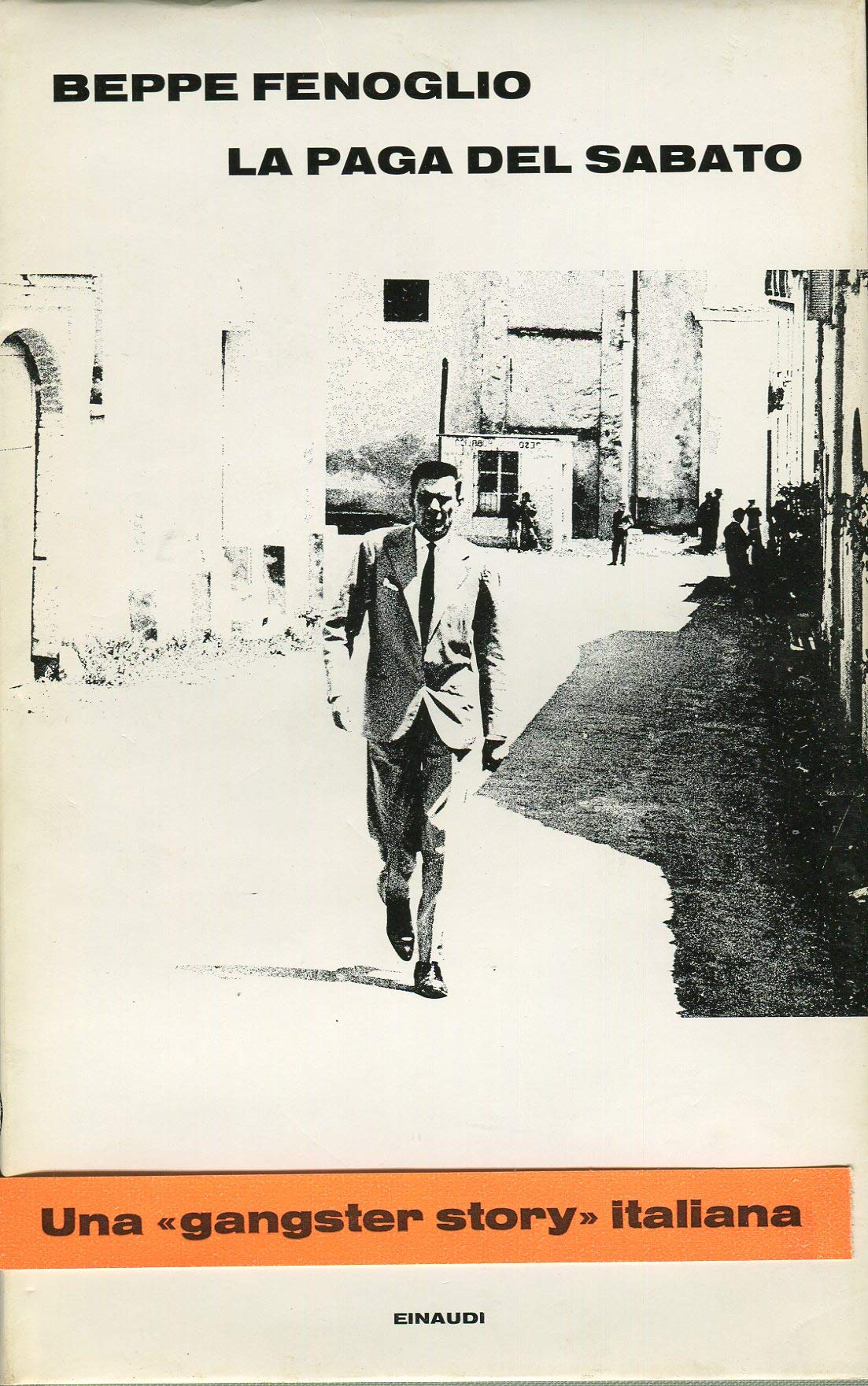 Comunque, anche senza “La paga del sabato”, Fenoglio è oggetto di una feroce polemica accesa da Salinari, l’accademico direttore de “Il Calendario del Popolo”: lo bolla come autore di “cattive azioni”; gli contrappone, quale testo esemplare di giusta valorizzazione della Resistenza, “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò; e, meno frontalmente, “Sentiero dei nidi di ragno” di Calvino. Comprensibile, del resto. Fenoglio dice i suoi sono racconti “della guerra civile”: definizione utilizzata con troppo anticipo: occorre attendere gli anni Novanta, perché sia sdoganata dallo storico Claudio Pavone; e anche lui si trova al centro di polemiche e contestazioni.
Comunque, anche senza “La paga del sabato”, Fenoglio è oggetto di una feroce polemica accesa da Salinari, l’accademico direttore de “Il Calendario del Popolo”: lo bolla come autore di “cattive azioni”; gli contrappone, quale testo esemplare di giusta valorizzazione della Resistenza, “L’Agnese va a morire” di Renata Viganò; e, meno frontalmente, “Sentiero dei nidi di ragno” di Calvino. Comprensibile, del resto. Fenoglio dice i suoi sono racconti “della guerra civile”: definizione utilizzata con troppo anticipo: occorre attendere gli anni Novanta, perché sia sdoganata dallo storico Claudio Pavone; e anche lui si trova al centro di polemiche e contestazioni.
In effetti Fenoglio è colpevole di molte colpe. A parte la refrattarietà all’engagement e il passato di partigiano tra “fazzoletti azzurri”, non nasconde la sua allergia per tutto quello che ha il sapore del contenzioso ideologico; al referendum repubblica o monarchia, il suo voto è per il re; in politica il massimo che si concede per quello che riguarda la sinistra, è una simpatia per Pietro Nenni. A Vittorini, nel giugno 1953, confida di aver avuto la tentazione di votare “Unità popolare”, ma di aver finito con il dare il suo voto al PSDI, sia pure non convinto, “per l’ovvia ragione della battaglia su due fronti. Vedremo. Certo che ci ho patito a non votare per Parri e Calamandrei”. E’ laico, non mette piede in chiesa e si sposa solo civilmente (il suo è il primo matrimonio civile di Alba); impartisce precise disposizioni per il suo funerale: “laici, senza fiori, senza soste, senza discorsi”.
Deve trascorrere molto tempo, prima che a Fenoglio si perdoni l’affronto di aver mostrato i partigiani come persone normali, intrappolate in vortici di situazioni straordinarie, ma non per questo immuni da “normali” debolezze, fragilità, dubbi, paure; e comunque non mancano gli “irriducibili”; come Giorgio Bocca: il 1 aprile del 2007, sul “Corriere della Sera” sostiene che “Fenoglio della Resistenza non ha capito nulla…è un falsario della lotta di Liberazione. È come Pansa. La sua Resistenza, un teatro di assassini, di cialtroni e di poveracci”.
Questo è il punto. A suo tempo Vittorini rimprovera a Fenoglio di non essere un vero romanziere, usa una metafora automobilistica: sarebbe privo delle necessarie “quattro marce”. In realtà Fenoglio paga l’essere un antifascista liberale: nel senso più classico ed esteso del termine. Conosce il gusto del sale. Racconta e descrive Resistenza e partigiani con canoni diversi da quelli della cultura egemone, lo fa con un linguaggio, originale, “nuovo”, moderno; in grande anticipo rispetto ai tempi in cui vive. Calvino mostra di accorgersi della “novità”, e “capire”. Il 2 novembre 1950 gli scrive: “…hai coraggio, hai idee chiare su quello che fa e che pensa la gente, e lo dici. Idee fin troppo chiare: evidentemente tu hai l’orgoglio di riuscire a dire tutto e non la modestia di chi si limita a dare occhiate spaurite nelle sempre misteriose vite altrui. E’ questo spesso a forzarti la mano e a farti scrivere pagine che mi sembrano un po’ irritanti…Tu non dai giudizi espliciti, ma, come dev’essere, la morale è tutta implicita nel racconto, ed è quanto io credo debba fare lo scrittore”.
Non sono espressioni di circostanza o consolatorie. Calvino è convinto, e qualche giorno dopo, l’8 novembre, scrive a Vittorini: “Caro Elio, ti mando il manoscritto de ‘La paga del sabato’, di un certo Beppe Fenoglio di Alba. Natalia ed io l’abbiamo letto con molto piacere. É un libro che ha molti difetti di lingua e di gusto (in certi punti rasenta la pornografia); ma tutti difetti locali, eliminabili con poche correzioni… Quando non è alle prese con una situazione psicologica, fa del cinema, ma del buon cinema credo di quello che tu definisci ‘secco’. Insomma, spero che ti piaccia e che vada bene per la tua collana, perché – benché non possa essere considerato un “neorealista” di stretta osservanza – non rifà il verso a nessuno e dice delle cose nuove”. Einaudi stesso è d’accordo, vorrebbe pubblicare: “Che ci siano delle parti bruttissime (le parti sessuali) siamo d’accordo tutti e due. Ma a me sembra, nell’insieme, molto bello. Gli ho scritto ed è disposto a correggere, tagliare, ecc.”.
Niente da fare. Calvino deve piegarsi ai “niet” che condizionano molte delle scelte editoriali dell’Einaudi (e delle altre case editrici).
Una digressione ora: aiuta a comprendere l’aria che tira in quei giorni. Einaudi definisce “bruttissime” le parti sessuali. Per Calvino la parte dove Ettore e Vanda fanno l’amore sono “irritanti”; in altre occasioni, lo esorta a purgare il suo racconto: “…in ‘Nove lune’ io toglierei nella prima pagina la rievocazione dell’incontro in cui è successo il fattaccio, perché tanto come succede quando nasce un bambino lo sappiamo tutti”. Perché tanta pruderie? E’ vero che si arriva a censurare perfino i fumetti; è vero che da Botteghe Oscure arriva il perentorio ordine di essere più rigorosi e “bacchettoni” in fatto di costume dei democristiani (ipocrite pubbliche “virtù”, perché privatamente i “vizi” si coltivano, eccome). Però accade che lo stesso Calvino, e da Einaudi, nel 1947 pubblica “Il sentiero dei nidi di ragno”: è il suo primo romanzo, ambientato in Liguria; anche qui lo sfondo è la guerra partigiana. A un certo punto ci si imbatte in una scena di sesso, tra un militare tedesco e la sorella di Pin, in combutta con i nazisti. Per quelle pagine, nessuna obiezione, nessuna richiesta di “tagli”. Perché tutto si svolge pudicamente al buio, e se si consuma con una prostituta si può? La Vanda di Fenoglio non è come la sorella di Pin; è una ragazza innamorata come tante, non si prostituisce. Forse non è gradito il fatto che Vanda, in preda all’estasi, urli: “Sono una puttana, lo sono ma cosa me ne fa, è tanto bello, è troppo bello, quelle che non lo fanno sono delle disgraziate! Sono una put…!”. Vai a sapere…
Chi legge Fenoglio con un minimo di attenzione non può non cogliere la “modernità” di questo autore che esplicitamente descrive e ama le donne libere e consapevoli. E’ questo “amore” a procurargli in parte l’ostracismo e la diffidenza di cui è vittima? Sarà una coincidenza, ma all’inizio de “I ventitrè giorni della città di Alba” racconta di come le partigiane mandano a “farsi fottere” i capi che non vogliono farle sfilare a fianco dei ragazzi, perché “i borghesi” le pensano puttane. Di Vanda cui piace far l’amore con Ettore, s’è detto; per soprammercato: non è neppure “buona a pregare”, per la semplice ragione che al pari del suo uomo, non ci crede.
Per quel che riguarda Fenoglio persona, calzante il ritratto che Calvino ne fa, nel 1953, a Giuseppe De Robertis:
“E’ un tipo insolito nelle nostre lettere, anzi proprio il contrario del solito ragazzo di provincia letterato. E’ un commerciante di vermut, non in proprio, ma per una ditta in cui svolge mansioni importanti. E’ un tipo magro, con una faccia da film del West, un po’ brutale e accipigliata, caratteristiche accentuate da una triste affezione: una vegetazione di verruche e escrescenze sul viso. Parla a scatti, con brevi frasi dal giro inaspettato. Non è certo timido (è chiaramente un uomo pratico e risoluto ed è stato comandante partigiano nei badogliani), né è tipo da darsi arie; ma è un uomo che rimugina dentro e parla poco. Lo si direbbe un istintivo di poche letture – e in effetti lo è; ciò non toglie che a un certo momento lo si scopra traduttore di poeti inglesi raffinati: John Donne, Hopkins, Eliot”.
Vittorini ne scrive “ufficialmente” in due occasioni. Nel 1952, quando presenta “ I ventitré giorni della città di Alba”, annota:
“Con Fenoglio la nostra collana presenta un nome del tutto nuovo alla letteratura. Fenoglio è nato nel 1922 ad Alba, dove è vissuto fino a quando è andato soldato, e dove vive ancora oggi, procuratore d’una ditta vinicola. Fuori d’ogni descrittiva regionalistica, Fenoglio della sua provincia sa cogliere più ancora che un paesaggio naturale, un paesaggio morale, il piglio in cui s’articolano i rapporti umani, un gusto ‘barbarico’ che persiste come gusto di vita non solo nel costume del retroterra piemontese. Ed è questo sapore ‘barbaro’ a caratterizzare i racconti che ora presentiamo, rievocanti episodi partigiani o l’inquietudine dei giovani nel dopoguerra. Sono racconti pieni di fatti, con una evidenza cinematografica, con una penetrazione psicologica tutta oggettiva e rivelano un temperamento di narratore crudi ma senza ostentazione, senza compiacenze di stile ma asciutto ed esatto”.
La seconda “presentazione” è del 1954 (Fenoglio non ne è punto contento):
“Degli scrittori che i ‘Gettoni’ hanno presentato del tutto nuovi Beppe Fenoglio è uno su cui siamo più inclini a puntare. Piemontese delle colline, soldato dal ’41 al ’43, poi partigiano fino al ’45, e oggi procuratore, ad Alba, d’una ditta vinicola, egli ci diede il suo primo libro, ‘I ventitrè giorni della città di Alba’, al principio del ’52. Questo che ora pubblichiamo, è per molti aspetti più bello nello stesso senso di rappresentazione (e rappresentazione a contropelo) di quanto può essere aspro l’uomo con l’uomo. Racconta di rapporti umani in campagna ridotti alla nuda spietatezza (anche tra marito e moglie, e anche tra padre e figli) del rapporto di lavoro. Ma ci conferma in un timore che abbiamo sul conto proprio dei più dotati tra questi giovani scrittori dal piglio moderno e dalla lingua facile. Il timore che, appena non trattino più di cose sperimentate personalmente, essi corrano il rischio di ritrovarsi al punto in cui erano, verso la fine dell’Ottocento, i provinciali del naturalismo, i Faldella, i Remigio Zena: con gli ‘spaccati’ e le ‘fette’ che ci davano della vita; con le storie che ci raccontavano, di ambienti e di condizioni, senza saper farne simbolo di storia universale; col modo artificiosamente spigliato in cui si esprimevano a furia di afrodisiaci dialettali. E’ solo un rischio ch’essi corrono. Un dirupo lungo il quale camminano. Ma del quale è bene che siano avvertiti”.
In una scheda autobiografica, Fenoglio annota:
“La critica mi ha seguito e mi segue con una certa attenzione, in misura superiore, debbo dire, all’aspettativa di uno scrittore appartato e ‘amateur-like’ quale io sono. Le recensioni a tutt’oggi sono numerose e, per quel che riguarda la sostanza, variano dal moderato elogio alla stroncatura selvaggia. In linea generale, il mio atteggiamento di fronte alle sentenze della critica è quello già configurato da altro scrittore e comune, penso, a tutti gli artisti, stupore per quello che i critici sanno trovare nel tuo lavoro e altrettanto stupore per quello che non sanno trovarci. Scrivo per un’infinità di motivi. Per vocazione, anche per continuare un rapporto che un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per giustificare i miei sedici anni di studi non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, anche per restituirmi sensazioni passate; per un’infinità di ragioni, insomma. Non certo per divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti. Scrivo ‘with a deep distrust and a deeper faith’”.
A proposito dell’aspetto fisico: Maurizio Crosetti, per “Repubblica”, ripercorre luoghi ed atmosfere del “partigiano Beppe” in compagnia della figlia Margherita, “una donna alta come papà”. Margherita, che aveva appena due anni, quando Fenoglio muore, si leva la mascherina anti-covid: “Ecco, vede? Sono lui. Precisa identica. Se solo papà mi avesse lasciato un nasino alla francese, invece del naso dei Fenoglio, e almeno un po’ del suo talento. Via, è andata così”.
Quanto al parlare a scatti, lo scrittore ha un difetto di lingua, e in particolare quando è fuori dalla cerchia familiare e degli amici. Capita. Ingiusto però averlo considerato per tutta la sua non lunga vita un “dilettante” che rischia di precipitare in un provinciale naturalismo… Vero che Vittorini fa un discorso generale, non si riferisce al solo Fenoglio; tuttavia per farlo utilizza la “tribuna” del risvolto di un libro di Fenoglio. Tutta la mole del suo lavoro, recuperata e pubblicata postuma, dimostra il contrario: Fenoglio è un gigante della letteratura italiana del secondo ‘900. E tuttavia…
Non si tratta certo di una ricerca esaustiva; per quanto frammentaria, è comunque indicativa: nel “Compendio di storia della letteratura italiana” di Natalino Sapegno, nelle pagine dedicate agli scrittori più contemporanei, si citano Cesare Pavese, Massimo Bontempelli, Aldo Palazzeschi, Giani Stuparich, Enrico Pea, Giovanni Comisso, Carlo Emilio Gadda, Gianna Manzini, Corrado Alvaro, Alberto Moravia, Guido Piovene, Romano Bilenchi, Elio Vittorini, Carlo Levi, altri. Fenoglio è ignorato. Stessa sorte nella “Storia della letteratura italiana” di Mario Sansone. Assente in “Scrittori e popolo” e in “Letteratura italiana” di Alberto Asor Rosa. Compare invece, ne “La narrativa italiana contemporanea” di Giorgio Cavallini e Livio Marguati, un paio di corpose schede: si osserva che “l’opera di Fenoglio si inserisce indubbiamente in quelle istanze regionalistiche che nel secondo dopoguerra trovano espressione nel neorealismo e nelle dimensioni esistenziali che a quella piuttosto debole poetica seppe dare Cesare Pavese…in Fenoglio manca tutto l’aspetto ideologico e letterario del ‘mito’ e del profondo senso del dolore individuale di Pavese”. Interessante soprattutto la “recensione” relativa ai “Ventitré giorni della città di Alba”. Si ricordano le polemiche accese dall’“Unità”, per poi annotare con pacata precisione: “…erano quelli gli anni che vedevano svilupparsi una violenta e avvilente campagna antipartigiana di denigrazione e calunnie, ma certo la miglior difesa della Resistenza fu fatta più da chi come Fenoglio sapeva anche cogliere gli errori e le incertezze della lotta partigiana che da coloro che la osannavano indiscriminatamente sul piano agiografico e retorico. La superiorità, il distacco tra la Resistenza e i suoi nemici, sta anche in questa capacità estremamente morale di autocriticarsi; di cogliere le proprie debolezze che sono del resto quelle comuni a tutti gli uomini, e se i partigiani erano uomini (‘non-uomini’, come scrisse Vittorini, erano gli ‘altri’), non riuscirono certo a restarne immuni”.
Nel 2006, sono già trascorsi quarantatré anni dalla morte, Giulio Ferroni, riconosce a Fenoglio il giusto:
“…Si rivela sempre più “grande” e assoluta l’opera di Beppe Fenoglio, scrittore solitario, che è stato del tutto estraneo alla frivolezza e alle beghe politico-istituzionali della società letteraria…Egli ha dato una narrazione eccezionale e davvero “assoluta”, senza costruzioni ideologiche o prospettive di partito, ma indagandone la profonda “verità”, scendendo fino in fondo dentro al senso di quell’esperienza, dentro le sue contraddizioni e le sue lacerazioni, ma anche dentro la sua “necessità”. La Resistenza raccontata da Fenoglio è qualcosa di tremendo e di essenziale, che consegue a una scommessa di dignità e di autenticità: in essa non si affermano modelli positivi, non si tracciano programmi ideali, ma si lotta per salvare la possibilità stessa di un equilibrio umano, di una continuità e di una comunità civile e culturale. E’ la concretezza della rappresentazione letteraria a farci vedere in atto che il fascismo e il nazismo contro cui si combatte non costituiscono semplicemente “l’altra parte”, ma sono un male radicale, un blocco della vita, della storia, della civiltà, contro cui ci si deve comunque schierare, anche se il fatto di combattere, di per sé, non può essere un “bene”…lo sguardo di Fenoglio è insieme tragico e crudamente realistico, non nasconde nulla di quell’orrore; ma può farlo solo perché è dalla parte della ragione, della sola ragione allora minacciata, la cui sconfitta avrebbe rappresentato la catastrofe dell’Italia e della sua storia…Oggi, a sessant’anni dall’inizio della Resistenza, e a quaranta dalla morte di Fenoglio, la concretezza, la forza, la densità esistenziale e simbolica della sua opera assumono un sempre più netto ed essenziale rilievo storico e letterario: e ciò proprio perché essa è sorretta da una assoluta religione della libertà e della letteratura, che la allontana da quell’intento agiografico e da quello spirito propagandistico, in cui incorsero molti libri dedicati “a caldo” alla Resistenza…Il linguaggio di Fenoglio, dai numerosi racconti, all’epopea frammentaria di quel vero e proprio continente testuale che è ‘Il partigiano Johnny?, al capolavoro supremo di ‘Una questione privata’, offre un’immagine viva e concreta di quella realtà, al di là di tutte le convenzioni del neorealismo, proprio perché scaturisce da un impegno letterario assoluto, da una volontà di interrogare un’esperienza intensamente vissuta alla luce di una passione integrale per la letteratura (in primo luogo la grande letteratura inglese, che Beppe aveva appassionatamente studiato negli anni della giovinezza)…Se Fenoglio ha fatto della Resistenza e dell’esperienza vissuta la materia della sua scrittura, questa sua scrittura è stata essa stessa “resistenza”, modo di testimoniare il valore dell’esperienza e della verità in un mondo che sempre più tende a dimenticare e a cancellare, che sempre più mette in pericolo la memoria, la passione, la dignità, la serietà, il pudore, che riduce tutto a squallido spettacolo, a esibizione pubblicitaria, a effimeri effetti di choc”.












