Nemmeno le emozioni sono più quelle di una volta. Il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti ci spiega il perché in due libri editi da Feltrinelli, uno per gli adulti e uno per i ragazzi Il libro delle emozioni e Che tempesta! 50 emozioni raccontate ai ragazzi.
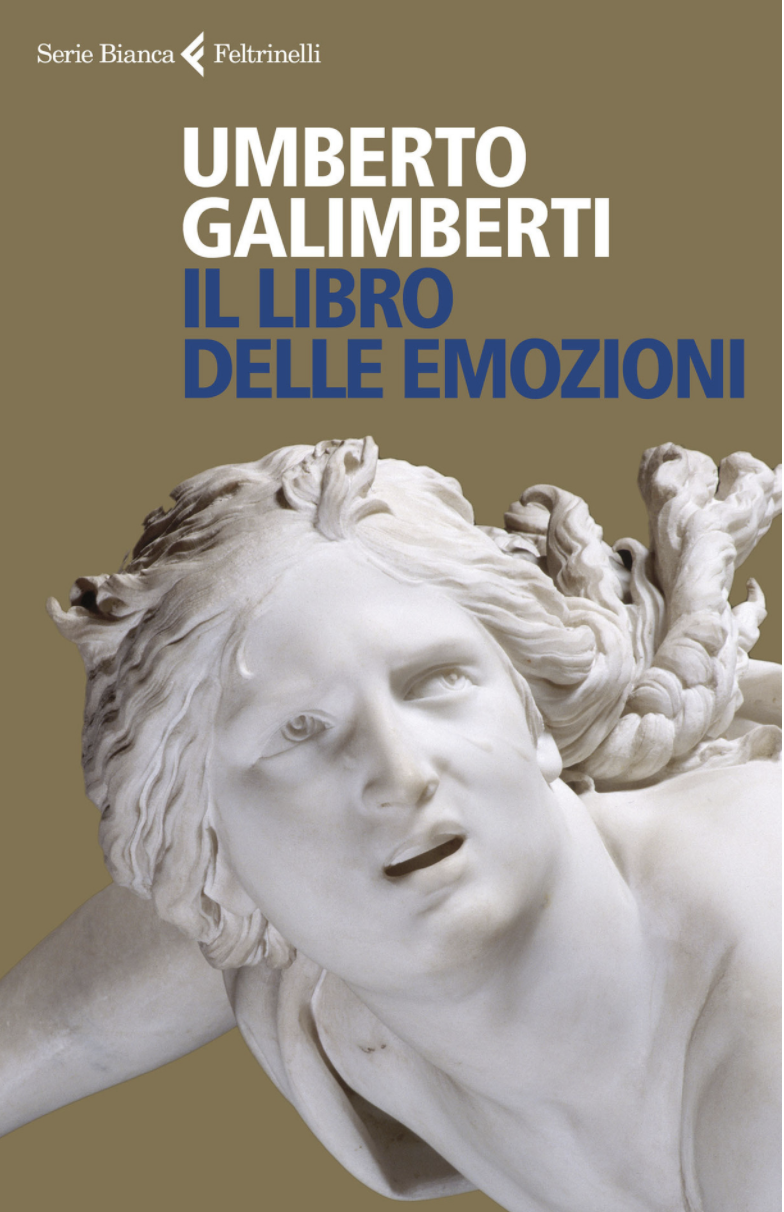 L’età della tecnica in cui viviamo ci ha ridotto a degli analfabeti emotivi. E le nuove tecnologie ci conducono a una progressiva infantilizzazione, dove il telefonino fa le veci del vecchio orsetto di pelouche dal quale non ci separiamo mai.
L’età della tecnica in cui viviamo ci ha ridotto a degli analfabeti emotivi. E le nuove tecnologie ci conducono a una progressiva infantilizzazione, dove il telefonino fa le veci del vecchio orsetto di pelouche dal quale non ci separiamo mai.
Ma cos’è un’emozione? Una reazione affettiva di insorgenza immediata e di breve durata; spiega Galimberti. Dipende dal cervello antico, sotto la corteccia, che abbiamo in comune con gli animali, il quale affronta i problemi senza il tempo della riflessione. La paura è stata un’emozione molto utile ai primitivi per difendersi dai pericoli, trovare il cibo e non diventare cibo per gli altri.
Oggi viviamo nell’età della tecnica che esprime una razionalità molto rigorosa: raggiungere il massimo degli scopi con l’impegno minimo dei mezzi. Questo è comune anche al mercato, che però conserva ancora una passione umana per il denaro, da cui invece la tecnica è completamente esonerata. Se la razionalità diventa l’unica forma del pensare umano, i cui valori sono efficienza, produttività, velocizzazione del tempo, tutte le dimensioni irrazionali dell’uomo vengono percepite come intralci e disturbi. Vengono messi fuori gioco il dolore, l’amore, la fantasia, l’immaginazione, il sogno, in cui propriamente consiste l’uomo. Una possibile reazione è un comportamento regolato dal principio: “Ma io sento così”, solo che il sentire individuale sganciato dalla relazione sociale non è un buon criterio, come hanno dimostrato i no vax. E gli altri non contano niente? Un’altra reazione è l’esposizione della vita emotiva a cui inducono numerose trasmissioni tv dove si chiede ai partecipanti di rendere pubblica la loro vita intima, scambiando la spudoratezza per sincerità, mentre si tratta della perdita del pudore.
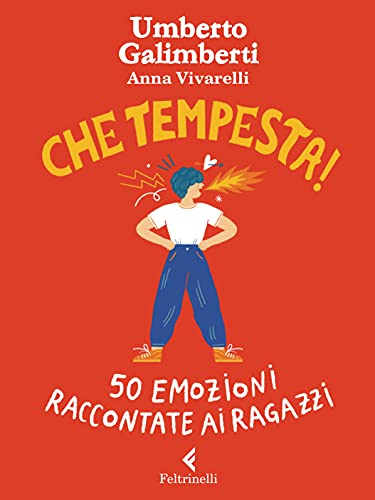 La gelosia è un’emozione primordiale, fondata sul sostentamento, che innesca dei processi competitivi, ad esempio, in un uomo verso chi voglia sottrargli la sua donna, oppure proiettivi, quando un uomo desidera relazionarsi con altre donne, ma inibisce questo desiderio e lo proietta sulla donna con cui vive, come se fosse suo, diventando di una gelosia paranoica che lo porta a controllare tutto. L’ira si scatena quando non si raggiunge l’obiettivo che ci si era prefissati e o si subisce un torto.
La gelosia è un’emozione primordiale, fondata sul sostentamento, che innesca dei processi competitivi, ad esempio, in un uomo verso chi voglia sottrargli la sua donna, oppure proiettivi, quando un uomo desidera relazionarsi con altre donne, ma inibisce questo desiderio e lo proietta sulla donna con cui vive, come se fosse suo, diventando di una gelosia paranoica che lo porta a controllare tutto. L’ira si scatena quando non si raggiunge l’obiettivo che ci si era prefissati e o si subisce un torto.
Gli effetti dell’informatica hanno creato una patologizzazione del vissuto emotivo. Come l’intolleranza della distanza (scrivo alla fidanzata e lei non mi risponde); il controllo paranoico (posso sapere dov’è, diventando un investigatore invece che un amante); l’angoscia dell’anonimato (parlo ad alta voce in treno per far sapere a tutti chi sono); la nostra identità è fuori di noi (si affida ai like al numero dei follower); cybersesso (scateno tutte le mie fantasie sessuali e poi svaluto la relazione reale come inferiore). Finisco per sostituire la realtà con la virtualità creando un fenomeno di derealizzazione: per cui posso visitare Roma senza esserci mai andato; nuotare negli abissi dell’oceano senza bagnarmi; simulare reazioni che non ho il coraggio di fare. Perdo le abilità necessarie per muovermi nel modo reale. Secondo processo negativo: la desocializzazione, perché posso parlare con il mio amico in Australia e poi non conosco il vicino di casa. L’informatica modifica il mio modo di sentire perché la nostra psiche reagisce solo agli eventi del mondo circostante, non del mondo nella sua globalità: se muore una persona che ho amato, soffro; se mi dicono che sono morti dieci bambini per fame e sete, per me resta una statistica. La mancanza di risonanza emotiva produce persone pericolose.

La scuola dovrebbe educare alle emozioni per insegnare ai ragazzi a sentire la differenza tra il bene e il male, tra ciò che è grave e ciò che non lo è. E dovrebbe insegnare i sentimenti, perché non sono un evento naturale ma culturale. I primitivi insegnavano la differenza tra sacro e profano, puro e impuro, totem e tabù. I Greci avevano l’Olimpo dove ogni dio rappresentava un’emozione e un sentimento. Per cui bisogna riempire le scuole non di computer, ma di letteratura, in modo che, quando sopraggiunge il dolore o qualche difficoltà, i ragazzi abbiano in testa dei modelli dei sentimenti e sappiano dire di che cosa soffrono e conoscano le strategie per uscirne. “Il dolore è un errore della mente” ha scritto Eschilo.












