Un borghese grande grande. A 84 anni appena compiuti, Andrea Carandini si è tolto un sassolino dalla scarpa. Sassolino che rotolando è diventato una montagna gigantesca e impervia come la sua vita ricca e meravigliosa, dispiegata in una biografia di 786 pagine pubblicata da Rizzoli con un titolo fulminante: L’ultimo della classe. Archeologia di un borghese critico. Non tanto perché il professore da ragazzo a scuola odiava la matematica (“ancora adesso non ho capito come si fanno le divisioni”), ma perché è il superstite di un gruppo sociale estinto. Ovvero la borghesia colta, critica, liberale e illuminata che nel dopoguerra e oltre aveva tracciato il disegno della nuova Italia. E ancora una terza accezione di questa parola fatidica: classe come stile, eleganza, distinzione, un argine alle invasioni barbariche di questi tempi bui.
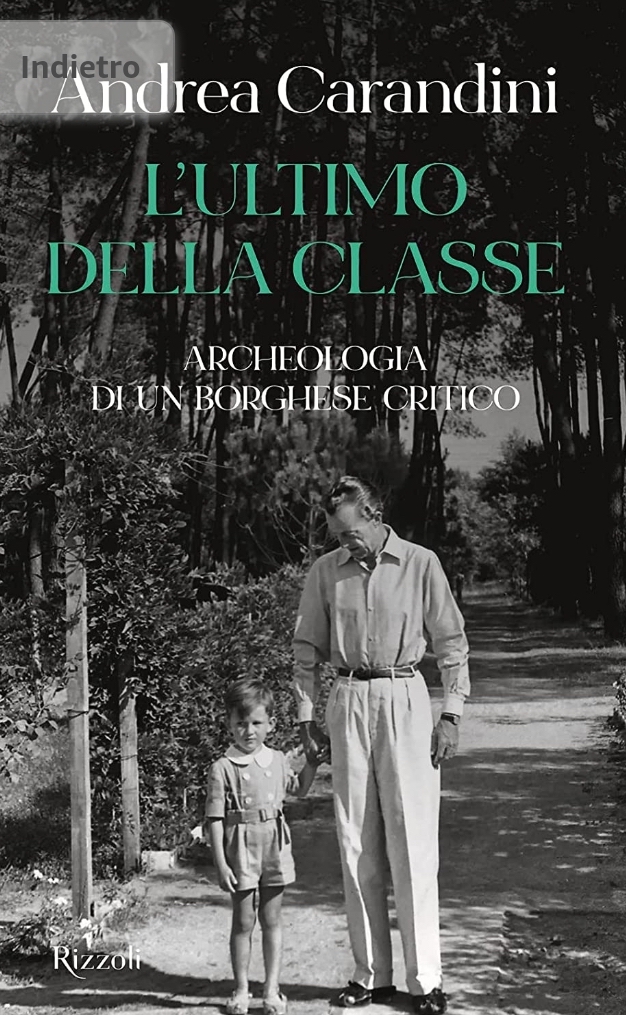 Ma chi è stato e chi è tuttora il conte Andrea Carandini dei marchesi di Sarzano, patrizio di Modena e nobile di Bologna, quarto di cinque fratelli? Impossibile non partire dalla sua famiglia illustre e gloriosa, che aveva per amici Tolstoi e Croce, Boito e Fogazzaro. Il padre Nicolò è stato uno degli uomini chiave della neonata Repubblica, ministro e ambasciatore a Londra. La madre Elena era figlia del senatore Luigi Albertini, leggendario direttore del Corriere della Sera rimosso da Mussolini per il suo dichiarato antifascismo. Non solo. E’ bisnipote di Giuseppe Giacosa, scrittore e librettista (la Bohème, Tosca, Madama Butterfly), intimo di Puccini e Verdi. E perfino cugino di terzo grado di sir Christopher Frank Carandini Lee, l’interprete di Dracula in dodici film.
Ma chi è stato e chi è tuttora il conte Andrea Carandini dei marchesi di Sarzano, patrizio di Modena e nobile di Bologna, quarto di cinque fratelli? Impossibile non partire dalla sua famiglia illustre e gloriosa, che aveva per amici Tolstoi e Croce, Boito e Fogazzaro. Il padre Nicolò è stato uno degli uomini chiave della neonata Repubblica, ministro e ambasciatore a Londra. La madre Elena era figlia del senatore Luigi Albertini, leggendario direttore del Corriere della Sera rimosso da Mussolini per il suo dichiarato antifascismo. Non solo. E’ bisnipote di Giuseppe Giacosa, scrittore e librettista (la Bohème, Tosca, Madama Butterfly), intimo di Puccini e Verdi. E perfino cugino di terzo grado di sir Christopher Frank Carandini Lee, l’interprete di Dracula in dodici film.
Sarebbe bastato questo. E invece Andrea Carandini si è buttato in uno studio accanito e prezioso, all’inseguimento della sua grande passione, la vocazione di bambino: l’archeologia. Allievo di Ranuccio Bianchi Bandinelli, è diventato accademico e docente universitario per quasi mezzo secolo grazie alle sue grandi scoperte sul campo. Prima fra tutte quella che l’ha reso celebre nel mondo: i resti di una fortificazione sulle pendici settentrionali del Palatino, il circuito murario difensivo che circondava il colle nell’ottavo secolo avanti Cristo. Ovvero le vestigia della nascita di Roma, la Storia che conferma il mito di Romolo e Remo.
Ma come ha raccontato in un incontro con il teologo Vito Mancuso al Mast di Bologna, Carandini è anche l’archeologo di se stesso. Ha cercato risposte a domande eterne (chi siamo? da dove veniamo? dove andremo?) zappando nell’antichità e nella propria personalità narcisista, tra conscio e inconscio, con una lavoro progressivo di analisi freudiana. Il suo punto di riferimento è stato Marco Aurelio, quasi un padre spirituale, l’imperatore definito “il più grande pensatore della romanità”. La citazione iniziale dell’autobiografia dice già tutto: “Scava dentro, dentro è la fonte del bene, che sgorga a condizione che tu continui a scavare”.

Carandini l’ha fatto senza tirarsi indietro. E scavando sono emerse le emozioni, la meraviglia, l’intelligenza, l’arte, la politica, l’impegno civile, la potenze di idee che hanno punteggiato un viaggio lunghissimo. Fino al momento del bilancio, mettendo le cose in fila nero su bianco. “E’ venuto il tempo di setacciare la mia vita, capire quel che c’è da buttare, conservare e recuperare dalle ortiche”, scrive a pagina 516 della sua ambiziosa ricognizione. Il bambino, l’adolescente, l’uomo maturo, il vecchio. Sullo sfondo il simbolo di una appartenenza inevitabile: la middle class che si inchinò al fascismo, fatta a pezzi dal ’68, osteggiata e tradita persino da lui che ne è l’incarnazione. Una borghesia di cui si è detto tutto il male possibile, ma che oggi manca terribilmente a un Paese incapace di esprimere una classe dirigente credibile e intellettualmente indipendente.

“Sono un sopravvissuto che indossa la giacca di tweed con la pochette nel taschino e i pantaloni di flanella: desueto e insolito, mi rendo conto. Vago tra le rovine di quel che è stato il mio mondo. Parlo con persone morte che sento vive”. E del resto il presente è spesso scoraggiante. Senza più una scuola degna di questo nome, il suo grande rimpianto. “Una volta mi sono ritrovato seduto in aereo con mia moglie, d’estate. Noi gli unici vestiti attorniati da turisti tatuati e seminudi in volo dal Messico a Roma. Mi sono sentito un antropologo in mezzo a una tribù di selvaggi”, sorride ironico. Più facile allora confrontarsi con maestri che non tradiscono: Goethe, Einstein, Camus, Proust, il cardinale Martini. E quel Thomas Mann che esprime tutta la sublime severità dell’etica borghese in una lettera al figlio: “La mia coscienza mi fa guardare a ciò che uno riesce a fare, piuttosto che al piacere. Io aspiro alla mia opera e diffido dalla felicità”. Ma attenzione. Fra illusioni e disillusioni, errori e abiure, l’uomo del Novecento non rinnega il secolo che abita oggi, tutt’altro.
Al secondo mandato da presidente del Fai, il Fondo per l’ambiente, Carandini ha raccolto nel 2013 l’eredità di Ilaria Borletti Buitoni e della fondatrice Giulia Maria Crespi, “l’imperatrice capricciosa”, aprendo a tutti le porte della grande bellezza italiana. Il compito che sente suo è offrire un lascito alle nuove generazioni, trasmettendo quanto ricevuto da guide ineguagliabili. Il filo della memoria tessuto nel gomitolo dell’esistenza. Un messaggio nella bottiglia esplicitato nella dedica alla nipotina Lea di due anni, che gioca con l’orsacchiotto di pezza che fu del piccolo Andrea. “La curiosità è la mia ossessione. Vivo la vecchiaia che è un’età straordinaria: ti porta a sorridere di molte cose, con distacco e consapevolezza se hai saputo cercare dentro di te. In fondo si può chiamare saggezza”. Tutto, e così sia.












