Era il 1837 quando alcuni marinai egiziani di ritorno dall’India diffusero il colera a Siracusa. Il morbo si diffuse velocemente in tutta la Sicilia con particolare intensità nel palermitano, nell’agrigentino e nel trapanese. L’epidemia raggiunse anche Salemi, antica città arabo-medievale situata nella Valle del Belice, che nel 1860 con lo sbarco di Garibaldi a Marsala che capeggiava la spedizione dei Mille, divenne simbolicamente e per un giorno la capitale d’Italia. Pur nell’impossibilità di una conta esatta, si sa che le vittime furono circa 600, tutte sepolte, secondo le disposizioni di legge del tempo, in una fossa comune situata fuori dall’abitato in contrada Serrone. L’area divenne un cimitero con al centro un cippo in pietra e una grande croce di ferro che svettava in cima; i parenti dei colerosi si recavano per visitare, pregare e portare un fiore ai loro cari. Dai primi del ’90, però, il sacro luogo non venne più frequentato e con il passare degli anni, cadde nell’incuria e nell’abbandono generale fino a scomparire del tutto.

Circa otto anni fa, Vito Surdo, salemitano “d.o.c”, storico per passione e primario in pensione di ortopedia e traumatologia all’Ospedale di Mirano, nel Veneto, s’imbatte in una pagina del romanzo storico, Gli illusi” di Alessandro Catania, medico e scrittore di Salemi morto nel 1932. Surdo in particolare si sofferma su questo racconto: «In quel mentre sopraggiunge mastro Pasquale Dacinarea, un giovane sui 27 anni, alto, robusto, roseo, un bel giovane. Era figlio di don Stanislao che abitava laggiù a S.Antonio, quattro figli, due maschi e due femmine, il primo dei quali era Pasquale. Ogni lunedì don Stanislao, facesse tempo cattivo o bello, d’estate oppure d’inverno, si recava al cimitero dei colerosi, poco distante da Salemi, al Serrone, a recitare una preghiera per la perduta moglie» (p.23). Da allora il nostro autore “invaso” da un’interiore inquietudine si sente spinto, dopo accurate ricerche, a impegnarsi per ridare dignità e rispetto a quel luogo dove i suoi antenati, vittime del morbo asiatico, erano sepolti in maniera indegna e nell’oblio di tutti. Decide, quindi, di restaurare il cippo in pietra ormai crollato e sistemare l’intera aerea cimiteriale. Ottenute le prescritte autorizzazioni dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione gratuita di tecnici amici (architetto, ingegnere e muratori) e accollandosi personalmente la gran parte dei costi, finalmente il suo progetto diviene realtà riparando così a uno scempio vergognoso.

Ora, la storia del cimitero dei colerosi di Salemi è diventata un libro il cui autore è lo stesso Vito Surdo, “I morti dimenticati. Breve storia del ritrovamento del cimitero dei Colerosi di Salemi e delle vicende che hanno portato alla sua nuova sistemazione (Edizione Sipirro, pp. 119). Si tratta di un “libro-dossier” dove la cronaca storica è comprovata da documenti e foto che immergono il lettore in uno scorcio della storia salemitana cadenzata dagli avvenimenti che man mano che si susseguono fanno emergere anche i sentimenti di fede, umanità e patriottismo nazionale e locale dei protagonisti del passato e di oggi, in primis dell’Autore. Il libro, terminato qualche mese prima dello scoppio della pandemia da Covid 19 in Italia e pubblicato in pieno lockdown, costituisce certamente un documento di riflessione e, per alcuni aspetti, di comparazione con le problematiche che l’umanità sta vivendo oggi a causa del coronavirus.
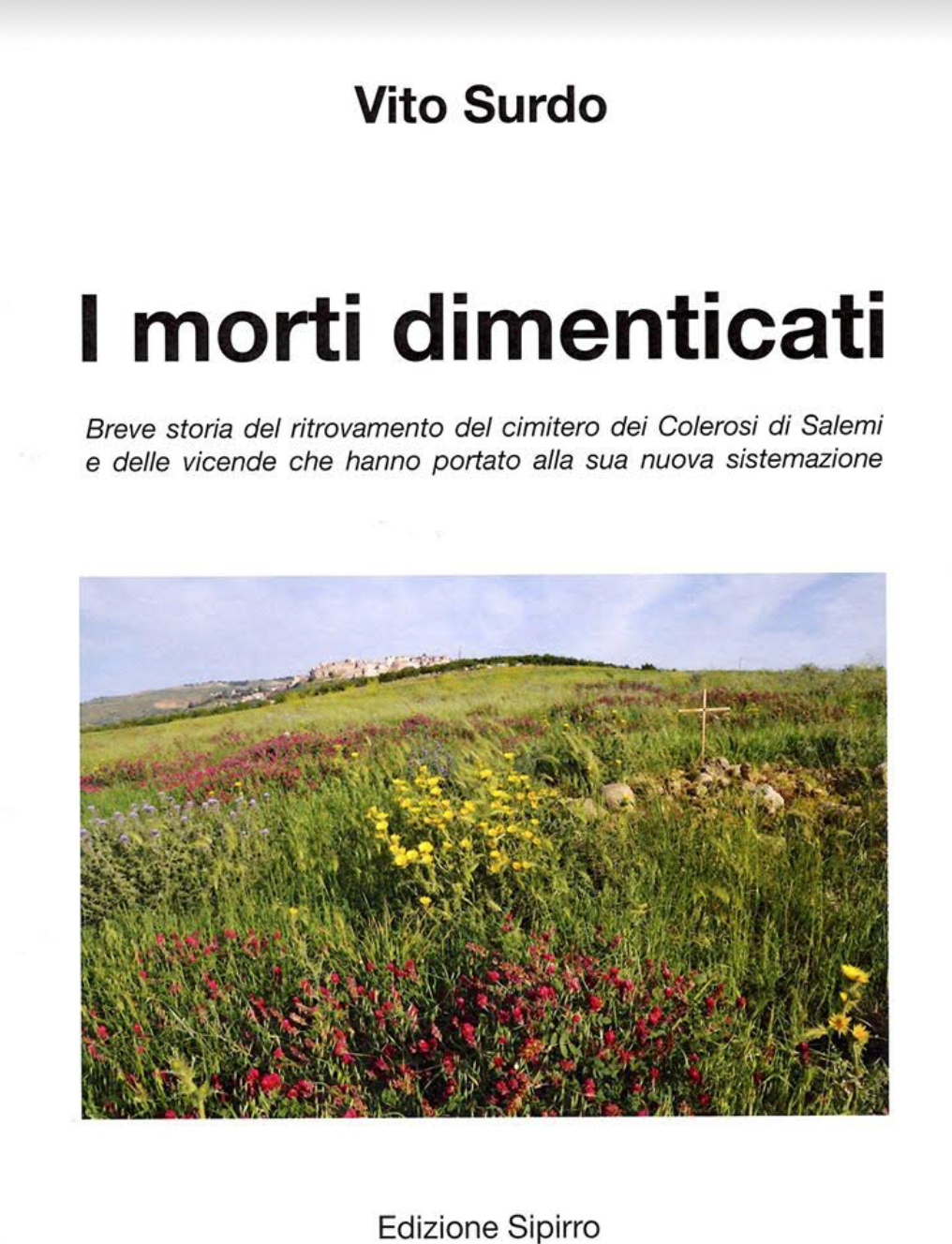
Nonostante la penuria e l’assenza di documenti, dall’archivio storico comunale di Salemi, è emersa documentazione dalla quale si conoscono quelle che oggi chiameremmo le “misure di prevenzione e sicurezza”. Il sindaco del tempo, Giuseppe Favara Inglese e Giovanni Baviera, primo eletto del Decurionato, all’indomani dei primi casi di colera chiusero la città in un “cordone sanitario” con 12 posti di blocco mettendo a capo l’ispettore, Cav. Lorenzo Cascio; istituirono, inoltre, dei “lazzaretti” per la “quarantena” delle persone e l’isolamento delle merci in arrivo, una Commissione sanitaria per controllare le acque potabili e l’igiene della città, emanarono avvisi di divieto di assembramenti e riunioni. Sono stati scandagliati, inoltre, gli archivi parrocchiali delle parrocchie della Catena e della Chiesa madre da cui è stato possibile, attraverso il registro dei defunti, risalire ai nomi di alcune vittime del morbo morte in quei terribili 45 giorni del 1837. Dalle ricerche emerge l’abnegazione del clero salemitano mostrata nel soccorso agli ammalati e ai moribondi: tre sacerdoti persero la vita per contagio: Giuseppe Accardi, frate cappuccino morto il 28 agosto 1837, Saverio Mistretta deceduto l’8 settembre e Antonino Cottone morto il seguente 22 ottobre. Altri preti e religiosi si distinsero per il loro impegno a favore dei colerosi: padre Antonio Orlando Olivieri parroco della Catena, il rettore dell’Orfanotrofio di Sant’Anna, Antonino Scalisi, padre Antonino Spagnolo, rettore della Chiesa di Santa Maria e padre Giuseppe Verdirame Patti. Questo è un libro che racconta una storia triste e di dolore, ma illuminata dal cuore di un uomo che ha coinvolto nella sua buona, civile e religiosa battaglia i suoi paesani salemitani ridando giustizia e rispetto a donne e uomini anonimi, ma pur sempre inviolabili nella loro dignità.











