Ci sono ricerche e analisi che sono necessarie e indispensabili per comprendere l’essenza, radici, nascita e sviluppo di una intera società. Questo è quanto mai utile in un gruppo statuale recente che si è creato dal nulla e che ha dovuto esplorare e analizzare le proposte di realizzazione per la fondazione e la formazione di un nuovo Stato. Ciò diventa più necessario e pressante nella situazione in cui il processo della sua formazione nasce da una rottura, clamorosa e cruenta, rivoluzionaria per se stessa, ma anche per le ragioni basilari, una crasi profonda ideologica e istituzionale con la preesistente struttura politico-amministrativa inglese, sovrappostasi attraverso un vero e proprio secolare genocidio degli autoctoni, ab initio possessori di quelle terre. Ciò si rendeva allora ineludibile in una spontanea, ristretta Confederazione di 13 regioni di un vastissimo ignoto ed inesplorato continente, formatesi per eterogenea colonizzazione e assurte ad identità di Stato autonomo. Si tratta in questo processo eccezionale di raccordare le divere esigenze di regioni colonizzate da popoli di differente nazionalità e motivazioni di fuga dalla terra natale, in un territorio geografico variegato per zone climatiche e abitative, per diversità di ricchezze, agricole o minerarie, di esigenze insediative ed antropologiche. Fra l’altro in un continente in cui vivevano milioni di autoctoni e rinforzato da milioni di neri, conseguenza della tratta dei negri, l’asiento, prerogativa inglese in seguito ad un “accordo” del trattato di Aquisgrana del 18 ottobre 1748 a chiusura della guerra di successione austriaca.
Le recenti ultime elezioni nazionali degli USA ci hanno offerto il termometro per valutare le difficoltà di aggregazione e convivenza, di ideali di vita di una confederazione così diversificata, tanto da turbare il corretto svolgimento di libere elezioni e da mettere in crisi principi naturali e sacrosanti in una moderna democrazia formatasi sui grandi ideali dell’Illuminismo francese abbracciati dai padri fondatori e in modo considerevole sulla tradizione politica latina e italiana. Eppure si tratta della stessa Costituzione studiata, discussa, resa omogenea e perenne, salvo qualche giusto emendamento, in altri casi improvvido, tanto da ledere i principi fondanti dell’Unione, anche se richiesto da momenti eccezionali, come per esempio il possesso delle armi, in una società moderna che in tutte le istituzionali internazionali le ha bandite.
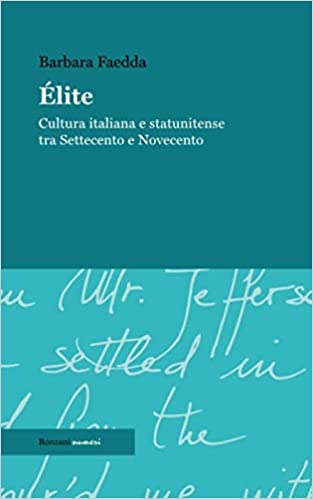 Mi auguro che il libro di Barbara Faedda, Élite. Cultura italiana e statunitense tra Settecento e Novecento (ed. Ronzani numeri, 2020) sia tradotto e divulgato capillarmente nelle moltissime istituzioni italiane che pullulano negli States, studiato e approfondito nei College, ove si insegna la lingua e la letteratura italiana. Basta leggere la formazione umana e culturale dei quattro Founding Fathers of the United States, i Magnificent Four, da quel primo Washington che diede nome alla capitale federale per scorrere a John Adams, a Thomas Jefferson e a Benjamin Franklin. Bastano solo questi quattro pilastri, si badi di origine anglosassone, a dimostrare quanto la cultura, diciamo la “Civilisation”, con un termine creato da Arnold Toynbee nella sua magistrale e rivoluzionaria storia dell’umanità, quel sapere dell’antica Roma e poi dell’Italia medioevale e Rinascimentale siano state le radici istituzionali di quella confederazione che tra acquisti in moneta, come se fossero proprietà privata, e conquiste militari, 9850476 km2 in totale e circa 330 milioni di abitanti formano l’eterogeneità multietnica e multiculturale dei 50 stati e un distretto federale degli USA.
Mi auguro che il libro di Barbara Faedda, Élite. Cultura italiana e statunitense tra Settecento e Novecento (ed. Ronzani numeri, 2020) sia tradotto e divulgato capillarmente nelle moltissime istituzioni italiane che pullulano negli States, studiato e approfondito nei College, ove si insegna la lingua e la letteratura italiana. Basta leggere la formazione umana e culturale dei quattro Founding Fathers of the United States, i Magnificent Four, da quel primo Washington che diede nome alla capitale federale per scorrere a John Adams, a Thomas Jefferson e a Benjamin Franklin. Bastano solo questi quattro pilastri, si badi di origine anglosassone, a dimostrare quanto la cultura, diciamo la “Civilisation”, con un termine creato da Arnold Toynbee nella sua magistrale e rivoluzionaria storia dell’umanità, quel sapere dell’antica Roma e poi dell’Italia medioevale e Rinascimentale siano state le radici istituzionali di quella confederazione che tra acquisti in moneta, come se fossero proprietà privata, e conquiste militari, 9850476 km2 in totale e circa 330 milioni di abitanti formano l’eterogeneità multietnica e multiculturale dei 50 stati e un distretto federale degli USA.
La ragione ha un suo fondamento logico. Questi conquistatori inglesi non avevano una base storica politica a cui raccordarsi per inventare un nuovo Stato. Pesava anche l’antitesi naturale che discendeva dalla forte contrapposizione politica tra coloni e madre patria. Naturale quindi il ritorno alle origini della società occidentale e il ricorso alla legislazione romana dalle antiche leggi repubblicane fino ai codici di Giustiniano. Ma solo questo non bastava. C’era stato un processo di evoluzione storica da Livio a Cicerone a Tacito, ma il dibattito non si era fermato a partire dal De monarchia di Dante, attraverso i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di Machiavelli, a Guicciardini, fino a giungere ai contatti con i grandi storici e teorici a loro contemporanei della fine Settecento e inizio Ottocento, all’Alfieri con le sue odi di L’America libera, al Beccaria del rivoluzionario Dei delitti e delle pene.

Ecco, questo è il tema che Barbara Faedda, protagonista dal 2006 della Italian Academy, nella gloriosa sede di Casa Italiana, Executive Director della nuova e prestigiosa Academy for Advanced Studies presso la Columbia University, e dal maggio 2019 Ambassador, Permanent Observer for the European Public Law Organization to the United Nations, ha ritenuto necessario sviluppare. Si era già occupata della storia della Accademia, in «celebreting the Casa’s ninetieth anniversary», dal primo approccio attraverso l’insegnamento di Da Ponte, giunto a New York nel 1805, dopo una vita avventurosa condotta in Italia e la collaborazione con Mozart (Barbara Faedda, From Da Ponte to the Casa Italiana, A brief history of Italian Studies at Columbia University, Columbia University Press, New York, 2017). Ero stato presente, onorato di un invito al Symposium, nel 2018, quando era stata anche rappresentata The musical bee (L’ape musicale). Perciò ad essa rimandiamo per una più precisa ed esauriente storia.
Non proprio dal punto di vista della sua personale formazione legale, ma in un raggio assai ampio e complesso che abbraccia l’intera letteratura italiana, con qualche puntata al costume e alle tradizioni di quell’Italia di staterelli con governi diversi, presenza attiva il granducato di Toscana, come i principi di Savoia o la Lombardia austriaca, Roma e Napoli città protagoniste. Secondo me, la prima parte con le radici della civilisation degli United States of America risponde e illustra il debito immenso che essi devono alla cultura italiana. Ma non solo la letteratura a cominciare dai grandi storici, persino ai poeti latini, ma anche la grande architettura che trova la sua esaltazione in quel municipio di Philadelphia, toponomastico di “Amore fraterno”, termine greco che stupisce dal momento che in quelle radici fu quasi assente Omero, non si trova Platone e la grande oratoria ateniese. Qui furono studiate e organizzati gli articoli della Dichiarazione di Indipendenza del 1776 e la Costituzione del 1787.
L’analisi di Barbara Faedda affronta tutte le molteplici e complesse acquisizioni della cultura italiana, la fondazione per donazioni e acquisti delle grandi biblioteche di testi latini e italiani, in una strabiliante simbiosi tra personaggi di differente cultura, in uno scambio che nei quattro fari della civiltà statunitense non risparmiò alcun aspetto. Commoventi davanti alla moderna mistificazione dei prodotti italiani la questione dell’impianto delle viti e degli ulivi, le difficoltà per l’introduzione degli agrumi, le lodi e la passione del parmigiano da parte di Jefferson, oggetto oggi di contese di originalità, come dei “macaroni”, le risaie di Vercelli. E non meno emozionante quella tenuta di Washington a Mount Vernon con la sua villa in stile palladiano, il suo inesausto amore verso la nostra Italia, come quello di Thomas Jefferson e il suo Monticello, “small hill”, in Virginia, ancora in stile palladiano, i due Cincinnati di America.
Sarebbe troppo lungo e impossibile districarsi in questo intreccio di reciproci innesti, fino alla mescolanza di gusti e tendenze non solo culturali, ma culinarie e di costume, propriamente di innesto antropologico che fu l’età meravigliosa del Grand Tour che coinvolse tutto l’Occidente e vide il moltiplicarsi di diari e descrizioni etnografiche. In queste visite reciproche, alcune addirittura definitive sia da parte italiana, ma anche straordinaria da parte americana, si creò una miscela straordinaria di ideologie e di gusti.
Qui, rimandando alla lettura del saggio, voglio solo ricordare l’opera mostruosa di John Adams che nel momento del trasferimento della capitale da Filadelfia a Washington il 24 aprile 1800 istituì con cinque mila dollari la Library of Congress, nel Capitol fino al 1814, oggi Palazzo Thomas Jefferson, primo fondo l’immensa e preziosa biblioteca di Washington, e in seguito gli oltre sei mila libri di Jefferson. Oggi dislocata in tre edifici con un complesso di 50 milioni di manoscritti, 28 milioni di volumi, – ci ho trovato anche due mie saggi! – e materiale in 470 lingue, atti legali, film, spartiti e registrazioni, mappe.
Nella prevedibile e augurante nuova edizione sarebbero utili un indice bibliografico delle fonti librarie per rendere più facile la ricerca nella accurata ed encomiabile selva di citazioni, così forse anche un indice delle cose notevoli.
Questo consiglio a lode della ricchezza e della quantità, meticolosità e complessità delle fonti e della puntualità e minuziosità degli argomenti affrontati.
Esemplare e godibile la veste editoriale con la sua copertina in due fasce di diversa tonalità dal blu al celeste e quello scritto originale in cui si intravede quel Mr. Jefferson, fra tutti il più votato alla diffusione della cultura occidentale e italiana in particolare. Così agevoli e non stancabili i caratteri tipografici scelti nelle due versioni di testo e citazioni.












