Le assaggiatrici di Rosella Postorino, finalista al premio Campiello 2018, racconta la vicenda di un gruppo di ragazze reclutate per assaggiare, 3 volte al giorno, i piatti destinati a Hitler, al fine di accertarsi che non siano stati avvelenati.
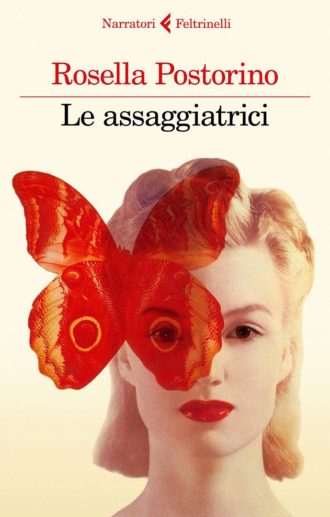 Una professione dal sapore medioevale, quella dell’assaggiatore, delicata e sottilmente umiliante come altre che portano a stretto contatto con il potere e qui soprattutto con il corpo del potere, con le sue esigenze, uguali peraltro in ogni essere umano (lo sa bene la satira che da sempre, per schernire i re e le regine, sottolinea la natura delle loro funzioni fisiologiche, perfettamente identiche a quelle dei sudditi).
Una professione dal sapore medioevale, quella dell’assaggiatore, delicata e sottilmente umiliante come altre che portano a stretto contatto con il potere e qui soprattutto con il corpo del potere, con le sue esigenze, uguali peraltro in ogni essere umano (lo sa bene la satira che da sempre, per schernire i re e le regine, sottolinea la natura delle loro funzioni fisiologiche, perfettamente identiche a quelle dei sudditi).
Nel romanzo della Postorino, il tema consente soprattutto di interrogarsi su uno dei dilemmi morali più impegnativi di sempre: fino a che punto è lecito compromettersi con il Male per tutelare se stessi o i propri cari? È un dilemma che riguarda chi vive sotto una dittatura ma potrebbe riguardare benissimo anche chi vive sotto la minaccia di una violenza mafiosa (oggetto di un precedente romanzo dell’autrice).
Rosa Sauer, l’io narrante, non è una fervente nazista. Non lo è nemmeno la famiglia del marito, che la ospita a Gross-Partsch in un piccolo paese della Germania, dove è sfollata dopo aver perso la propria casa, a Berlino, a causa dei bombardamenti. Siamo nelle ultime fasi della guerra: solo i fanatici ritengono che il nazismo abbia ancora qualche speranza. Rosa attende assieme ai suoceri il ritorno del suo sposo dal fronte. Ma all’improvviso la dittatura fa il suo ingresso, sotto forma di un drappello di SS che la recluta a forza per entrare a far parte delle assaggiatrici, una decina di ragazze che ogni mattina vengono prelevate dalle loro case per andare al “lavoro” per il Reich, ovvero per mangiare le pietanze riservate al Führer. Il paese, infatti, è pericolosamente vicino alla Wolfsschanze, la Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler mimetizzato nella foresta, sua penultima dimora prima del bunker finale, nonché luogo dove subirà l’attentato che, il 20 luglio del 1944, avrebbe potuto cambiare il corso dell’ultima fase della guerra (Hitler, come noto, si salvò, e i complottisti vennero giustiziati).
La vicenda è tratta dalle cronache dell’epoca e lo stesso personaggio di Rosa è ispirato a quello di Margot Wölk, che rese pubblica la sua vicenda di assaggiatrice solo nel 2012, all’età di 95 anni (Postorino per un soffio non è riuscita a conoscerla di persona, l’anziana assaggiatrice è scomparsa prima dell’incontro).
Mangiare è un atto pieno di implicazioni, anche simboliche. Qui, poi, l’atto salvifico, autoconservativo di nutrirsi assume il valore di un possibile sacrificio: le assaggiatrici mangiano per consentire ad Hitler di farlo, più tardi, in tutta tranquillità, e quindi eventualmente per sventare un attentato, morendo al suo posto. Dapprincipio, quella dell’assaggiatrice è un’attività angosciante. Ma siamo in tempo di guerra, cioè in tempo di ristrettezze alimentari. È inevitabile che nel mangiare le pietanze riservate al Führer le assaggiatrici provino anche piacere (nonostante non siano sempre particolarmente appetitose, Hitler osserva un regime alimentare rigido e ripudia la carne). Questo è solo uno dei cortocircuiti possibili suggeriti dal libro.
In realtà i problemi di ordine morale che si intrecciano nei pressi della Tana del Lupo, ed in particolare nella mensa che le ragazze frequentano ogni giorno, sotto stretta sorveglianza delle SS, toccano anche altri aspetti oltre a quello immediatamente legato al cibo. Dapprima la questione della menzogna: a Rosa, la “berlinese”, che il cuoco ha preso a benvolere, le altre assaggiatrici chiedono di rubare del latte dalla dispensa della cucina, per loro e per i propri figli. E’ giusto ingannare una persona magari non amica ma che svolge onestamente il proprio lavoro e ci ha fatto dono della sua fiducia, per un fine benevolo? E poi, il fine benevolo lo è davvero, oppure Rosa vuole soltanto essere accettata dal resto delle ragazze, e la questione diventa quindi se vale la pena o meno di correre il rischio di essere scoperta, per raggiungere quel risultato?
Più avanti, gli interrogativi assumono ben altra portata. Riguardano l’amore-passione, inteso come infedeltà, ma anche come comportamento da cui possono derivare vantaggi materiali, quindi l’amore con una persona che sta “sopra”, e che esercita il suo potere in maniera inflessibile, anche crudele. Riguardano inoltre la natura stessa del Male che il nazismo incarna e riassume, ovvero il razzismo, e di conseguenza la possibilità di accettare e “digerire” la sparizione di una persona cara, un’ebrea, perché si è impotenti, perché ribellarsi non servirebbe a nulla, se non a testimoniare il proprio assoluto dissenso.
Il romanzo di Postorino scorre fra la descrizione delle giornate trascorse dalle assaggiatrici, che ovviamente non vedranno mai Hitler di persona, alcuni colpi di scena che ne movimentano la trama, ed il disvelamento di dettagli relativi al Führer e alle sue abitudini alimentari (ad esempio, il suo consumo abnorme di pasticche contro la flatulenza, fino a 15 al giorno). Pur affrontando gli interrogativi a cui abbiamo brevemente accennato – e anche altri – non ha un approccio moralistico. Del resto, lo impedirebbe la scelta di dare la parola a Rosa, giovane donna impegnata in primo luogo a sopravvivere (cosa che, anche al suo alter-ego reale è riuscita particolarmente bene).
Ma se Rosa non è un’eroina, non si sacrifica come un padre Kolbe – non avrebbe nemmeno l’attrezzatura culturale per farlo – non è nemmeno cinica o indifferente al Male e alle sue conseguenze, come qualche altro memorabile personaggio della letteratura contemporanea (mi viene in mente ad esempio “l’uomo del corocoro” descritto da Céline nel Viaggio al termine della notte, contaminato da un altro tipo di Male, il sopruso coloniale).
L’interesse, qui, è rivolto piuttosto a quella zona grigia dove la maggior parte delle persone si ritaglia un nido provvisorio nelle situazioni eccezionalmente gravi, potendo in questo modo rimandare la propria morte, o aggirandola del tutto. In quella zona grigia hanno trovato riparo molti tedeschi, durante e dopo la guerra. Né pienamente complici con i volonterosi carnefici di Hitler , né pienamente innocenti. Ma forse in quella zona grigia ci ritroviamo anche noi, ogni giorno, pur non essendo in pericolo di vita: quando non ci opponiamo ad un’ingiustizia palese, quando per senso d’impotenza o amore del quieto vivere (l’accettazione sociale, la conservazione del nostro benessere, per modesto che sia) ci voltiamo dall’altra parte, o semplicemente ci adattiamo al corso delle cose.
Postorino dà vita a un microcosmo femminile sorvegliato severamente dagli uomini e dominato dalla paura perché sacrificabile, come attesta un incidente che fa presumere un effettivo tentativo di avvelenamento ai danni di Hitler. Il lettore si affaccia volentieri su questo microcosmo, ne segue le accelerazioni, alternate a momenti di stasi, ne segue gli scarti, le meschinità e le tragedie anche se non ne è mai pienamente coinvolto. La commozione, per strano che sia, arriva forse solo nel finale, in un’epoca e un luogo molto lontani da quelli in cui si consuma l’azione, ma non abbastanza da avere cancellato del tutto in Rosa il suo imprinting di assaggiatrice. Non c’è catarsi, non c’è redenzione. Ci sono semmai la consapevolezza, rassegnata, tardiva, di ciò che la guerra e il nazismo hanno eroso per sempre. Il grigiore di un’esistenza che dopotutto è continuata, malgrado la storia e le sue nefandezze.
La macchina dello storytelling procede senza intoppi, ben oliata. Se la materia del romanzo è complessa e “disturbante”, sintassi e trama non lo sono altrettanto. Il linguaggio è sobrio, pulito, descrittivo, non raggiunge le vette rarefatte del minimalismo durasiano (a cui pure Postorino è devota) ma nemmeno scivola nel barocchismo di tanti autori italiani (che spesso mi rendono la loro lettura indigesta). La consequenzialità narrativa è normalmente osservata (anche se la storia è uno scavo nella memoria della protagonista, il che le consente di formulare impressioni e giudizi “a posteriori”), a differenza ad esempio che in La ragazza con la Leica di Janeczek, altro romanzo a sfondo storico e atro candidato del Campiello, dove il lettore è sottoposto a continui salti temporali e a cambi di prospettiva.
Le assaggiatrici è insomma un romanzo che si fa leggere e questo forse che ha portato qualcuno (come Andrea Caterini, in un articolo sulla nuova letteratura italiana su Il Giornale) a sostenere che in queste pagine “non facciamo un passo fuori dall’ordinario” e che “il tema del libro non è che un tema deciso a tavolino”.
Apro una parentesi: ultimamente questa critica ritorna abbastanza spesso, per autori che hanno avuto anche un buon successo commerciale e di pubblico. Senza citare la solita Ferrante, pensiamo a Cognetti, Balzano, Di Pietrantonio. Tutti scrittori e scrittrici il cui stile non è particolarmente “sovversivo”, pur mantenendo comunque, almeno in alcuni casi, una sua riconoscibilità.
Trovo queste osservazioni – specie se espresse da critici come Caterini – in parte fondate, anche se non considero il quadro dipinto da Postorino consolatorio e la vicenda narrata risaputa. Come lettore, è vero, mi attendo sempre di essere destabilizzato. Accade ormai di rado, ma quando accade, ho la sensazione di essere in presenza di un capolavoro (o quantomeno di un’opera che propone un approccio diverso rispetto a quelli che mi sono noti). Certo, voglio che la letteratura sia qualcosa di più del mero intrattenimento, ed infatti inorridisco all’idea delle cosiddette letture “da ombrellone”, per definizione facili e rilassanti. La lettura – un certo tipo di lettura, come chiamarla? “Lettura “letteraria”? – è un atto di fede e di scoperta, un impegno etico ed estetico assieme.
Al tempo stesso, non credo possa essere stigmatizzata la capacità di narrare, che è spesso la cifra stilistica principale degli autori che ho citato. Ci sono romanzi che fanno egregiamente il loro mestiere di buoni romanzi senza con ciò inaugurare una nuova stagione letteraria (così come ci sono canzoni che fanno il loro mestiere di buone canzoni senza diventare le nuove Nel blu dipinto di più, Yesterday o Like a Rolling Stone). E’ così oggi, ai tempi delle scuole di scrittura, ma era così anche in passato. Un pezzo del giudizio finale, peraltro, è sempre appaltato ai posteri.
Peraltro, la ricerca ossessiva di uno stile “unico”, che estorca alla vicenda narrata il suo carico di ambiguità e complessità (la letteratura non può esimersi dal farlo) a sua volta rischia di risultare stucchevole, se non attentamente governata. Penso ad esempio al ripudio della trama lineare: se in Underworld di De Lillo (ma potrebbe valere anche per L’Amante della Duras, solo per citare un altro titolo notissimo), raggiunge vertici difficilmente superabili, in altri casi è puro manierismo.
Le assaggiatrici è stato acquistato da molti editori stranieri e ha creato forti aspettative anche negli USA, dove se ne parla come di un nuovo The Reader. Niente di più probabile che ne venga tratto un film.












