Ci sono luoghi segnati per sempre da un evento storico; altri che ne hanno viste di tutti i colori, e si possono prestare perciò ad ogni genere di narrazione. Fra i secondi ci sono metropoli come New York o Roma. Otranto appartiene invece alla prima specie. L’evento-simbolo di Otranto è una strage, anzi, un genocidio, per dirla con un’espressione di oggigiorno: l’uccisione di tutti i maschi al di sopra dei 15 anni, e la riduzione in schiavitù di donne e bambini, in seguito alla presa della città da parte dei Turchi, nel 1480. L’episodio più cruento ebbe luogo al termine dell’assedio, il 14 di agosto: la storia racconta che gli Ottomani, agli ordini di Gedik Ahmet Pascià, proposero agli abitanti rimasti di convertirsi all’Islam, avendo in cambio salva la vita. Gli idruntini (così sono anche detti gli abitanti di Otranto, da Hydruntum, il nome romano della città) si rifiutarono. Così 800 di essi furono decapitati sul colle della Minerva. I loro resti – teschi e ossa – sono oggi visibili in tre grandi teche nella cappella dei Martiri della cattedrale (e in parte anche nel duomo di Napoli). Dietro l’altare della cappella, seminascosta, la pietra della decapitazione.

Un evento del genere non poteva non imprimere un segno imperituro, almeno nella mente degli artisti e dei letterati, e forse spiega il carattere un po’ “creepy”, terrorizzante, inquietante, dei romanzi qui ambientati. Anche se Otranto oggi è Patrimonio Culturale dell’Unesco, membro del Club dei borghi più belli d’Italia, nonché apprezzatissima meta balneare.
Tre i romanzi fondamentali: Il castello di Otranto, di Horace Walpole (1764), Otranto di Roberto Cotroneo (1997), L’ora di tutti di Maria Corti (1962).
 Partiamo da Walpole: Il castello di Otranto è un libro famoso, perché considerato l’iniziatore del genere gotico. Maturato nel corso dell’800, il gotico unisce gli stilemi del romanzo moderno, essenzialmente realista e naturalista, con quelli del canone precedente, per quanto riguarda la letteratura anglosassone in particolare il canone shakespeariano (parliamo qui dello Shakespeare dell’Amleto, con i suoi castelli e i suoi fantasmi). Come scrisse lo stesso autore nell’incipit Il castello di Otranto è stato un tentativo, all’epoca molto apprezzato dal pubblico, che ne decretò il rapido successo, di unire “le due anime della narrativa, l’antico e il moderno. In principio era tutto immaginazione ed improbabilità: in seguito, la natura è sempre stata copiata con successo… L’autore delle pagine seguenti ritiene possibile riconciliare i due tipi”.
Partiamo da Walpole: Il castello di Otranto è un libro famoso, perché considerato l’iniziatore del genere gotico. Maturato nel corso dell’800, il gotico unisce gli stilemi del romanzo moderno, essenzialmente realista e naturalista, con quelli del canone precedente, per quanto riguarda la letteratura anglosassone in particolare il canone shakespeariano (parliamo qui dello Shakespeare dell’Amleto, con i suoi castelli e i suoi fantasmi). Come scrisse lo stesso autore nell’incipit Il castello di Otranto è stato un tentativo, all’epoca molto apprezzato dal pubblico, che ne decretò il rapido successo, di unire “le due anime della narrativa, l’antico e il moderno. In principio era tutto immaginazione ed improbabilità: in seguito, la natura è sempre stata copiata con successo… L’autore delle pagine seguenti ritiene possibile riconciliare i due tipi”.
Il lettore di oggi in verità riconduce più facilmente il romanzo di Walpole al passato, a Shakespeare ma anche altra letteratura elisabettiana, che non al romanzo “borghese”, ottocentesco, o anche a classici nella letteratura gotica come Frankenstein di Mary Shelley. La storia è ambientata nel castello che ancora oggi domina il centro storico del borgo salentino, e ruota attorno a Manfredi, principe d’Otranto, che perde il figlio prediletto, Corrado, il giorno in cui avrebbe dovuto convolare a nozze con Isabella, la figlia del marchese di Vicenza. La sera stessa Manfredi propone a Isabella di sposare lui. Ancora scossa dalla morte del promesso sposo (piuttosto grottesca. è rimasto schiacciato dalla caduta di un enorme elmo) Isabella scappa per un sotterraneo, dove fa strani incontri. Manfredi intanto viene perseguitato dallo spettro di un suo antenato…
Castelli, morti inspiegabili, oscure trame familiari, passaggi segreti: gli ingredienti di tanti romanzi del terrore ci sono tutti. Otranto, invece, è assente: la storia ha poco o nulla di realistico, e si svolge prevalentemente dentro al castello, che a sua volta è una creazione di fantasia, di un’ispirazione nata, come ebbe a spiegare Walpole, da un sogno. Ma il romanzo dell’autore inglese ha ritagliato per sempre alla cittadina un ruolo non piccolo nel pantheon dei luoghi letterari.
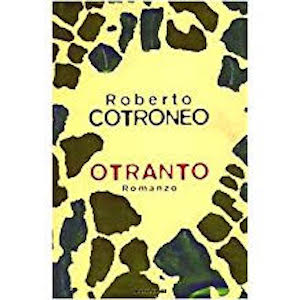 Gli altri due romanzi, italiani, recenti, si occupano invece entrambi della strage. Partiamo da quello che oggi è più noto e più letto, cioè quello di Roberto Cortoneo, che ha continuato anche dopo la pubblicazione di Otranto, suo seconda prova narrativa, a scrivere della cittadina del Salento e ad organizzarvi iniziative culturali (anche nell’estate appena conclusasi). Protagonista del romanzo di Cotroneo – autore che per molti anni è stato anche un severo recensore sulle pagine del settimanale L’Espresso – è una giovane olandese, Helena, giunta in città per lavorare al restauro del grande mosaico pavimentale della cattedrale, un’opera del XII secolo, densa di simboli. Fin dall’inizio il lettore è calato in un’atmosfera sospesa, onirica, carica di mistero e di presagi. Ci sono la speciale luce della Puglia, ci sono i colori del mosaico, ci sono presenze inquietanti, ci sono i malori e le visioni della protagonista, legata ad Otranto da lontani legami di sangue. Molte le descrizioni, molti gli aggettivi, pochi i dialoghi. Potremmo essere dalle parti de Il pendolo di Foucault di Umberto Eco: una vicenda che si svolge ai giorni nostri ma che rimanda a vicende del passato, a memorie e saperi “sepolti”, solo che qui non ci sono l’ironia e l’arte affabulatoria del compianto professore, né la sua capacità di costruire dei veri e propri thriller, seppure coltissimi. Ed infatti, se il romanzo si carica via via di aspettative e di domande, esse alla fine vengono sciolte solo parzialmente. Ciò non toglie che le sue pagine emanino una notevole suggestione, e possano spingere chi giunge nel Salento per il mare e la pizzica a guardare a quel gioiello che è Otranto con occhi diversi.
Gli altri due romanzi, italiani, recenti, si occupano invece entrambi della strage. Partiamo da quello che oggi è più noto e più letto, cioè quello di Roberto Cortoneo, che ha continuato anche dopo la pubblicazione di Otranto, suo seconda prova narrativa, a scrivere della cittadina del Salento e ad organizzarvi iniziative culturali (anche nell’estate appena conclusasi). Protagonista del romanzo di Cotroneo – autore che per molti anni è stato anche un severo recensore sulle pagine del settimanale L’Espresso – è una giovane olandese, Helena, giunta in città per lavorare al restauro del grande mosaico pavimentale della cattedrale, un’opera del XII secolo, densa di simboli. Fin dall’inizio il lettore è calato in un’atmosfera sospesa, onirica, carica di mistero e di presagi. Ci sono la speciale luce della Puglia, ci sono i colori del mosaico, ci sono presenze inquietanti, ci sono i malori e le visioni della protagonista, legata ad Otranto da lontani legami di sangue. Molte le descrizioni, molti gli aggettivi, pochi i dialoghi. Potremmo essere dalle parti de Il pendolo di Foucault di Umberto Eco: una vicenda che si svolge ai giorni nostri ma che rimanda a vicende del passato, a memorie e saperi “sepolti”, solo che qui non ci sono l’ironia e l’arte affabulatoria del compianto professore, né la sua capacità di costruire dei veri e propri thriller, seppure coltissimi. Ed infatti, se il romanzo si carica via via di aspettative e di domande, esse alla fine vengono sciolte solo parzialmente. Ciò non toglie che le sue pagine emanino una notevole suggestione, e possano spingere chi giunge nel Salento per il mare e la pizzica a guardare a quel gioiello che è Otranto con occhi diversi.
 Infine L’ora di tutti, opera più volte ripubblicata nel corso degli anni di un’autrice, scomparsa nel 2002, che è stata anche docente universitaria, critica letteraria, filologa. Siamo, di nuovo, nel 1480. Qui, però, a differenza che nel romanzo di Cotroneo, la storia non è evocata da creature sfuggenti, sogni o manifestazioni del “perturbante”, ma costituisce la materia stessa del romanzo. Protagonisti sono infatti cinque personaggi diversi, attraverso i quali seguiamo le varie fasi della battaglia, dall’arrivo della imponente flotta ottomana alla resistenza degli abitanti della cittadella fino alla resa e alla strage finale. Ogni personaggio parla con la propria voce, descrive le situazioni di cui è stato protagonista e finanche, in qualche caso, la sua morte: il pescatore Colangelo, sentinella sulle mura difensive, il governatore di Otranto, capitano Zurlo, la bellissima Idrusa, vedova di un pescatore, ragazza “selvaggia” ed insieme eroica, diventata una delle figure femminili più famose e studiate della cultura letteraria salentina, Nachira, che sopravvive alla battaglia vera e propria ma viene poi decapitato come gli altri 800 che rifiutarono di convertirsi, e infine Aloise de Marco, che racconta della rinascita della città dopo la liberazione dai Turchi, avvenuta solo un anno dopo la presa.
Infine L’ora di tutti, opera più volte ripubblicata nel corso degli anni di un’autrice, scomparsa nel 2002, che è stata anche docente universitaria, critica letteraria, filologa. Siamo, di nuovo, nel 1480. Qui, però, a differenza che nel romanzo di Cotroneo, la storia non è evocata da creature sfuggenti, sogni o manifestazioni del “perturbante”, ma costituisce la materia stessa del romanzo. Protagonisti sono infatti cinque personaggi diversi, attraverso i quali seguiamo le varie fasi della battaglia, dall’arrivo della imponente flotta ottomana alla resistenza degli abitanti della cittadella fino alla resa e alla strage finale. Ogni personaggio parla con la propria voce, descrive le situazioni di cui è stato protagonista e finanche, in qualche caso, la sua morte: il pescatore Colangelo, sentinella sulle mura difensive, il governatore di Otranto, capitano Zurlo, la bellissima Idrusa, vedova di un pescatore, ragazza “selvaggia” ed insieme eroica, diventata una delle figure femminili più famose e studiate della cultura letteraria salentina, Nachira, che sopravvive alla battaglia vera e propria ma viene poi decapitato come gli altri 800 che rifiutarono di convertirsi, e infine Aloise de Marco, che racconta della rinascita della città dopo la liberazione dai Turchi, avvenuta solo un anno dopo la presa.

Già solo per la scelta di dar voce a cinque personaggi diversi il romanzo si imprime nella memoria e rimane, nonostante qualche imprecisione storica, un buon punto di partenza per addentrarsi nella tragica vicenda (a cui potremmo accostare, ai giorni nostri, e a parti invertite, ad esempio quella di Srebrenica, la cittadina bosniaca dove, nel 1995, oltre 8000 musulmani vennero trucidati dalle milizie serbo-bosniache). Solo un’osservazione finale: come sempre, mettersi nei panni dell’altro risulta la cosa più difficile, anche per uno scrittore. Il punto di vista dei Turchi, qui, non emerge, così non è mai emerso, che io ricordi, il punto di vista dei Vietcong nei film girati dagli americani sulla guerra del Vietnam, neanche in quelli più critici verso l’impegno americano (un po’ meglio è andata, anche se tardivamente, ai nativi americani).
Sia come sia, visitate Otranto. Fatelo “dal vivo”, se non l’avete già fatto, e fatelo anche attraverso queste pagine. Scoprirete una delle tante tessere che fanno dell’Italia un mosaico culturalmente così affascinante. E al tempo stesso, una parte di quelle memorie di sangue di cui il nostro suolo è intriso.












