Il tema di Eccomi (Here I Am), l’ultimo, attesissimo romanzo di Jonathan Safran Foer, a 11 anni dal precedente Molto forte, incredibilmente vicino (Extremely Loud and Incredibly Close), è la crisi di coppia. Una coppia borghese, americana, di origini ebraiche, Jacob e Julia: lui sceneggiatore, lei architetta, tre figli maschi, nonni che, come spesso accade, un po’ aiutano e un po’ complicano ulteriormente l’esistenza. Un Bar Mitzvah da organizzare per il figlio più grande, con tanto di parenti in arrivo a Washington D.C. da Israele per festeggiarlo. Sembrerebbe un campionario di cose già viste. Invece, è il succo di un romanzo splendido.
“Eccomi” (Hinneni) è ciò che risponde Abramo a Dio quando lo chiama, per chiedergli di sacrificare suo figlio Isacco. “Qualunque cosa Dio voglia, Abramo è completamente presente per Lui, senza condizioni, o riserve, o necessità, o spiegazioni”. Ma Abramo è anche un padre. E quando Isacco lo chiama, “Padre mio!”, risponde in maniera analoga: “Eccomi, figlio mio”. Come può Abramo essere due cose contemporaneamente? L’uomo che si affida a Dio, senza riserve, e il padre che accudisce suo figlio?
Come fanno Jacob e Julia ad essere al tempo stesso due genitori presenti, vigili, del tutto consapevoli dei propri ruoli, e due coniugi rattrappiti ciascuno nel proprio guscio, che non si confidano, che non si sfiorano nemmeno? Come fanno ad andare avanti senza sesso? Come fanno a non morire di trombosi, se il canale della comunicazione, che un tempo li univa, ora è ostruito da tutti quei residui che la vita coniugale trascina con sé?
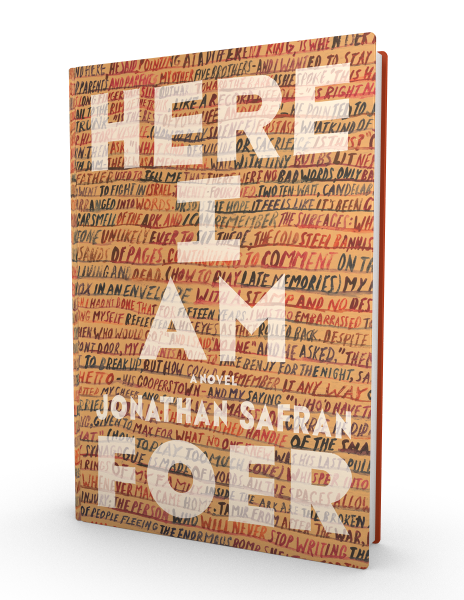 Il libro di Foer consta di 661 pagine e di piste ne esplora più di una, ma questa è la principale. Ciò che il matrimonio maschera, omette, oppure cerca faticosamente di conciliare. Fonte di innumerevoli recriminazioni ma anche di precari equilibri, che reggono, spesso, per tutta una vita.
Il libro di Foer consta di 661 pagine e di piste ne esplora più di una, ma questa è la principale. Ciò che il matrimonio maschera, omette, oppure cerca faticosamente di conciliare. Fonte di innumerevoli recriminazioni ma anche di precari equilibri, che reggono, spesso, per tutta una vita.
Nessuno nella sua famiglia ha mai risposto a nessun altro “Eccomi!”, pensa Sam, accusato dalla Casa Ebraica di avere compilato una lista piena di ingiurie, in particolare ingiurie a sfondo razzista (notare il sottile paradosso: qui non c’è un’istituzione conformista che mette sotto accusa un adolescente per il suo essere ribelle, ma un’istituzione progressista che punta il dito contro un comportamento censurabile perché politicamente scorretto). Sam, nella sua preadolescenza (o è adolescenza? Anche su questo Jacob e Julia sono in disaccordo) è ingeneroso: il padre in realtà gli crede, quando sostiene di non essere lui l’autore della lista infamante, anche se forse lo fa per amore del quieto vivere; la madre invece non gli crede ma non per mancanza di fiducia, piuttosto perché concentrata sui suoi doveri educativi e sulla necessità pratica di tacitare la polemica, rendendo possibile lo svolgimento del Bar Mitzvah.
Ogni personaggio di questo libro ha un’altra vita da qualche parte, un retropensiero, un movente occulto, nessuno è del tutto presente ad un altro, nessuno è trasparente, nudo, a disposizione, come Abramo di fronte a Dio. Ma nessuno è spregevole o cattivo.
Jacob ha la sua corrispondenza erotica, la sua attrazione per le catastrofi e la sua consultazione compulsiva dei siti delle agenzie immobiliari. Julia coltiva il sogno di possedere finalmente la casa perfetta, con una sola camera da letto; ma il suo desiderio supremo è avere tempo e spazio per sé, anche se nel suo “giorno libero” non trova niente di meglio da fare che infilarci altro lavoro, schivare la seduzione di un cliente appena separatosi dalla moglie e tornare a casa prima.
Sam invece ha una doppia vita elettronica, in Other Life: l’ha chiamata Samanta, e governa un universo costruito meticolosamente con l’ausilio dell’Ipad, compresa una sinagoga da far esplodere nel giorno fissato per il suo Bat Mitzvah virtuale, non in odio al rito di passaggio (che nella cultura ebraica segna l’ingresso dei bambini e delle bambine nell’età adulta) quanto piuttosto perché quella sinagoga lì non è perfetta, non è la sinagoga. Max e Benjy, i due fratelli di Sam, non sono da meno, il primo con la sua intelligenza precoce e tagliente, il secondo con il suo sguardo stupefatto che si posa sul mondo che lo circonda.
 C’è però un’altra pista, da seguire, luminosa. Viene annunciata nell’incipit: “Quando la distruzione di Israele ebbe inizio…”. Fa pensare ad uno scenario un po’ alla De Lillo, uno di quegli universi paralleli o di quelle distopie che vanno molto di moda. In effetti è così: c’è un terremoto spaventoso che squassa la Terra Santa, che in un paio di settimane apre la strada ad una guerra definitiva dei paesi arabi contro Israele (estremamente efficace il brevissimo capitolo 15 giorni in 5.000 anni, in cui si descrive come ciò potrebbe accadere, con la complice indifferenza degli Stati Uniti). Ma non è tutto qui. Quello che potrebbe essere solo un furbo riempitivo, è invece l’altro pilastro su cui si regge l’edificio narrativo edificato da Foer, quello relativo alla condizione ebraica, esemplificata dal confronto fra la famiglia Bloch e i parenti d’Israele che circa a metà romanzo arrivano in visita, così diversi, nella loro esagerata vitalità, ma anche dalla presenza di tanti altri personaggi “minori” (straordinario il giovane rabbino).
C’è però un’altra pista, da seguire, luminosa. Viene annunciata nell’incipit: “Quando la distruzione di Israele ebbe inizio…”. Fa pensare ad uno scenario un po’ alla De Lillo, uno di quegli universi paralleli o di quelle distopie che vanno molto di moda. In effetti è così: c’è un terremoto spaventoso che squassa la Terra Santa, che in un paio di settimane apre la strada ad una guerra definitiva dei paesi arabi contro Israele (estremamente efficace il brevissimo capitolo 15 giorni in 5.000 anni, in cui si descrive come ciò potrebbe accadere, con la complice indifferenza degli Stati Uniti). Ma non è tutto qui. Quello che potrebbe essere solo un furbo riempitivo, è invece l’altro pilastro su cui si regge l’edificio narrativo edificato da Foer, quello relativo alla condizione ebraica, esemplificata dal confronto fra la famiglia Bloch e i parenti d’Israele che circa a metà romanzo arrivano in visita, così diversi, nella loro esagerata vitalità, ma anche dalla presenza di tanti altri personaggi “minori” (straordinario il giovane rabbino).
“Suo padre era fissato con lo sfoggio di ottimismo, con l’accumulo immaginario di proprietà e con le battute; sua madre con il contatto fisico prima di salutarsi e con l’olio di fegato di merluzzo e le giacche per uscire e ‘la cosa giusta da fare’; Max con l’empatia estrema e l’alienazione autoimposta; Benjy con la metafisica e l’incolumità fisica. E lui, Sam, desiderava sempre. Cos’era quel sentimento? Aveva qualcosa a che fare con la solitudine (sua e altrui), qualcosa con la sofferenza (sua e altrui), qualcosa con la vergogna (sua e altrui), qualcosa con la paura (sua e altrui). Ma anche qualcosa con la convinzione caparbia e la dignità caparbia e la gioia caparbia. Eppure non era davvero nessuna di queste cose né la loro somma. Era il sentimento di essere ebreo. Ma che sentimento era?”.
Tutta la seconda parte del romanzo è attraversata da questo tema che è anche una domanda. Ed è proprio l’incontro delle due piste a trasformare un ottimo romanzo dedicato “solo” ad una crisi matrimoniale in qualcosa di unico. A prescindere dal fatto, giova ripeterlo, che gli eventi che si consumano nella famiglia Bloch non sono così diversi rispetto a quelli che accadono in ogni altra famiglia. Jacob smarrisce incautamente il suo cellulare segreto; Julia lo trova e legge i messaggi erotici che il marito scrive ad una collega di lavoro con la quale, giura, “non c’è mai stato altro”. C’è situazione meno canonica, nel mondo dei gadget per la comunicazione di massa che ci siamo costruiti? Eppure la trama incatena. Per 600 e rotte pagine. E dal momento che la lunghezza dei romanzi è tornata ad essere un argomento di discussione anche in Italia, dopo La scuola cattolica di Albinati, è bene ribadirlo chiaramente, la lunghezza non è di per sé un pregio ma non è neanche un ostacolo, non lo è mai stato con i classici russi, non lo è con un libro come questo.
Qual è il segreto, dunque (a parte quanto abbiamo già detto, a parte, cioè, tutto il rimestare nel calderone sulfureo dell’ebraismo, da Mosè ad Anna Frank)? In primo luogo i dialoghi. Certo, l’io narrante onnisciente ci mette del suo. Ma il motore della narrazione sono i dialoghi. Incalzanti, serrati, arguti, a volte commoventi. I bambini sono troppo maturi e strafottenti, forse, ma una volta accettato il loro linguaggio, seguirli – specie quando fanno a pezzi i loro genitori– è un vero divertimento, o una vera sofferenza, a seconda dei punti di vista.
Poi ci sono i ripetuti cambi di registro. La Bibbia e All Apologies dei Nirvana, le riflessioni filosofiche e la realtà virtuale, gli excursus socio-geografico-politici e l’eros, che ritorna continuamente, sia quando è consumato in coppia, sia quando è un passatempo solitario, sia infine quando viene meno, per mancanza di desiderio (Foer lo chiama nelle interviste “pornografia”, ed in effetti il tono dei messaggi che Jacob computa nel suo cellulare non lascia nulla all’immaginazione, sembra preso di peso dai cataloghi di Youporn, se sapete cosa voglio dire).
 Qualcuno è partito precisamente da qui per avanzare la sua critica: Eccomi sarebbe “troppo”, troppo ambizioso, troppo dettagliato, troppo prigioniero della smania che lo stesso autore ha confessato, quella di “dire tutto” (critica che di solito viene rivolta ai romanzi degli esordienti). Ma non è vero. In questo romanzo non c’è tutto. C’è, se vogliamo, qualche pagina di troppo (francamente non sentivamo il bisogno di un nuovo pirotecnico excursus sulla masturbazione adolescenziale maschile, avevamo già Il lamento di Portnoy). C’è invece una grande attenzione al dettaglio, che però non diventa maniacal-ossessiva come in Foster Wallace, essendo governata da una scrittura che vuol bene al lettore prima che a se stessa. C’è una tensione continua, perfettamente governata, che a volte, più spesso nei capitoli finali, fa scaturire dall’intreccio vera commozione.
Qualcuno è partito precisamente da qui per avanzare la sua critica: Eccomi sarebbe “troppo”, troppo ambizioso, troppo dettagliato, troppo prigioniero della smania che lo stesso autore ha confessato, quella di “dire tutto” (critica che di solito viene rivolta ai romanzi degli esordienti). Ma non è vero. In questo romanzo non c’è tutto. C’è, se vogliamo, qualche pagina di troppo (francamente non sentivamo il bisogno di un nuovo pirotecnico excursus sulla masturbazione adolescenziale maschile, avevamo già Il lamento di Portnoy). C’è invece una grande attenzione al dettaglio, che però non diventa maniacal-ossessiva come in Foster Wallace, essendo governata da una scrittura che vuol bene al lettore prima che a se stessa. C’è una tensione continua, perfettamente governata, che a volte, più spesso nei capitoli finali, fa scaturire dall’intreccio vera commozione.
In questa capacità di raccontare i tempi nostri, le nostre vite borghesi e “occidentali”, le nostre insoddisfazioni, le nostre piccinerie e le nostre grandezze, che si stagliano come shilouette sullo sfondo dei drammi collettivi che TV e web ci portano continuamente in casa, la narrativa americana rimane insuperabile.
Jonathan Safran Foer, Eccomi, Guanda, 2016 (trad. Irene Abigail Piccinini). Uscita prevista negli USA, per Farrar, Straus and Giroux, il prossimo 29 settembre (in Italia è stato pubblicato alla fine di agosto).











