Purity, il nuovo romanzo di Jonathan Franzen, da poco pubblicato anche in Italia, non mi ha convinto. Se voleva essere un missile lanciato contro il mondo di Internet, trovo sia stata più efficace la raccolta di saggi Come stare soli (pubblicata in Italia da Einaudi, come il resto della produzione di Franzen). Se invece Purity costituisce una nuova manifestazione del grande romanzo americano (se non del grande romanzo realista tout court), l’impressione, alla prima lettura – e temo non ve ne saranno altre – è che sia strutturalmente inferiore sia rispetto a Le correzioni sia anche a Libertà. Tuttavia, essere inferiore rispetto a due capolavori del genere non ne fa un cattivo romanzo: ci sono alcune parti – in particolare quelle che hanno per protagonista Tom Aberant, un giornalista d’inchiesta, e quelle berlinesi – davvero molto avvincenti. Altre invece vanno dal fastidioso all’indigeribile, in particolare Moonglow Dairy, che narra dell’incontro in Bolivia fra la protagonista, una stagista di nome Pip (nome accettabile in Dickens ma non necessariamente qui, soprattutto se appiccicato ad un personaggio simpatico come un’infezione da mononucleosi) e l’eroe del web Andreas Wolf, che come tutti sanno è l’alter-ego di Julian Assange.
Complessivamente intesa, Purity è un’occasione colta solo in parte e sono convinto che fra 10 anni chi guarderà retrospettivamente all’opera di Franzen giungerà alla stessa conclusione. Ma procediamo con ordine, conformemente all’implacabile rigore che Franzen ha applicato alla costruzione del suo romanzo-fiume (un rigore che gli va riconosciuto, ma che forse, in dosi così massicce è anche responsabile di quell’eccesso di controllo che si avverte a volte, procedendo di pagina in pagina. Del resto i detrattori di Franzen hanno sempre sostenuto che lui è solo tecnica: un giudizio, sia chiaro, del tutto ingeneroso).
Partiamo dalla trama. Purity ha una molla molto classica: la ricerca della verità. La protagonista, Purity Tyler, “Pip”, una stagista già seppellita, a 22 anni, da un debito studentesco di 140.000 dollari, vuole sapere chi è suo padre, un uomo che la madre le ha dipinto come pericoloso rifiutandosi però di rivelare di più. Pip vive in uno squat: Franzen ama descrivere quest’America “alternativa”, non esattamente la prima cosa a cui pensiamo in Europa quando rivolgiamo il nostro sguardo agli USA (in Libertà era il mondo ecologista, qui oltre agli squatter e agli hackers ci sono i vegetariani/vegani, ma forse il reale bersaglio dell’autore è il rivale Jonathan Safran Foer, animalista dichiarato, che si guadagna una citazione beffarda – con nome storpiato – in un passaggio del romanzo). Comunque, è in questo squat di Oakland che Pip viene messa in contatto con il Sunlight Project, progetto simil-WikiLeaks gestito dal carismatico Andreas Wolf, che mette on-line i segreti di mezzo mondo, grazie ad una potente rete di hackers e ad alcune protezioni internazionali (come quella garantitagli dalla Bolivia di Evo Morales). Dopo qualche tira e molla via mail, Pip decide di accettare l’offerta di Wolf di effettuare uno stage pagato nel paese latinoamericano. L’incontro fra i due è la parte del libro che più ho fatto fatica a superare: sembra di essere dalle parti delle Cinquanta sfumature di grigio, salvo che qui la studentessa inesperta, dopo aver portato per ben due volte all’erezione il maturo, affascinante anfitrione, lo lascia a bocca asciutta (il lettore è abituato a questo comportamento di Pip avendone già fatta esperienza nello squat, dove un altro malcapitato è stato messo in attesa per tre quarti d’ora con pantaloni calati, mentre lei imburrava un toast e compilava un questionario per la Sunlight).
In tutto questo entra pesantemente il comunismo, in particolare quello della DDR, la Repubblica democratica tedesca o Gemania Est, prima della caduta del Muro di Berlino e della riunificazione. Andreas Wolf, infatti, viene da lì, e lì ha seppellito un tenebroso segreto di gioventù. Non a caso si chiama Wolf, ossia Lupo, e il suo demone è l’Assassino.

Ma c’è anche dell’altro: c’è un giornale d’inchiesta di Denver, nel quale Pip ad un certo punto viene spedita da Wolf a “collaborare”, nonché a spiare (nulla è ciò che sembra), guidato dalla coppia meglio disegnata del romanzo, Tom e Leila, entrambi inclini al sacrificio e all’automortificazione. E c’è una misteriosa vicenda riguardante la sparizione di un ordigno nucleare, su cui il giornale sta indagando: ovviamente quando in un grande romanzo americano compare il nucleare il pensiero corre a Underworld di De Lillo ( difficile però arrivare fino a quel bunker in Asia centrale dove De Lillo ci fa assistere alla detonazione degli ordigni dismessi, nel suo memorabile capolavoro).
Sulla fine non si deve dir nulla, ma, in confidenza, trasuda un moralismo facile: la cattiveria viene punita e la bontà premiata, e sul tutto aleggia anche un’eredità miliardaria, come nelle migliori favole. Non si legge un romanzo così per sapere come va a finire, ma certo, l’epilogo malinconico di Libertà si fa rimpiangere.
Veniamo ai personaggi. Se fossi il lettore di un’agenzia letteraria e avessi ricevuto questo manoscritto in forma anonima, avrei risposto a Franzen: cambia i protagonisti, il lettore ha bisogno di qualcuno con cui identificarsi. È una regola stupida, lo so. È stupida come la scolasticità delle agenzie letterarie. Tuttavia, qui a volte se ne sente la mancanza. Prendiamo Andreas e Pip: sono entrambi troppo irritanti per provare dell’empatia nei loro confronti. No, i personaggi di maggior successo del romanzo sono altri e sono soprattutto di sesso femminile. Certo, si tratta di caratteri sempre molto disturbati. La madre di Pip, che nelle prime righe si rivolge a lei con uno squillante “micetta”, ve la lascio immaginare, ma non è che la prima moglie di Tom – ricchissima, anche se ha rinunciato a tutto per odio nei confronti della famiglia d’origine, vegana, artista velleitaria che passa 10 anni a cercare di filmare pezzi del proprio corpo per un film sperimentale – sia molto diversa. La madre di Andreas Wolf? Una seduttrice compulsiva, che si è sbarazzata del vero padre di Andreas, nonché suo amante, facendolo incarcerare dalla Stasi, la polizia politica che dettava legge nella Germania Est. E quella di Tom? E la madre della madre? Uh, mamma mia!
Il messaggio può essere ovviamente quello classico di Franzen, le famiglie covano ogni genere di disfunzionalità, e come tale dobbiamo prenderlo, in parte perché è vero, in parte perché rappresenta uno dei pilastri della sua narrativa, e se lo togli, viene giù tutto. Ma certo, qui il concetto viene ribadito forse con qualche insistenza di troppo.
Resta il fatto che Franzen è un fuoriclasse nel raccontare nevrosi, depressioni, disadattamenti. Clelia, la madre di Tom, è un esempio memorabile. Profuga della DDR, in fuga dalla madre dispotica, va in sposa al primo americano gentile – e idealista – che incontra a Berlino Ovest, ma una volta approdata in America non simpatizza per le cause umanitarie del marito, quanto piuttosto per le corporation e Ronald Reagan. Quando verrà a contatto con il mondo dei veri ricchi, rappresentato dalla nuora, rampolla di un impero industriale (specializzato nella produzione di carni e mangimi) la sua delusione sarà profondissima. Debole, malata, eppure coriacea, fino in fondo “tedesca”, Clelia è davvero qualcosa che resta, a fine lettura, e oltretutto ci distrae dalla tentazione di andare continuamente con il pensiero a Milan Kundera e Herta Muller, tentazione sempre presente quando in un romanzo compare il mondo plumbeo dell’Europa comunista.
Anche certi tratti nevrotici di Wolf sono indubbiamente ben tratteggiati. Il suo passare da una devozione quasi folle per Annagrette, la quindicenne conosciuta quando faceva l’assistente sociale nei sotterranei di una chiesa (scopandosi 53 delle giovani che gli chiedevano aiuto), all’avversione più radicale, il suo discendere gli abissi della dipendenza dal cyberg sex, per non dire del suo cinismo nel manipolare Pip per i suoi scopi, costituiscono un acuto lavoro di scavo psicologico.
Ma soprattutto, come già detto, abbiamo Tom. Che ci racconta sia del fallimento del suo matrimonio sia di come abbia conosciuto Andreas Wolf, a Berlino, subito dopo la caduta del Muro, e di come gli abbia fatto un favore di quelli che non si dimenticano. Tom, è l’unico nel romanzo ad avere l’onore di poter prendere la parola in prima persona. Come se Franzen si fosse reso conto che qui aveva per le mani un narratore di prim’ordine, un vero protagonista. Uno che dice: “Non parlatemi di odio se non siete stati sposati. Solo l’amore, solo una lunga storia di empatia, identificazione e compassione possono radicare un’altra persona nel vostro cuore così in profondità da non permettervi più di sfuggire al vostro odio per lei; soprattutto quando ciò che odiate di più è la sua capacità di farsi ferire da voi”.
E veniamo alla struttura. La struttura di Purity è quella tipica dei Grandi Romanzi Americani (in parte dei Grandi Romanzi tout court). È caratterizzata da un pluralismo di voci e di punti di vista e anche da continui salti temporali. Tutto molto ben fatto, Franzen ha pochi rivali nella trama polifonica. Ma, di nuovo: dopo Underworld, su questo versante, non ci impressiona più nulla.
Purity è diviso in sette sezioni. La prima è centrata su Pip a Oakland, la seconda sulla giovinezza di Andreas Wolf nella Berlino comunista, la terza introduce Leila e Tom, e l’inchiesta che 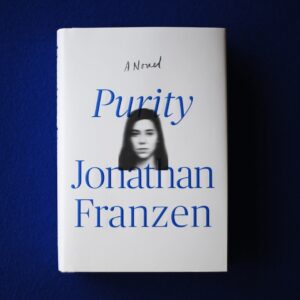 stanno conducendo su una presunta testata nucleare scomparsa da un magazzino della difesa e ricomparsa nel cortile di una casa privata di Amarillo, per attizzare un’intensa copulazione (a proposito: questo romanzo contiene alcune delle più fiacche scene erotiche che si siano lette nella letteratura recente, lo segnalo a quelli del Bad Sex, il premio assegnato annualmente alle peggiori scene di sesso della letteratura). E via così fino al finale, dove i fili si ricongiungono. Sei sezioni sono in terza persona, quella riservata a Tom, lo ripetiamo, è scritta in prima, ed è la più avvincente.
stanno conducendo su una presunta testata nucleare scomparsa da un magazzino della difesa e ricomparsa nel cortile di una casa privata di Amarillo, per attizzare un’intensa copulazione (a proposito: questo romanzo contiene alcune delle più fiacche scene erotiche che si siano lette nella letteratura recente, lo segnalo a quelli del Bad Sex, il premio assegnato annualmente alle peggiori scene di sesso della letteratura). E via così fino al finale, dove i fili si ricongiungono. Sei sezioni sono in terza persona, quella riservata a Tom, lo ripetiamo, è scritta in prima, ed è la più avvincente.
La tensione resta quasi sempre alta. I dialoghi sono, anche qui come negli altri romanzi di Franzen, fondamentali. Lo stile è medio, in generale non ci sono grandi picchi d’emozione o di lirismo, né azzardi sperimentali. Per alcuni critici questo è un di più e non un di meno, perché la forza del romanzo sta nella sua struttura complessiva, nella sua coerenza, nella solidità dell’edificio, non in qualche singolo ornamento. Il che può essere e lo accettiamo.
Ma scrivere, come ha fatto qualcuno, che ogni pagina è una lezione di stile, è una forzatura. A volte si ritrova addirittura la stessa parola ripetuta due volte nella stessa frase, e non credo sia colpa della traduzione di Silvia Pareschi, credo semplicemente che se si scrive un romanzo di 642 pagine qualche sbavatura sia inevitabile. E, certo, la si può perdonare, specie a fronte dell’urgenza dei temi trattati.
Ecco, siamo arrivati al punto definitivo. Non la trama, non i personaggi, non struttura e stile. Il tema. Di che cosa parla, alla fine, Purity? Prendiamola alla larga. Purity, come ogni grande romanzo dall’800 ad oggi, parla di temi politico-sociali e al tempo stesso di amore, di relazioni umane, di rovelli interiori. Mette assieme il grande e il piccolo, l’alto e il basso, ciò che è profondo e ciò che sta in superficie. Qui abbiamo l’America alternativa, l’America della protesta sociale, dipinta perlopiù come un’America velleitaria, monopolizzata da ambiziosi figli di papà, da ragazze di buona famiglia inevitabilmente bellissime e politicamente corrette (quelle di cui si circonda Wolf in Bolivia); ma abbiamo anche l’America in buona fede, dei giornalisti di redazione, poco pagati e poco cool, che fanno lo sporco lavoro dei giornalisti d’inchiesta nell’era che sembra avere decretato la fine del giornalismo. Abbiamo poi la decomposizione di un regime comunista, che riporta a galla segreti sepolti negli archivi della Stasi, e non sempre questo è desiderabile, non sempre un evento apparentemente ascrivibile nella colonna del “Bene”, è benefico fino in fondo.
Sull’altro piatto della bilancia abbiamo, come già detto, famiglie disfunzionali, madri che nevrotizzano figli e figlie, e figli e figlie che poi in un modo o nell’atro si vendicano altrettanto nevroticamente, abbiamo matrimoni che franano, abbiamo il conflitto fra i sessi.
Infine, come elemento trasversale, abbiamo internet, le tecnologie dell’informazione. Incistate nel romanzo di un autore che le ha sempre aspramente criticate e che a tutt’oggi non ha – che mi risulti – un suo profilo FB. Internet come la Stasi, il Network come il socialismo scientifico. Entrambe ideologie totalitarie, la seconda fondata sul terrore della repressione, la prima sul terrore dell’inconsistenza, dell’essere nessuno.
Ma dire così non è abbastanza, me ne rendo conto. Qual è, allora, il tema di Purity? Cos’è che, più di ogni altra cosa, ha spinto l’autore a scrivere queste 600 e passa pagine? È la purezza? È il senso di colpa? È il velleitarismo di certe crociate? È l’incapacità degli eroi pubblici di comportarsi correttamente nella loro vita privata? È – infine – l’invadenza della Rete? È l’incapacità di internet di soddisfare le aspettative che ha generato, riducendo il suo ruolo alla produzione di motori di ricerca sempre più sofisticati?
 Questo romanzo ha senz’altro a che fare con il tema dei segreti e della loro rivelazione. La madre di Pip custodisce gelosamente il segreto che la ragazza vuole svelare; Pip rimprovera alla madre la sua mancanza di sincerità ma mente a Tom e Leila, lo fa a tal punto da lanciare un software spia di Andreas Wolf nel sistema informatico della testata che Tom dirige, e di cui Leila è la prima inviata; Wolf svela a Tom, appena conosciuto in un pub di Berlino Ovest, il suo segreto più importante, salvo poi a pentirsene e cercare di controllarlo attraverso Pip; lo stesso Wolf, così ossessionato dalla sua immagine, e dagli attacchi che ne potrebbero derivare dalla Rete, è però il paladino del diritto alla conoscenza, che mette on line i documenti segreti che i suoi hackers riescono a piratare. E via di questo passo.
Questo romanzo ha senz’altro a che fare con il tema dei segreti e della loro rivelazione. La madre di Pip custodisce gelosamente il segreto che la ragazza vuole svelare; Pip rimprovera alla madre la sua mancanza di sincerità ma mente a Tom e Leila, lo fa a tal punto da lanciare un software spia di Andreas Wolf nel sistema informatico della testata che Tom dirige, e di cui Leila è la prima inviata; Wolf svela a Tom, appena conosciuto in un pub di Berlino Ovest, il suo segreto più importante, salvo poi a pentirsene e cercare di controllarlo attraverso Pip; lo stesso Wolf, così ossessionato dalla sua immagine, e dagli attacchi che ne potrebbero derivare dalla Rete, è però il paladino del diritto alla conoscenza, che mette on line i documenti segreti che i suoi hackers riescono a piratare. E via di questo passo.
Se il fulcro del romanzo è Andreas Wolf, il tema dei temi di questo romanzo è la difficoltà di conciliare il desiderio di verità, che porta a indagare – e poi a smascherare – i complotti, con il bisogno, altrettanto umano, a volte vitale (specie per le persone di successo) di preservare la propria privacy (nonché la propria immagine pubblica). Oppure anche: l’ossessione compulsiva per il mettere on-line, per il rivelare, con l’imperativo di comprendere (per comprendere un evento, politico o di altro genere, ci vuole ancora l’intermediazione del giornalista, sembra dirci Franzen fra le righe, non basta l’hacker che getta le notizie in pasto al pubblico).
Il tema del segreto è naturalmente attualissimo. Forse, con le tante trame che si intrecciano nel romanzo, l’autore poteva raggiungere lo stesso risultato – o un risultato addirittura migliore – facendo economia dei suoi mezzi. Ma tant’è; se si vuol competere con Dickens, cosa di cui Franzen in realtà non avrebbe bisogno, difficile stare sotto un certo numero di pagine.
Il segreto: cosa ci fa venire in mente? Certo, è lo stesso tema di cui scrive sempre Javier Marías, anche nel suo ultimo Così ha inizio il male. Invito i lettori a leggersi lo spagnolo – completamente diverso da Franzen, molto più lento, cerebrale, ossessivo – e poi a fare un ideale confronto.
Ma c’è un’altra possibilità. Ovvero che il fulcro del romanzo sia Pip, dal momento che a lei il libro è intitolato. In questo caso, allora, il tema dei temi di Purity è il passaggio di testimone fra le generazioni – un testimone che è fatto di nevrosi e frustrazioni – e la capacità (o forse la necessità) di saper andare oltre, di superare, per dirla con un personaggio del Pulp Fiction di Tarantino, queste cagate. Il finale, come ho già detto, è debole. Ma è pur sempre un atto di fiducia nei confronti delle nuove generazioni.
Jonathan Franzen, Purity, Einaudi, 2016, trad. Silvia Pareschi.
Negli USA il romanzo è uscito a settembre 2015 per Farrar, Straus & Giroux.












