Inverno del 1959-60 a Gerusalemme: pioggia sulle vecchie pietre e ogni tanto la pallottola vagante di un cecchino giordano. Shemuel Asch, studente socialista facile alla commozione, ha appena abbandonato gli studi, compresa la sua tesi sulla figura di Gesù nella cultura ebraica. È stato anche lasciato dalla sua ragazza, che si è sposata con un precedente fidanzato, esperto in gestione delle acque. Inoltre le finanze familiari vanno a rotoli e i genitori, che vivono ad Haifa, non possono più permettersi di pagargli gli studi.
È in queste circostanze che, per un colpo di fortuna – un avviso affisso ad una bacheca della mensa universitaria – Shemuel trova lavoro in una vecchia, grande casa abitata da un anziano professore, Gershom Wald, che vive con la nuora, rimasta vedova del figlio di Wald, ucciso crudelmente nella campagna militare del 1948 (per la quale era partito volontario anche se avrebbe potuto essere esonerato). La donna, Atalia, scontrosa seduttrice molto disillusa nei confronti degli uomini, è anche figlia di Shaltiel Abravanel, l'unico sionista che si oppose al disegno di Ben Gurion di dar vita ad uno stato ebraico, proponendo in alternativa una patria comune per arabi ed ebrei (una figura di fantasia presentata come un personaggio storico).
Questi in sintesi i luoghi e questi i protagonisti di Giuda, nuovo romanzo di Amos Oz, uscito nell'ultimo scorcio del 2014. L'incipit è quasi classico, rimanda a certi romanzi tedeschi del passato (Hoffmann? Heine? Kafka? Hesse?), dove abbondano queste figure di studenti stralunati che la sorte trascina qui e là, lungo percorsi avventurosi e chiaroscurali, immersi in un'atmosfera quasi onirica.
La Gerusalemme di Oz è così, piena di vicoli e di animali notturni, circondata per tre quarti da forze ostili, sospesa e chiusa in se stessa, perfetto fondale per gli interrogativi che l'autore vuol proporre al lettore: cos'è il tradimento e qual è il ruolo dei traditori, di figure come Giuda o Abravanel? E poi: è sensato impegnarsi nel cambiare l'umanità, dicendo di amarla nella sua interezza, oppure l'amore vero non può che essere riservato ad una manciata di persone ben precise, e chi si propone di redimere il genere umano tutto intero è destinato a produrre disastri e persino massacri, come hanno fatto tanti rivoluzionari, come hanno fatto le chiese di ogni confessione, compresa quella cristiana?
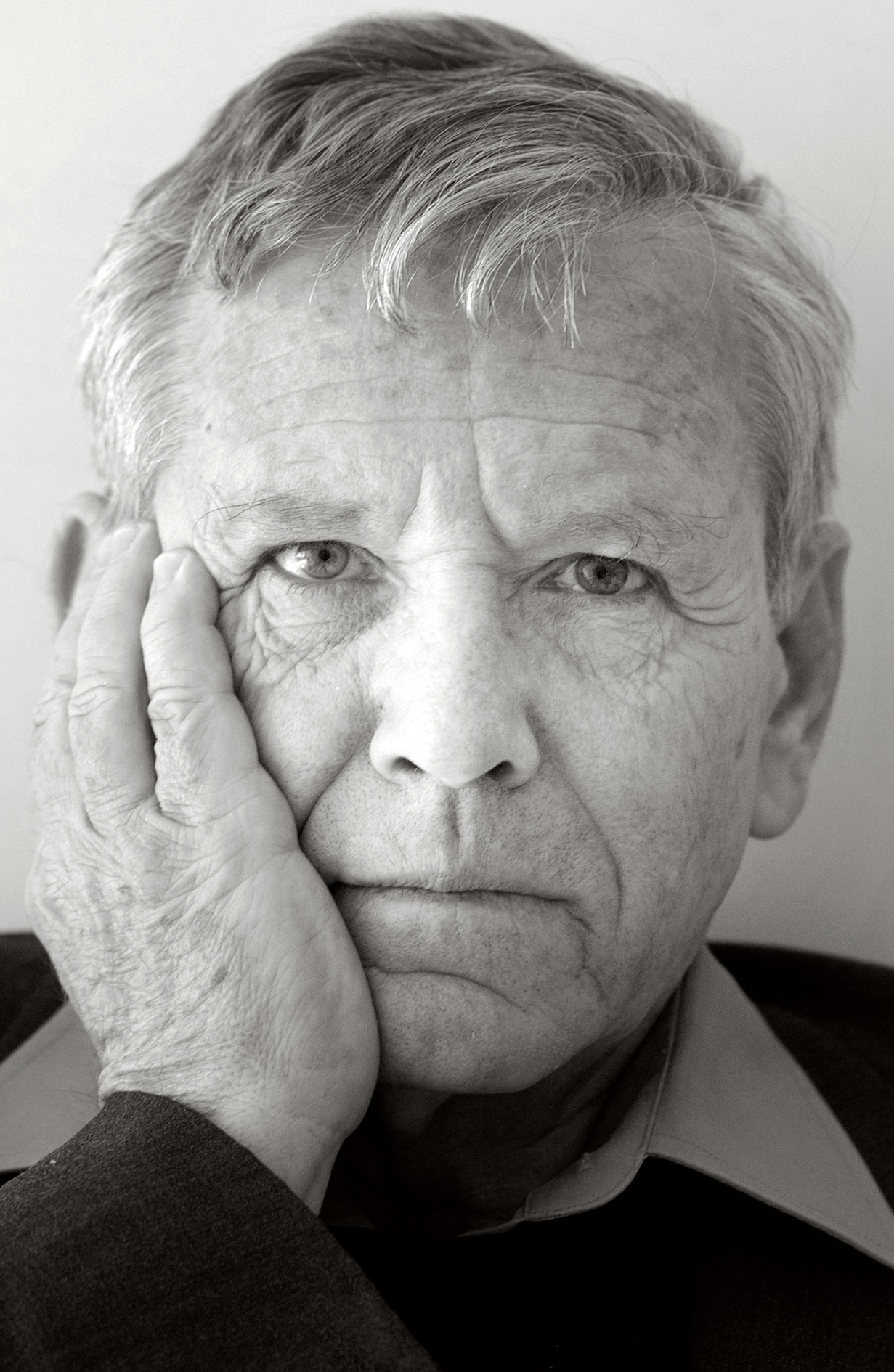
L’autore di “Giuda”, Amos Oz.
Uno dei pregi del romanzo sta nella capacità dell'autore di presentare punti di vista diversi, tutti ugualmente plausibili. La forza dei monologhi e dei dialoghi che ne costituiscono l'ossatura è proprio questa; inoltre Oz non è preso dall'ansia di dire qualcosa di originale o di stupire con la ricercatezza del linguaggio. Tutto è detto bene e senza inutile prosopopea. Tutto è ben spiegato e non stanca. Non solo: il romanzo è anche la storia di una lenta e in parte inevitabile seduzione. La storia di un amore fra due persone distanti per età ed esperienze, che sanno di non avere un futuro in comune.
Vediamo almeno il nocciolo teologico, partendo dalla tesi di laurea su cui Shemuel, pur avendo lasciato l'università ed essendosi rintanato nella mansarda di casa Wald, continua a rimuginare. L'oggetto doveva essere in origine la figura di Cristo, ma è diventato in realtà Giuda, il più fedele dei discepoli, l'unico a non essere di umili origini, tanto che risulta davvero risibile l'idea che abbia potuto tradire il suo Maestro per trenta denari. E allora, qual è il suo disegno?
Giuda, secondo Shemuel, crede davvero che il Regno dei Cieli sia arrivato. Ha visto Gesù compiere i suoi miracoli in Galilea, camminare sulle acque, resuscitare i morti, mutare l'acqua in vino. Lo ha sentito predicare. Ora, vuole che vada dritto nel "cuore del sistema", a Gerusalemme: dove si farà crucifiggere e poi scenderà dalla croce, mostrando a tutti, con quest'ultimo miracolo, qual è il volere divino.
Ma Gesù è preda del dubbio; si chiede se sia davvero lui il figlio di Dio, si chiede quale sia il vero progetto del Padre. Si chiede persino se le cose per le quali è diventato famoso nelle campagne della Galilea funzioneranno nella "laica", smaliziata Gerusalemme. Insomma, Gesù tentenna. E Giuda non può accettare queste indecisioni. Il suo tradimento è concepito a fin di bene, affinché le profezie si compiano. Negli ultimi momenti della Passione, è ai piedi della croce; attende che Gesù si strappi di lì, si tolga i chiodi e scenda fra la gente. Ma le ore passano. Gesù muore. La gente lentamente se ne va. Giuda capisce che nessun Regno dei Cieli sta arrivando, che il mondo continuerà così com'è, per secoli e secoli e secoli. Giuda perde la fede. Scende dal Golgota, cerca il suo albero. Sceglie il ramo più robusto a cui impiccarsi.
E Abravanel, il padre della fascinosa Atalia? Anche lui è un traditore, agli occhi degli altri ebrei, per avere respinto il grandioso, temerario progetto di dar vita ad uno stato ebraico, nella consapevolezza che esso produrrà una inimicizia terribile fra arabi ed ebrei. Qual è il disegno di Abravanel? Quello di un'unica patria (patria, non stato) per due popoli, capaci di risolvere le loro dispute con il dialogo, capaci di dialogare ed infine di collaborare, di mescolarsi. Idealismo puro, certo; ma forse anche un nobile obiettivo, proiettato nel futuro, in un mondo finalmente liberato dai nazionalismi novecenteschi. Un obiettivo che riacquista credibilità oggi, di fronte alla evidente impossibilità di pacificare quella regione del mondo sulla base della formula, che tutti ripetono meccanicamente, "due popoli-due stati".
 Da un lato, insomma, ci dice Oz, il tradimento può essere un efficace strumento di cambiamento (anche se i due personaggi che nel libro lo rappresentano sono a tutti gli effetti due sconfitti). Il traditore può essere la persona capace di vedere le alternative, di calarsi nei panni dell'altro, di tracciare nuove vie, fuori dal terreno del conformismo. Il traditore può essere persino il mediatore per antonomasia, e qui il pensiero corre ad uno dei pochi politici-filosofi che l'Italia contemporanea abbia conosciuto (anche lui in parte di origini ebraiche), Alexander Langer, fondatore dei Verdi e leader di Lotta Continua, il quale, in un suo famoso scritto, spiegava che per creare dialogo e ponti fra i popoli è necessario che ci siano dei traditori, che però non devono passare semplicemente dall'altra parte, devono essere capaci di tradire conservando – ed è questa forse la cosa più difficile – un'appartenenza.
Da un lato, insomma, ci dice Oz, il tradimento può essere un efficace strumento di cambiamento (anche se i due personaggi che nel libro lo rappresentano sono a tutti gli effetti due sconfitti). Il traditore può essere la persona capace di vedere le alternative, di calarsi nei panni dell'altro, di tracciare nuove vie, fuori dal terreno del conformismo. Il traditore può essere persino il mediatore per antonomasia, e qui il pensiero corre ad uno dei pochi politici-filosofi che l'Italia contemporanea abbia conosciuto (anche lui in parte di origini ebraiche), Alexander Langer, fondatore dei Verdi e leader di Lotta Continua, il quale, in un suo famoso scritto, spiegava che per creare dialogo e ponti fra i popoli è necessario che ci siano dei traditori, che però non devono passare semplicemente dall'altra parte, devono essere capaci di tradire conservando – ed è questa forse la cosa più difficile – un'appartenenza.
D'altro canto, ricorda Wald in una delle sue conversazioni pomeridiane con Shemuel, chi vuole cambiare la storia, chi vuole redimere l'umanità è senza dubbio un illuso, se non, a volte, addirittura un criminale, con i garretti che affondano nel sangue. E tuttavia tocca sempre a Wald, che nel '48 non aveva condiviso la visione di Abravanel, ritenendo che gli ebrei fossero con le spalle al muro e dovessero combattere per sopravvivere, tocca a Wald, il disilluso non domato, pronunciare una delle più belle e più semplici sentenze contenute in questo superbo romanzo: "Ti dico anche che malgrado tutto quello che ti ho detto prima, beati i sognatori e sventurati coloro che hanno gli occhi aperti. I primi non ci salveranno di certo, né noi né i loro discepoli, ma senza sogni e senza sognatori la maledizione peserebbe mille volte di più".
Amos Oz, Giuda, Feltrinelli, 2014. Traduzione di Elena Loewenthal.












