Nel pieno del dibattito sull’accordo bilaterale che prevede la costruzione in Albania di due strutture per le “procedure di frontiera o di rimpatrio” di migranti destinati all’Italia (la Corte Costituzionale di Tirana con cinque voti a favore e quattro contrari ha appena affermato che l’accordo “non lesiona l’integrità territoriale della nazione” e può andare in parlamento per approvazione), arriva L’Albania – Dall’impero ottomano all’Unione Europea (Libreria ASEQ Editrice), il libro di Roberto Rendina sul vicino paese “delle Aquile”, membro della Nato dal 2009 e candidato ad entrare nell’Unione Europea.
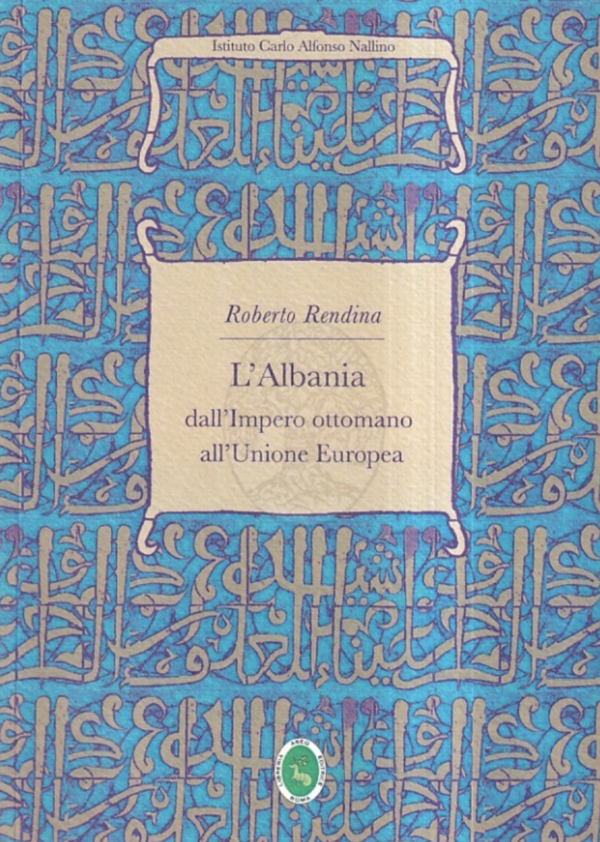 L’autore – che ha esperienza diretta del paese e della cultura islamica, ed è socio d’onore dell’Istituto per l’Oriente Nallino – premette all’analisi delle tendenze politico-economiche attuali e della collocazione internazionale del paese, un approfondito esame della geografia, della demografia e della storia albanesi, alle quali fa risalire molte delle questioni che a Tirana agitano il dibattito interno, mentre sollevano all’estero interrogativi.
L’autore – che ha esperienza diretta del paese e della cultura islamica, ed è socio d’onore dell’Istituto per l’Oriente Nallino – premette all’analisi delle tendenze politico-economiche attuali e della collocazione internazionale del paese, un approfondito esame della geografia, della demografia e della storia albanesi, alle quali fa risalire molte delle questioni che a Tirana agitano il dibattito interno, mentre sollevano all’estero interrogativi.
A questo proposito viene anche approfondita la questione delle fedi professate, in particolare del legame profondo con l’islam. La convivenza interreligiosa viene vista come cartina di tornasole di un profondo attaccamento alla tradizione e all’identità nazionale, un concetto che include – evidentemente non in termini sovrani ma esclusivamente culturali – i vicini Kosovo e Macedonia del Nord. A questo proposito Rendina testimonia “un livello di coesione tra le popolazioni albanofone, un sentimento d’identità collettiva diffuso tra popolazioni che fanno parte di diversi soggetti collettivi organizzati in forma statale […]”.
Particolare attenzione il libro dedica al rapporto che l’Albania (27.400 kmq e 2.850.000 abitanti) mantiene con l’Italia e l’Unione Europea. Con quest’ultima sono aperti i negoziati di adesione, la cui conclusione non è prevista in tempi brevi, visti i lunghi e complessi adeguamenti con l’acquis communautaire ai quali il paese balcanico, come ogni candidato, si trova vincolato. Dopo il regime di segregazione al quale gli albanesi erano stati costretti, dal 1945 al 1990, dal comunismo filocinese di Enver Hoxha, l’obiettivo, benché lontano, dell’integrazione nella famiglia democratica dell’Europa centro-occidentale, assume valore di storica speranza. Si pensi solo a un dato: nei quattro decenni e mezzo di comunismo più di cinquemila albanesi furono condannati a morte per fucilazione, impiccagione o altro: tra questi 450 donne.
In quanto all’Italia, gli ottimi rapporti bilaterali, che nel passato trovarono rappresentazione nella scenografia dell’impero fascista e oggi nella vasta comunità di autoctoni e immigrati albanesi, sono testimoniati dagli interessanti dati del commercio bilaterale e, sul piano politico, da eventi come quello citato in apertura.
I rapporti con Ue e Italia dotano il piccolo paese balcanico di opportunità tutte da esplorare, fondate sul recupero dello spazio storico che le due guerre mondiali della prima metà del novecento, e quindi il comunismo, avevano affossato. Come scrive Rendina, l’Albania “da sempre è stato l’ideale confine tra oriente e occidente in tutte le declinazioni che nel tempo si sono succedute (Bisanzio e Roma, islam e cristianesimo, comunismo e atlantismo) con la peculiarità di conservare e far convivere nel suo popolo molteplici e differenti tradizioni.”
Punto centrale dell’evoluzione albanese resta la questione economica e sociale. Con un prodotto interno lordo pro capite che non arriva a 5.500 dollari l’anno, una disoccupazione strutturale che fatica a scendere sotto il 12% (quasi 40% per le donne), un’agricoltura che contribuisce alla formazione della ricchezza annua quasi quanto l’industria, non sorprende l’alto numero degli espatriati e la crisi demografica che ne deriva. La diaspora albanese viene considerata, in percentuale sulla popolazione, la terza al mondo: solo in Italia soggiornano con regolare permesso 400.000 albanesi, e già nel 2017, secondo l’istituto Pew, all’estero vivevano 1.150.000 albanesi. L’elevata conflittualità politica interna e la corruzione ai livelli alti dello stato (per Transparency International l’Albania è 98° su 180 paesi per minore corruzione percepita) non forniscono molte aspettative di miglioramento, il che spiega perché l’emigrazione, nonostante gli incentivi fiscali al rientro, rimanga così alta.
Giustamente Rendina dedica molta parte della ricerca al progresso dei negoziati di adesione, vera speranza di un futuro migliore per il paese delle aquile. Sotto questo profilo, mentre non mancano “difficoltà nel negoziato e la possibilità di stallo, fallimento e mancata adesione”, si ha consapevolezza – come ha scritto la stessa Commissione Europea – che “una prospettiva di adesione credibile rappresenta il principale incentivo e motore di trasformazione nella regione e rafforza la sicurezza e la prosperità collettive”.












