Rossana e Fabrizio vivono fuori dall’Italia ormai da più di 13 anni, se si esclude un breve rientro alla base di circa 24 mesi. Lui, dirigente di una multinazionale, ha felicemente accolto l’opportunità del trasferimento per offrire un panorama diverso alla famiglia e lei, impiegata nella stessa azienda, ha temporaneamente lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla gestione della famiglia e all’ educazione dei figli. Dopo qualche anno in Svizzera, dal 2013 sono definitivamente a New York e i loro due ragazzi, che oggi hanno 16 e 5 anni, sono cresciuti in ambienti diversi, frequentando da sempre scuole internazionali.
La loro esperienza è comune a quella delle molte famiglie che si trovano ad affrontare una condizione di emigrazione privilegiata, legata a scelte professionali e di vita. Ma se due adulti che eleggono a propria dimora un Paese altro portano con sé le proprie radici, facendo della diversità un valore aggiunto e assimilando dalla nuova cultura quanto di meglio per loro, che cosa succede alla nuova generazione, che si trova sospesa fra una cultura familiare acquisita per interposta persona e una formazione internazionale?
Al di là del carattere e della capacità di adattamento individuale, il legame che i giovanissimi hanno con la propria cultura di origine è ovviamente filtrato dal nuovo contesto in cui crescono e nel quale, in un certo senso, rischiano di rimanere “stranieri”. Una condizione che ha ovviamente pro e contro, ma che sembra determinare almeno un privilegio su tutti: la libertà di vivere senza condizionamenti. A patto che la crescita sia stata guidata da genitori fortemente consapevoli del proprio ruolo.
Da Fabrizio e Rossana ci siamo dunque fatti raccontare come hanno affrontato e gestito l’educazione dei figli nel melting pot culturale newyorkese. A partire dal presupposto che ”l’etimo di educare è e-ducere, cioè ‘tirar fuori’. Ogni cultura inevitabilmente aggiunge, ti mette addosso un uniforme e da delle regole; l’educazione invece, intesa in senso assoluto, non dovrebbe ‘aggiungere’ o peggio inculcare ma al contrario far ‘fiorire’ i bambini, aiutarli a far venir fuori quanto di meglio c’è in loro”.
Esiste una modalità “assoluta” di educare, che non sia strettamente legata alla cultura di un paese in particolare?
R: “Io direi di si, la cosa bella sta nel prendere le cose più interessanti, le migliori, da ciascuna cultura. Noi siamo italiani, ci siamo portati l’Italia in America, ma cerchiamo anche di fare nostro in una certa misura il modo americano di concepire l’educazione e la crescita dei figli”.
F: “Iniziamo col dire che i bimbi nascono senza educazione, per loro una cultura vale l’altra e quindi la primissima formazione può essere assolutamente libera. E’ crescendo che gli aspetti culturali diventano importanti, e un’idea è quella di integrare nel metodo formativo gli aspetti più interessanti di varie culture. Il fatto che in America venga apprezzato tantissimo il metodo Montessori, nato in Italia, ne è una prova”.
Rispetto all’educazione dei figli quali problemi vi siete dovuti porre lasciando l’Italia?
R: “Con la lingua siamo stati fortunati, conoscendo noi l’inglese e avendolo loro assimilato a scuola fin da piccoli. Federico (il maggiore, ndr) l’ha appreso insieme all’ italiano, Filippo addirittura lo preferisce . Per il resto non ho mai trovato – tranne quando siamo stati in New Jersey – difficoltà nel dovermi ambientare e confrontare con una cultura profondamente diversa dalla nostra. Le radici si hanno nella cultura familiare, che è fatta di un fondersi di valori diversi, nel nostro caso quelli italiani, a cui si sono aggiunti quelli che più condividiamo con gli americani e quelli che abbiamo acquisito attraverso alcune amicizie internazionali. E’ un lavoro intenso, perché il ruolo del genitore richiede un’energia infinita. Poterlo fare a NY è bellissimo, perché non ci sono limiti predefiniti all’ espressione della propria personalità e non vieni giudicato. Sei libero di vivere serenamente quello che sei e fai. Mentre in Italia, quando torniamo ogni anno, il primo impatto è proprio con la sensazione opprimente dello sguardo degli altri, anche nelle piccole cose. Tutti i limiti che ci sforziamo di eliminare per vivere in maniera più armonica con il mondo, in Italia ci sembrano pesanti, anche in una grande città come Roma”.
F: “I primi anni abbiamo seguito dei corsi cross-culturali e una delle cose che ci hanno insegnato è che i bambini di coppie che girano molti paesi appartengono ad una “terza cultura”, cioè una cultura propria, trasversale a quelle con cui si trovano a contatto. Lo vediamo nei nostri figli: Federico si definisce italiano, Filippo no. Ha una felice confusione relativamente alla sua appartenenza a una qualunque geografia. Lui a volte dice di essere a volte svizzero (è nato a Zurigo, ma ci ha vissuto solo il primo anno di vita, ndr) e a volte americano, ma se andassimo in Mongolia probabilmente si definirebbe mongolo. Ovviamente questo non significa che non abbia valori o abitudini o gusti, ma che ha una sua cultura “terza”, non condivisa con altri. Le culture sono fortemente strutturate perché vengono da secoli di storia, ma come per le ricette, i cuochi possono poi creare dell’altro, del ‘nuovo’ con quegli stessi ingredienti: Filippo non si identificherà con una cultura convenzionale, ma creerà la propria, fatta di principi, valori, abitudini personali”.
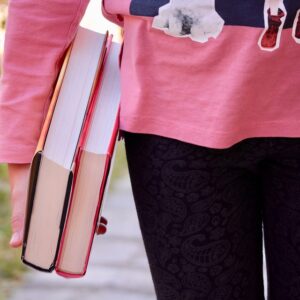
Rispetto al tipo di scuola, man mano che l’età cresce, che tipo di opzioni esistono in America?
R: “Una prima riflessione va fatta sulle finanze della famiglia, perché quando ti muovi da straniero tendi a dare più affidamento alle scuole private, pensando che ci sia più attenzione rispetto alla formazione, alla crescita, alle attività e a volte effettivamente è così. Di solito nelle scuole private e’ anche più facile che ci sia un contesto internazionale che favorisce inizialmente l’integrazione. Quindi se si hanno le possibilità, in genere ci si indirizza verso quel settore, che è estremamente oneroso. Una volta che ci si ambienta si comincia a capire come possano funzionare le cose in maniera alternativa, attraverso l’istruzione pubblica, che nelle zone più benestanti è ottima (insegnanti preparatissimi, che seguono regolarmente corsi di aggiornamento, comunità di genitori e volontari molto attive…) e quindi, come nel nostro caso, puoi finire ad avere due figli nella scuola pubblica. Con la possibilità, se sei bravo e motivato, di entrare attraverso il test di ammissione nelle scuole specializzate, dove l’istruzione pubblica è ad altissimi livelli. Purtroppo queste scuole, tranne le High School che sono su tutta NY, si trovano soprattutto nelle zone più abbienti, dove il reddito medio è più alto. Questo per l’istituto implica maggiori donazioni e quindi più mezzi a disposizione. Quella pubblica, più ancora che quella privata, è una scuola molto competitiva fin dall’ inizio: Filippo a 5 anni ha già fatto un test per poter accedere ad una scuola pubblica con una sezione Gifted and Talented”.
La forte competitività è un pro o un contro?
R: “Dipende dal carattere del singolo bambino, comunque si tratta di una competizione sana, motivazionale. Forse a 5-6 anni è troppo, ma già a 8-9 è stimolante. Noi ora stiamo studiando il panorama dei college (Federico l’anno prossimo dovrà fare domanda) e ci troviamo a considerare che ci piacerebbe essere in età scolastica: la possibilità di scelte che hanno questi ragazzi è infinita, è meravigliosa…”

F: “Ecco un contro: per la primissima infanzia trovo bello che si siano sviluppate tanto le Montessori (che però sono private), perché hanno un approccio fondamentalmente umanistico, quindi vicino ad un’idea europea, italiana. Sono molto responsabilizzanti e fondate sull’attenzione alla persona. Poi per elementari e medie il settore pubblico è guidato dai test, probabilmente per il fatto che in America tendono ad allineare tutto a degli standard. Questo si intensifica nelle high school, in prospettiva della selezione per entrare nei college. La competitivà e i test sono un aspetto a volte abbastanza asfissiante dell’istruzione e sono una cosa terribilmente meccanicistica: tutto è determinato da valutazioni tabellari, anche gli incentivi agli insegnanti. Lo trovo piuttosto disumanizzante e aziendale, mentre in questa fase le scuole private garantiscono ancora una crescita differenziata dell’individuo. Però va detto che le buone scuole pubbliche, chiamate ‘specialized’, pur puntando sui test standardizzati, hanno comunque finanziamenti, laboratori, opportunità, strumenti molto al di sopra della realtà italiana”.
R: “E hanno comunità di genitori che lavorano a tempo pieno nella scuola. Quest’anno ad esempio io mi occuperò della Book Fair (un impegno di un mese), poi si organizza una Auction night, che è il fundrising più importante per la scuola, a cui i genitori lavorano per tutto l’anno. Insomma, i genitori sono il sostegno dell’istituto, sono benvoluti e partecipano attivamente alla gestione. Non sono in contrasto con l’insegnante che è lì per giudicare gli alunni, come sento raccontare da amici italiani”.
Al di là del sistema valutazione, qual è l’approccio allo studio?
R: “In Svizzera Federico ha avuto la fortuna di seguire in International Baccalaureate, dove si affrontano le materie con un approccio tematico trasversale rispetto a temi di attualità e connessioni interdisciplinare. Qui a New York purtroppo esistono pochissime scuole simili, tutte private. Avendo noi scelto la scuola pubblica che richiede le verifiche via test, l’enfasi è sempre sul bagaglio di informazioni acquisite. La scuola dove Federico sta studiando è una Specialized High School, comparabile ad un liceo scientifico, con altissima presenza di asiatici (75%) e pochissimi bianchi. Le materie sono inglese, storia, scienze, matematica… E’ una scuola dura, perché ci si confronti con un livello di istruzione molto alto e studenti molto motivati. Pesante dal punto di vista della formazione, il cui metodo si basa su didattica e mole di informazioni. Filippo, al kindergarten, a fine anno ha già fatto il primo test che includeva spelling e scrittura. Qui sei abituato a fare i conti col tempo fin da piccolo, questo elimina l’ansia per gli esami ma fa perdere un po’ l’aspetto della crescita individuale. Bisogna avere la fortuna di incontrare insegnanti che riescono a valorizzare anche l’individuo, cosa che finora abbiamo spesso trovato. Siamo favoriti dal fatto di essere italiani, perché questo ci rende molto benvoluti e si ricordano di noi. Il fatto di rimanere impressi aiuta le relazioni personali e in quanto italiani ci vogliono bene, amano la nostra cultura e la nostra lingua”.

Che altre differenze riscontrate rispetto a quello che conoscete della scuola italiana?
F: “Conosco poco la scuola italiana di oggi, ma mi sembra di aver capito che ci sia una buona integrazione sociale, mentre quella culturale forse ancora non completamente. Qui è il contrario: ora sta iniziando un programma di integrazione sociale, cosa difficile da realizzare perché i ceti economici tendono a rimanere distinti. Se la scuola è privata c’è ovviamente una selezione economica alla base, mentre se è pubblica è legata al quartiere, che in genere è comunque abitato in modo omogeneo da persone dello stesso ceto. Forse in America, proprio per come è strutturato il sistema, c’è ancora una difficoltà rispetto alla reale integrazione fra ceti sociali. Hanno un enorme problema di inequality e non so se questa situazione nella scuola potrà creare una generazione che sia sensibile a questo problema e sappia offrire soluzioni efficaci in futuro. L’integrazione culturale a New York invece è una cosa normalissima”.
R: “L’integrazione sociale no. Ad esempio, nel nostro quartiere per l’affitto di un monolocale si spendono 2500-3000 dollari al mese, quindi il quartiere di residenza opera già una selezione economica. La scuola pubblica prende gli stessi finanziamenti di tutte le altre della città, ma qui avrà maggiori donazioni, ci saranno più genitori che possono permettersi di non lavorare e quindi di avere più tempo da dedicare all’istituto. Va anche detto che all’interno della scuola c’è molta solidarietà: si organizzano aiuti economici per le famiglie meno abbienti ed i bambini non percepiscono una diversità. Inoltre vengono organizzate le classi in cui i bambini con “Special needs” (5%) vengono affiancati da insegnanti di supporto e genitori volontari e ricevono finanziamenti ad hoc. E tutti i ragazzi devono passare almeno un anno della loro vita scolastica in una di queste classi”.
I vostri figli sono perfettamente integrati o hanno avuto difficoltà particolari?
R: “Problemi rispetto ai metodi di apprendimento no, perché Federico ha sempre seguito una scuola internazionale di matrice americana. Lui è molto fiero di essere italiano e di nascere dalla cultura italiana, ci tiene a mantenere le differenze e a volte le distanze, per un fatto caratteriale. Ci tiene al suo essere italiano. Sa però che la possibilità di studiare nella scuola in cui si trova ora è un privilegio, si rende conto che se riesce ad entrare in un buon college ha la possibilità di fare qualcosa che gli piace e poi magari di trovare una strada. Dell’Italia gli mancano sostanzialmente il cibo e le sfumature nelle relazioni umane. Cose che mancano anche a noi”.
F: “Io con l’età ho scoperto una cosa probabilmente ovvia a molti: i bambini hanno una capacità di adattamento molto maggiore di qualsiasi adulto, e le difficoltà dei nostri figli sono state semmai rispetto nello stabilire relazioni profonde. Federico per esempio parla degli americani come “diversi” rispetto ai rapporti interpersonali, li considera forse troppo semplici da un punto di vista culturale. Lui d’altra parte in un certo senso è introverso mentre gli americani sono di solito molto estroversi, diretti, fisici e questo probabilmente lo mette in imbarazzo e quindi sulla difensiva o a volte gli fa prendere le distanze”.

Il fatto di avere alle spalle la cultura italiana è sempre un valore aggiunto o è anche un limite?
F: “In Svizzera lo è stato, e abbiamo percepito un certo pregiudizio che ci vede come rumorosi, maleducati o po’ mafiosi… Io nell’essere italiano ci vedo invece molto valore aggiunto: adattabilità, flessibilità, capacità di apprezzare la vita e cercare le cose belle. Come limiti, che sento molto miei e al tempo stesso forse anche di tanti altri italiani, ne percepisco soprattutto due: un po’ di lassismo, cioè una mancanza di disciplina fisica e morale, e poi la tendenza a lamentarsi e a vivere le responsabilità e il sacrificio come un peso. Spesso con una venatura di vittimismo. A confronto, della cultura protestante, apprezzo molto la autodisciplina e la capacità di vivere le responsabilità con un sorriso. In queste cose Federico è assolutamente italiano come me… detto ciò, io sono molto contento dell’apertura mentale che gli ha dato il vivere in posti diversi. Non credo che un determinato sistema culturale o di educazione possa determinare la felicità di un bambino, e penso invece che sia un valore il fatto di crescere con una mente aperta e di aver conosciuto tanti modi diversi di pensare e di vivere”.
Se tornaste indietro, oggi scegliereste di uscire dall’Italia?
“Noi non abbiamo scelto di partire specificatamente nell’ottica di voler dare un futuro migliore ai nostri figli, ma semplicemente perché ci sembrava un’opportunità, e per fortuna loro sembrano essersi adattati molto bene. Si, torneremmo a New York. New York e’ una grande giostra di persone, ti dà il senso che tutto quello che fai entra in circolo e ti ritorna in termini di stimoli, affetto, felicità…. Oppure forse andremmo a San Francisco, o magari in un’altra grande città europea”.
Dove vorrebbero vivere in un futuro adulto?
“Federico in Inghilterra: lui ama profondamente gli inglesi, la sfumatura ironica della loro lingua, l’eleganza, le coloriture…. Filippo è diverso, usa già molto lo slang, sembra venir fuori newyorkese”.
E voi?
“Davanti al mare, meglio se il Mediterraneo”.











