Quando ti chiami Paul Auster e, insieme a Don De Lillo, Philip Roth e Thomas Pynchon, occupi uno scranno nell’Olimpo della letteratura americana del Ventunesimo secolo, lanciare il tuo ennesimo romanzo potrebbe sembrare una pratica di ordinaria amministrazione. In realtà nel caso di Auster, presentare al pubblico la sua ultima fatica letteraria, è sembrata una specie di liberazione, come posare a terra un grosso fardello dopo aver camminato a lungo. E se consideriamo che 4 3 2 1 è un malloppo di 880 pagine, scritte nel corso di sette anni — “an elephant of a book”, un pachiderma di romanzo, l’ha definito — dire “liberazione” sembra quanto mai appropriato. Questa è stata la sensazione, vedendo e sentendo parlare Paul Auster nella Kaufmann Concert Hall di 92nd Street Y, lunedì 30 gennaio 2017: una grossa prova portata a compimento, un velo di stanchezza nel tono della voce — Auster ha letto abbondantemente dal romanzo prima del talk.
Due parole sulla struttura che ha organizzato la presentazione. Studio, scuola, incubatore culturale con più di 140 anni di attività alle spalle, 92nd Street Y è un centro polivalente per le arti dello spettacolo, della musica — classica, jazz, pop — della danza, della letteratura che organizza seminari, reading, dibattiti, offrendo la possibilità a chi fa arte, di presentarla, studiarla, coltivarla, condividerla e, al pubblico, di fruirne. L’Unterberg Poetry Center, in particolare, che si occupa della sezione letteratura e poesia, ha reso possibili, negli anni, incontri con artisti del calibro di Pablo Neruda, Arthur Miller, W.H. Auden, Saul Bellow e Toni Morrison.

Tornando alla stanchezza, c’è da dire che Auster non è più un ragazzino. Ha raggiunto i settant’anni, e come lui stesso ha ammesso, incalzato da Bernard Schwartz, moderatore della serata nonché Direttore dell’Unterberg Poetry Center, ha dedicato gli ultimi tre anni della sua vita a questo romanzo, interrompendo qualsiasi altra attività, rifiutando interventi pubblici, lavorando dal lunedì al sabato, e persino alcune domeniche. “A fine giornata ero esausto”, ha dichiarato Auster, aggiungendo che non avrebbe potuto fare altrimenti: non avrebbe mai concluso il romanzo se non si fosse concentrato solo su quello, respingendo qualsiasi distrazione — e questo la dice lunga sulla disciplina e lo spirito di sacrificio dei grandi scrittori.
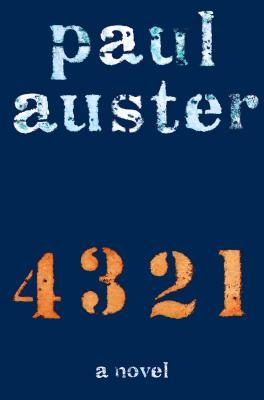 4 3 2 1 racconta la storia di Archie Ferguson, nato nel 1947 nel New Jersey — un mese dopo la nascita di Paul Auster stesso, guarda caso… Il protagonista si scinde in quattro diverse persone, ognuna delle quali con un proprio percorso e un proprio futuro. Tuttavia, questi quattro personaggi si troveranno a fronteggiare l’amore per la stessa ragazza. Il nonno di questo personaggio declinato in quattro sé, è Isaac Reznikoff, un ebreo di Minsk sbarcato, ai primi del ‘900, in America, dove avrebbe assunto il nuovo nome di Ichabod Ferguson — significativa storpiatura di un fraintendimento — e una nuova identità. L’identità è al centro di questo romanzo, un po’ come in tutti i romanzi di Auster, sin dalla Trilogia di New York. Ma in questa storia, ha confessato l’autore, ciò che gli interessava era esplorare il territorio del crescere, del passare dall’infanzia all’età adulta, cosa che gli ha consentito di riflettere sul proprio percorso personale. E tutto, ha dichiarato Auster, è iniziato proprio da lì, da quei quattro ragazzi protagonisti del libro. A questo proposito ha anche scherzato. “Mi fanno spesso la domanda ‘quanti Paul Auster esistono?’, alludendo, penso, ai personaggi metanarrativi cui ho dato vita nei miei romanzi. La risposta che davo era ‘Nove, come le vite dei gatti!’, ma adesso, dopo l’uscita di questo romanzo, il numero è quattro”.
4 3 2 1 racconta la storia di Archie Ferguson, nato nel 1947 nel New Jersey — un mese dopo la nascita di Paul Auster stesso, guarda caso… Il protagonista si scinde in quattro diverse persone, ognuna delle quali con un proprio percorso e un proprio futuro. Tuttavia, questi quattro personaggi si troveranno a fronteggiare l’amore per la stessa ragazza. Il nonno di questo personaggio declinato in quattro sé, è Isaac Reznikoff, un ebreo di Minsk sbarcato, ai primi del ‘900, in America, dove avrebbe assunto il nuovo nome di Ichabod Ferguson — significativa storpiatura di un fraintendimento — e una nuova identità. L’identità è al centro di questo romanzo, un po’ come in tutti i romanzi di Auster, sin dalla Trilogia di New York. Ma in questa storia, ha confessato l’autore, ciò che gli interessava era esplorare il territorio del crescere, del passare dall’infanzia all’età adulta, cosa che gli ha consentito di riflettere sul proprio percorso personale. E tutto, ha dichiarato Auster, è iniziato proprio da lì, da quei quattro ragazzi protagonisti del libro. A questo proposito ha anche scherzato. “Mi fanno spesso la domanda ‘quanti Paul Auster esistono?’, alludendo, penso, ai personaggi metanarrativi cui ho dato vita nei miei romanzi. La risposta che davo era ‘Nove, come le vite dei gatti!’, ma adesso, dopo l’uscita di questo romanzo, il numero è quattro”.
Che Auster sia uomo di spirito si è capito sin dall’inizio dell’evento. Dopo aver dato uno sguardo alla platea, appena salito sul palco, ha esordito con un “Wow, quante persone! Un milione e mezzo di sicuro… Ma forse forse anche di più”, facendo il verso alle cifre lievitate in bocca a un neo-presidente eletto… E da questa battuta si è capito molto di più che da lunghe prese di posizione politiche dichiarate. L’autore ha tuttavia negato di aver scritto il romanzo pensando a Trump, o facendovi riferimenti più o meno espliciti all’interno del testo. “Quando cominciai il romanzo, Trump non era nemmeno un’opzione… È stata la storia, piuttosto che la politica, a intromettersi. Il romanzo avrebbe dovuto intitolarsi Ferguson. Poi nel 2014 c’è stato il caso di razzismo a Ferguson, la città, e non potevo far finta di niente. Le guerre in Vietnam potranno anche essere concluse, ma i contrasti razziali sono ancora all’ordine del giorno in questo paese”, ha commentato Auster, riferendosi all’episodio avvenuto nell’agosto del 2014, nel sobborgo di St Louis, in Missouri, in cui Michael Brown, un diciottenne afroamericano colpevole solo di essere stato testimone di un furto in un tabaccaio, venne ucciso, e il suo corpo lasciato per strada per più di quattro ore.
Una domanda anonima dal pubblico durante il Q&A dopo il reading e il talk, ha chiesto a Auster cosa pensasse della letteratura nei momenti di tribolazione politica come quelli che stiamo vivendo. “La letteratura dovrebbe prodursi e consumarsi in momenti di tranquillità. Come per esempio nel Rinascimento Italiano, oppure l’arte fiamminga nel ‘700. Forse, nei momenti di difficoltà, è la poesia ad aiutare… Certo non un romanzo di 800 e passa pagine…!”, ha concluso, facendo ridere di nuovo la platea. Anche la domanda de La Voce di New York è stata selezionata fra le tante raccolte durante il reading. Davanti alla possibilità di sparire nel nulla e rifarsi una nuova vita da zero, come succedeva a Mattia Pascal nel romanzo di Pirandello, e come potrebbe verosimilmente accadere a qualcuno dei suoi personaggi, lui, Paul Auster, sparirebbe? “No”, ha risposto convinto. “Non sparirei mai. Ho una moglie che adoro, Siri Hustvedt, una famiglia che adoro. Non sparirei mai dalla mia vita”.
A breve sparirà, tuttavia, dalla sua Brooklyn… per il tour promozionale che lo porterà in Inghilterra, Germania e Olanda.











