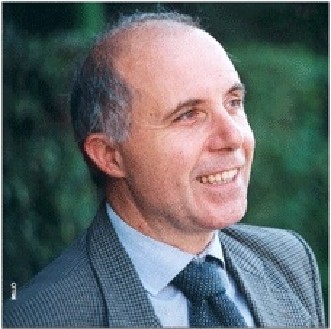La decisione di venerdì del Comitato norvegese del Nobel di assegnare all’Unione Europea il premio Nobel per la pace, premia sei decenni di testarda militanza delle istituzioni europee a favore della pacificazione tra i popoli, all’interno e all’esterno del vecchio continente. Si tratta di un atto politico di fortissima rilevanza, che contribuirà ad abbassare i toni del dibattito sullo stato dell’Unione, inaspriti negli ultimi tempi dalle difficoltà finanziarie di alcuni paesi membri. In troppi hanno dimenticato che il progetto di unire i popoli europei, superando il nazionalismo e gli egoismi degli stati nazionali responsabili delle due grandi guerre del secolo ventesimo, inizia a muovere passi concreti solo dopo che la carneficina della seconda guerra civile europea ha offerto la chance oggettiva per realizzare quello che da sempre hanno in mente uomini come Spinelli, Schuman, Monnet. La via delle comunità economiche, dalla prima del carbone e acciaio a quella del mercato comune, è strumentale fornendo i passi indispensabili per far convergere, intorno agli interessi, la volontà politica di costruire in Europa il nuovo modo di essere dell’entità stato. Questa novità merita di essere sottolineata. Mai prima nella storia umana è stata tentata l’aggregazione di popoli e stati fuori dall’opera bellicosa di uno stato o di un impero dominante, per volontà manifesta delle popolazioni. Non solo: l’esperimento avviene nel rigetto dello stato tradizionale, da sempre aggressivo e spoliatore, a suo agio nell’anarchia del sistema internazionale e nella difesa strenua del cosiddetto interesse nazionale, che è poi interesse dei soli ceti dominanti. Lo ricorderà con chiarezza il presidente francese François Mitterrand nel discorso pronunciato al Parlamento europeo di Strasburgo quando il 17 gennaio 1995, mentre sta morendo di cancro alla prostata, incita i deputati ad andare avanti:
“Bisogna vincere la nostra storia e pertanto se non la vinciamo, bisogna sapere che s’imporrà una regola, il nazionalismo, cioè la guerra! La guerra non è soltanto il passato, può essere ancora il nostro avvenire”.
La politica internazionale è tuttora basata sul realismo della forza. Il regionalismo economico europeo, con i suoi vagiti di regionalismo politico e di sicurezza, traccia la strada che il mondo contemporaneo dovrebbe seguire: smorzare gli egoismi nazionali, creare unioni regionali, armonizzare le loro esigenze in un concerto che tenda a dare risposte agli immensi problemi dei nostri tempi come l’arsenale batteriologico e nucleare, il riscaldamento globale, il sottosviluppo.
Le maggiori potenze della nostra epoca, perse nel culto dell’hard power, operano con strumenti vecchi di due secoli, e non hanno nessuna intenzione di imparare dalla lezione europea. Negli Stati Uniti, giusto dieci anni fa, è addirittura circolata la storiella, firmata dal politologo Robert Kagan in un articolo sulla rivista Policy Review, di un’Europa Venere opposta al Marte statunitense. Il Nobel all’Ue è il giusto riconoscimento che l’alto istituto norvegese tributa alla
resipiscenza di un continente che ha generato mostri quali il colonialismo, il nazifascismo e il comunismo, e che sulla consapevolezza delle proprie colpe ha scelto di rigettare la guerra, e dare ai suoi popoli il welfare prima del warfare. La costruzione della forza che stati come Usa, Cina e Russia continuano a mettere in cima alle priorità appartiene al mondo hobbesiano dove ogni stato è lupo all’altro. In Europa si sta tentando di edificare il mondo del diritto e delle istituzioni dove l’impellenza di sicurezza si allarghi anche al sociale, nel che Kant indicò con la Federazione della “pace perpetua”. E’ interesse di tutti che quel modello risulti vincente.