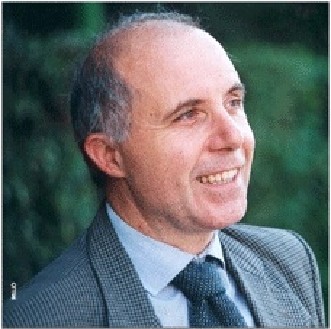Alla vigilia della riapertura di scuole e istituti superiori appaiono, come ogni anno, articoli dedicati alla migliore pedagogia da adottare per garantire che severità e flessibilità siano dosati nel modo più corretto. La questione riguarda gli educatori che operano nelle strutture pubbliche e private di insegnamento, ma anche le famiglie e, più in generale, l’insieme della società. Mariapia Veladiano, nella pagina culturale di “La Repubblica”, prende posizione sul meccanismo del voto, spogliandolo di ogni sacralità: “Il voto è solo lo strumento che ci siamo dati per comunicare fra professori, ragazzi, famiglie, mondo”. La saggista richiama il modello del Trentino che nei primi quattro anni delle elementari valuta “per aree di apprendimento” senza voti per le singole materie, fino alla terza media esprime solo giudizi articolati, alle superiori proibisce valutazioni inferiori ai 4/ 10. Chi educa non deve umiliare; può giudicare negativamente ma deve collaborare al recupero. Sulla “legittimità-indispensabilità” del voto e sulle tecniche alternative di giudizio a disposizione dei docenti, si sono spesi decenni di discussioni che non hanno portato a nessun risultato condiviso.
Per la cronaca, nel pieno della “contestazione” sessantottina si arrivò nelle università al cosiddetto “voto politico”, salvacondotto alla promozione per gli studenti dei ceti meno favoriti estendibile a tutti. Un meccanismo che nella Francia monarchica, in barba al nostro politically correct, era già stato sperimentato al contrario, in favore del delfino reale. L’espressione “Ad usum Delphini” di origine forse secentesca, ricorda come l’erede al trono fosse destinatario di testi classici “adattati” ad età e predisposizione allo studio: il pupone coronato non andava mai messo in difficoltà.
Al di là dei privilegi di delfini e sessantottini scarsamente dotati, va sfatata la convinzione che il voto basso premi qualità e merito. Serve piuttosto ad escludere chi lo riceve, a notificargli una sentenza di condanna, specie se il voto è espresso dentro sistemi standardizzati che sollecitano il conformismo più dell’attitudine alla libertà critica. Chi ritiene appropriato dare voti bassi dovrebbe ricordare che non si è educatori in quanto si ha il potere di emettere voti e giudizi ma perché si sa assistere l’allievo a tirar fuori il suo meglio.
Su questa linea “L’arte dell’incoraggiamento”, scritto anni fa da Herbert Franta e Anna Rita Colasanti, tuttora uno dei migliori manuali di psico-pedagogia in circolazione. Al centro della riflessione la personalità dei ragazzi e come l’istituzione scolastica debba impegnarsi a valorizzarla. Il libro definisce la formazione dei ragazzi un fatto “integrale”, che deve inserire nei fattori di rendimento anche le esperienze sociali. Parlando ai docenti, distingue il sapere, dal saper essere e dal saper fare, proponendo un magistero che sappia incoraggiare educando, e che accetti di essere sufficientemente umile da rendersi adattabile alla personalità del singolo allievo.
E’ ovvio che un modello del genere presupponga una scuola non fondata sull’anonimato docenziale, che metta al centro il rapporto personale dell’educatore con il suo allievo. La relazionalità interpersonale tra i due ruoli che costituiscono la centralità dell’esperienza scolastica (sullo sfondo famiglia e stakeholder), è il fondamento della tecnica dell’incoraggiamento, garanzia dell’interazione efficace e personalizzata tra chi sa e chi apprende. Che l’istituzione educativa di massa della contemporaneità, azienda tra le tante la cui prima preoccupazione è far quadrare il bilancio, sia in grado di raccogliere la sfida e praticare il modello, è altra questione.