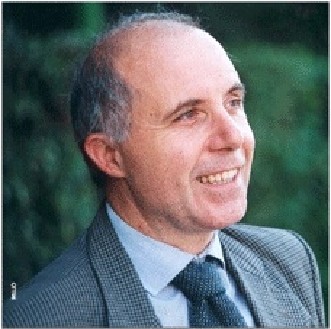Il 14 agosto 1892, a Genova, nasce il Partito socialista italiano, con il nome di Partito dei lavoratori italiani. Il programma approvato dal primo congresso, su proposta della Lega socialista milanese di Filippo Turati, punta a trasformare la società partendo dalla prospettiva riformista, contro gli estremismi di operaisti e anarchici.
Vincono moderazione e consenso dal basso, lotta attraverso il voto, rispetto della legalità, rifiuto della violenza. Le due importanti scissioni che il riformismo subirà nella prima metà del Novecento, dai “compagni” che diverranno i fascisti di Mussolini e i comunisti di Gramsci, saranno causate proprio dall’avversione allo stile di ragionevolezza e quotidiana costruzione del consenso affermatosi a Genova, e dal favore per l’infantile “tutto e subito” che porterà la sinistra italiana ad una lunga serie di tragedie, culminate, nei nostri decenni, nel brigatismo rosso e nell’incapacità di rendersi credibile classe di governo.
Il partito, che assume il nome di socialista al congresso di Parma del 1895, dà all’Italia oltre a Turati, uomini come Matteotti, Buozzi, Saragat, Nenni, Brodolini, Pertini. Realizza grandi riforme come lo statuto dei lavoratori, il sistema sanitario nazionale, il divorzio. Socialisti dirigono i sindacati (Bruno Buozzi fu fucilato dai tedeschi in fuga da Roma), creano e gestiscono la stagione del centrosinistra che traghetta l’Italia nella modernità laica e nello sviluppo sociale ed economico, con un posto fisso al tavolo delle maggiori potenze industriali.
L’ultimo leader è Bettino Craxi, meteora tragica della nostra vita politica. All’inizio mostra inattese virtù: accentua l’autonomia dai comunisti costringendo nell’angolo un uomo come Enrico Berlinguer, impone rispetto agli alleati democristiani, rilancia l’immagine culturale e storica della tradizione autonomista, firma il nuovo concordato, accentua i legami con i gangli della democrazia degli interessi: sindacati, cooperative, confederazioni imprenditoriali.
Convince molta opinione pubblica di centro e spaventa interessi consolidati che si prostrano al nuovo uomo forte, autoritario più che autorevole. È il politico dell’“onda lunga” elettorale che fa sognare i seguaci e fa ipotizzare agli osservatori che si vadano creando le condizioni per la modernizzazione lib lab di un paese impantanato nel confronto tra “chiesa” marxista-leninista e “chiesa” demo-cattolica.
Craxi cade sulla questione morale. Il partito che nella storia unitaria ha rappresentato la faccia onesta e pulita della politica, si trasforma in apparato di poltrone e denaro facile. A torto o a ragione diventa il protagonista principe di “tangentopoli”, il sistema di corruzione e costi crescenti all’origine del debito pubblico che strangola il futuro italiano. Craxi, che da primo ministro ha tenuto testa agli americani a Sigonella, manca la sua ultima occasione di fronte alla storia quando si sottrae alla giustizia di “mani pulite”, per rifugiarsi e morire presso il dittatorello tunisino Ben Ali. Il partito e le sue espressioni, a cominciare dal glorioso quotidiano Avanti!, sopravvissuti ai decenni degli assalti e roghi delle squadracce fasciste, chiudono ingloriosamente i battenti.
Ho in mano l’“Almanacco socialista” del 1982, celebrativo dei novant’anni, con Craxi allo zenit: cinquecento pagine di testi e foto trasmettono l’iconografia di un partito forte e consapevole.
Trent’anni dopo, gli ex arrampicatori dell’“onda lunga” risultano a libro paga della guida del centro-destra, l’uomo che si definì “unto del Signore”: con altri superstiti, esprimono patetici tentativi di rilancio del partito. I migliori ex dirigenti del garofano restano chiusi nella dignità della sconfitta e, fortunatamente per l’Italia, continuano a servire le istituzioni repubblicane.