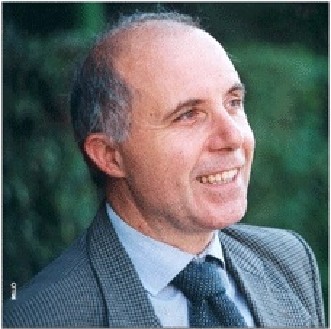Esattanmente dieci anni fa, nel pieno della transizione post comunista, l’Istituto di Economia dell’università di Cracovia organizzò una conferenza internazionale sulle questioni etiche legate alla crisi socio-economica nell’Europa centro-orientale. Intervenni con un paper centrato sul ruolo della fiducia nella costruzione di società giuste e ricche. Tentando di applicare l’apparato teorico esposto, sostenevo che la mancanza di fiducia nelle persone e in genere nel futuro, caratteristica di quelle società terrorizzate prima dal comunismo e ora dagli arrembanti “nuovi ricchi”, fosse di ostacolo al successo della transizione. In particolare chiamavo l’attenzione sulla necessità di dar vita a istituzioni di mercato socialmente responsabili. In effetti, dove gli sviluppi della politica e dell’economia hanno consentito a quella ricetta di affermarsi, vedansi Slovacchia e Paesi Baltici, mercato e democrazia hanno avuto successo, arricchendo i paesi e dando più felicità alle persone. Ebbi modo di citare, in quel contesto l’affermazione di R. Tartarin a commento di penuria e iperinflazione in Urss: “L’originalità storica del mutamento ad est sta nel tentare una trasformazione contrattuale”, da basarsi, manco a dirlo, sulla fiducia tra le parti.
La frase calza perfettamente sulla transizione cui da qualche anno la sfida del mercato globale ha chiamato l’Europa. Si tenga presente che il vecchio continente si era affacciato agli anni ’10 con un invidiabile accumulo di successi politici (assimilazione delle nuove democrazie europee), economici (primo mercato al mondo, euro forte), sociali (estensione del welfare, integrazione degli immigrati, crescita della partecipazione). Alla vigilia del suo sessantenario (2011), l’Europa risulta continente in sicurezza sicurezza che ha cancellato ogni conflitto armato, è protagonista di un esemplare regionalismo cooperativo, ha il primato nella produzione e nel commercio internazionali, cavalca un euro così robusto da competere col dollaro, dispensa un welfare che fa invidia a molti. Però resta nano politico, barcolla inaspettatamente sotto gli attacchi speculativi ai debiti sovrani di Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Italia, Francia, paventa la crisi delle istituzioni comuni e dell’euro. A fungere da catalizzatore è la fiducia degli europei e degli investitori: più cala la fiducia nelle istituzioni e nella loro capacità di rilanciare l’economia, più sale il rischio del fallimento del progetto europeo.
L’Europa può scivolare, mancando la fiducia, quindi investimenti e rischio imprenditoriale, in recessione e stagnazione, sempre che queste, viste le ingenti risorse pompate alle banche dalla finanza pubblica internazionale non imputridiscano in stagflazione. In molti se la prendono con Frau Merkel che tentenna e non adotta il piglio usato per tirar fuori dalle secche i länder dell’est tedesco. Dimenticano, i critici, che la cancelliera risponde all’elettorato nazionale, non a quello europeo, e che può darsi fiducia solo ad un progetto sul quale si disponga di poteri e controllo effettivi. Se si vuole che la Rft piloti l’uscita dalla crisi, si renda la Germania più eguale degli altri eguali che siedono al tavolo Ue, si proceda alla “trasformazione contrattuale” dell’esistente trattato creando tra i 27 una catena corta di comando economico. Pur dovendoci chiedere se la Merkel, che si è formata non al calore europeista renano ma al freddo nazionalismo burocratico della Germania comunista, sia in grado di credere nel progetto europeo, vedremmo l’elettorato tedesco, oggi spaccato sull’impegno europeista, riprendere fiducia nell’Ue mettendo in campo per Grecia e Spagna la solidarietà e le
risorse a suo tempo utilizzate per risollevare i länder orientali.