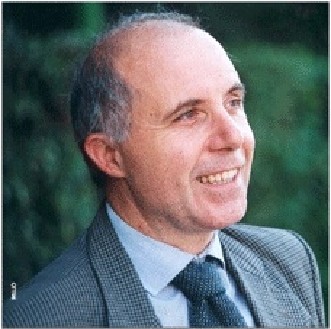La telefonata con la quale Fabrizio Cicchitto (da giovane leone della sinistra socialista di Riccardo Lombardi, a eminente grigia volpe del bestiario berlusconiano) ha attirato il primo ministro Monti fuori dal vertice sulla sicurezza nucleare di Seul mentre Obama concludeva citando a braccio il capo di governo, insegna molto.
Per la cronaca: il presidente Usa interveniva sui destini del pianeta, Cicchitto cercava la sconfessione del ministro della giustizia Severino impegnata sulle misure anti corruzione. Almeno tre le considerazioni. Il domestico, anche il meno urgente e rilevante, prevale, nella cultura politica italiana, sull’internazionale, anche quando questo significhi l’incontro più strategico che possa darsi visto che riguarda la sopravvivenza della specie umana. Gli esponenti di partito ritengono che le istituzioni dello stato siano “cosa loro” e di conseguenza trattano da dipendenti gli uomini che le interpretano.
Sotto il profilo dell’etichetta istituzionale, Monti si è fatto mancare di rispetto ed ha mancato di rispetto, fornendo uno squarcio eloquente sullo scarso affrancamento del governo dai partiti che lo appoggiano in parlamento. Interessa approfondire la seconda considerazione, perché centra uno dei malanni strutturali della Repubblica, il ruolo dei partiti. Secondo la carta costituzionale, i partiti sono libere associazioni di cittadini, che concorrono all’espressione della volontà popolare verso le istituzioni, anche attraverso i gruppi parlamentari: Cicchitto, ad esempio, è anche capogruppo Pdl alla Camera. Come dice il nome, esprimono interessi “di parte”, di fazioni e corporazioni. Se lo fanno bene, concorrono alla formazione dell’interesse generale, mai sono stato o istituzione pubblica. Nella confusione incorsero anche le Brigate Rosse, quando definirono il sequestro del presidente della Dc Moro, attacco “al cuore dello stato”: la potente Dc che sfornava a ripetizione governi e presidenti, era e restava associazione privata! E fu grave, sotto il profilo della cultura istituzionale, che nessuno all’epoca sollevasse una questione che non era di forma, ma di sostanza. Si noti che la personalizzazione subita da alcuni partiti negli ultimi due decenni ha fatto emergere “anche” la necessità di rappresentare bisogni privati del leader, riducendo ulteriormente la capacità partitica di interpretare gli obiettivi generali A pagare detti “privati” sta però la finanza pubblica, il che risulta una contraddizione in termini, specie quando, come si deduce dall’affare Lusi-Rutelli, il denaro è eccessivo e viene quindi indebitamente utilizzato per fini personali. E’ opportuno chiedersi perché non si sia ancora regolato il finanziamento “privato” dei partiti e perché questi non accettino, come ha fatto la Chiesa italiana nonostante il regime di concordato, di andare sul mercato del consenso civico chiedendo ai cittadini di sostenerli versando parte di quanto dovuto allo stato con la dichiarazione annuale dei redditi.
L’occupazione del potere e non solo (i partiti scelgono i dirigenti della Rai, degli ospedali, delle Aziende pubbliche e semipubbliche; sono nei giornali e nelle università, nelle banche e nelle fondazioni bancarie) costituisce il fattore P che impedisce all’interesse generale di emergere. Non si premia il merito ma la fedeltà, con la conseguenza che non vanno avanti necessariamente i bravi e competenti. Tornino i partiti alla costituzione: producano politica alta, idee e ideali, progettualità per rilanciare l’Italia e costruire l’Europa. Ne guadagneranno.