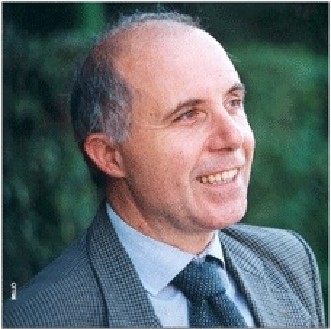Il 15 febbraio del 1942, settant’anni fa, il generale giapponese Tomoyuki Yamashita, dopo aver attraversato in bicicletta più di cento chilometri di foresta tropicale, arriva da terra a Singapore, sorprendendo il corpo di guardia britannico tutto schierato verso il mare. Piccolo e grassoccio, si piazza sul fianco settentrionale della città intimando, agli sbigottiti militi dell’impero di Albione, la resa senza condizioni. Cinquantamila tra britannici, australiani e indiani, si consegnano al nemico.
Per non smentire le tradizioni di crudeltà estrema con cui gli alti gradi del Sol Levante stanno conducendo la guerra nel Pacifico, Yamashita dispone per i suoi licenza di sterminio dei residenti cinesi, facendo un numero di vittime civili calcolato dagli storici tra le trentacinque e le cinquantamila.
La pulizia etnica, che i cinesi ricorderanno come Massacro di Sook Ching, dura un mese. Il generale passa alle cronache
con il nome di “Tigre della Malesia” (Singapore sarebbe diventata città stato solo negli anni ’60; all’epoca, con Malacca e Penang costituiva gli Straits Settlements, le colonie degli Stretti) e, nella nuova veste di eroe della patria, è promosso al vertice delle forze che occupano la Manciuria passando, nel 1944, nelle ancora più strategiche Filippine.
Come racconta l’amico Toni Truzzi in un libro di memorie che ho recensito in questa rubrica, a Singapore lo stato maggiore di Yamashita si insediò al Raffles, un hotel dove ho avuto il piacere di soggiornare io stesso, annusandone i vecchi potenti odori coloniali e sbirciando con angoscia, tra le foto degli ospiti storici, il profilo di quell’eccellente prodotto del militarismo nipponico, passato alle cronache dei crimini di guerra anche per non aver fatto, nell’ultimo anno del conflitto, un solo prigioniero.
Il fanatico e sanguinario non la smise neppure dopo la resa senza condizioni dell’imperatore, annichilito dalla doppia esplosione nucleare, continuando a macchiare la sua fedina di soldato con atrocità gratuite. Fu costretto ad arrendersi il 2 settembre a Leyte, Filippine, consegnandosi al generale americano Jonathan Wainwright. Giudicato per violazione del diritto di guerra e per aver dato continui e ripetuti ordini di strage di civili e soldati, fu impiccato il 23 febbraio del 1946. Singapore e l’intero Sud Est asiatico, martoriati per lunghi anni dal fanatismo militarista nipponico (a parte i reiterati eccidi, 10 milioni tra cinesi, filippini e coreani furono impiegati come schiavi per arricchire imprese come Mitsubishi), gioirono alla sentenza che faceva giustizia di tante sofferenze.
Resta la domanda sul perché una civiltà raffinata come quella giapponese registrasse quella deriva dai princìpi minimi di umanità e legalità. E, domanda anche più significativa, perché, a differenza di quanto fatto da Germania e Italia rispetto ai crimini di guerra, il Giappone eviti tuttora consapevolezza del male ingiusto perpetrato sulle popolazioni vicine, in particolare sul genere femminile umiliato dal gigantesco traffico di “comfort women ad uso e consumo delle sue truppe.
Il paese non sa chiedere perdono, e mai è andato oltre l’espressione del “rammarico” per l’accaduto. Criminali di guerra hanno ricevuto onorata sepoltura nei santuari della memoria nazionale e uomini politici, come Koizumi da primo ministro, non mancano di rendere loro pubblico omaggio. Circolano nelle scuole nipponiche libri di storia che tuttora esaltano le performance di quei delinquenti, come se i loro atti fossero da considerarsi eroici e patriottici.