Per tornare alle origini di un’interrogazione sulla cultura specificatamente italoamericana bisogna risalire al 1825. È Ugo Foscolo, insospettabilmente, a darne notizia e a formulare in un carteggio, per la prima volta, un pensiero esplicitamente rivolto a questa sottocategoria letteraria. Fino al 1885 se ne perdono poi le tracce, in un gap di silenzio durato sessant’anni. Oggi rinfoltita dal gran numero di autori che vanta, seppure ignoti alla massa, la letteratura italoamericana rivendica una posizione di diritto nell’ambito della critica artistica, sia prosastica che poetica.
Anthony Tamburri, direttore del John D. Calandra Italian American Institute della City University of New York (che avevamo intervistato su La VOCE proprio a proposito del suo libro), se ne occupa dedicando a questa produzione letteraria il suo libro Re-reading Italian Americana, diviso in tre sessioni, di cui la prima è rivolta allo stato della ricezione della letteratura italoamericana, sia in Italia che in America, mentre la seconda e la terza parte analizzano ciascuna sei autori, di prosa e di poesia.
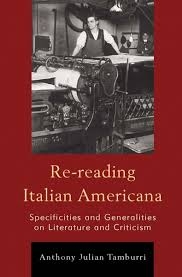 Se n'è discusso il 10 settembre alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della NYU con due ospiti d’eccezione: l'autrice e critica Josephine Hendin della New York University e il professore Martino Marazzi dell’Università di Milano. Entrambi si interrogano sulle motivazioni che hanno portato all’oblio di questo genere di letteratura, che pur vanta splendidi esempi di contemporaneità. La chiave di lettura offerta dalla Hendin per affrontare gli autori proposti da Tamburri è quella della post-poetry ovvero un’indagine che, oltre il linguaggio e attraverso di esso, indaghi sull’essenza della comunità che gli ha dato vita: “Bisogna creare una comunità che discute e indaga sulle sue potenzialità – sostiene l’esperta – La comunità è quella della letteratura latino-americana, inclusa l’italiana, pensando soprattutto all’eredità linguistica e alla sua commistione con la cultura ospitante. Il metodo innovativo di quest’inclusione dell’italianità in America genera una sottocultura vera e propria, che merita un nome e un’attenzione a sé”.
Se n'è discusso il 10 settembre alla Casa Italiana Zerilli-Marimò della NYU con due ospiti d’eccezione: l'autrice e critica Josephine Hendin della New York University e il professore Martino Marazzi dell’Università di Milano. Entrambi si interrogano sulle motivazioni che hanno portato all’oblio di questo genere di letteratura, che pur vanta splendidi esempi di contemporaneità. La chiave di lettura offerta dalla Hendin per affrontare gli autori proposti da Tamburri è quella della post-poetry ovvero un’indagine che, oltre il linguaggio e attraverso di esso, indaghi sull’essenza della comunità che gli ha dato vita: “Bisogna creare una comunità che discute e indaga sulle sue potenzialità – sostiene l’esperta – La comunità è quella della letteratura latino-americana, inclusa l’italiana, pensando soprattutto all’eredità linguistica e alla sua commistione con la cultura ospitante. Il metodo innovativo di quest’inclusione dell’italianità in America genera una sottocultura vera e propria, che merita un nome e un’attenzione a sé”.
Un aspetto importante di questa raccolta è la sua apertura a più dimensioni temporali: non soltanto un occhio al passato o al presente, ma fondamentale diventa la prospettiva futura del rinnovo di questo genere letterario. “Non esisterà più la Little Italy di una volta, l’Italia in America non è solo questo o comunque non lo è più – conclude la studiosa – Si apre così la domanda: cosa accadrà dopo?”. Anthony Tamburri sembra saperlo o comunque si sforza di dare un impulso e un contributo a questo studio, indicando altresì i paradossi di un’Italia che ha fatto di John Fante una star dell’italoamericanità e contemporaneamente ha ignorato autori altrettanto godibili, come ad esempio Pietro Di Donato. Lo stile verghiano di questo romanziere lo rende accessibile e interessante allo stesso tempo, aprendo a punti di comparazione sui quali far leva per penetrare più a fondo nel suo stile di scrittura. Di Donato è anche il preferito di Martino Marrazzi, che da Milano è approdato a New York appositamente per discutere del tema in questione, conferendogli già per questo l’importanza che merita.
“Gesù Giuseppe e Maria, assisteteci nell’ultima agonia”. È da questa frase, che Di Donato mette in bocca al padre morente nel suo romanzo proletario Chirst in Concrete (tradotto in Italia con il titolo Cristo tra i muratori), che Marrazzi prende spunto per provare a spiegare il fascino e la bellezza di cui dispone una prosa apparentemente semplice, in realtà elaborata per essere immediata. “La lingua è il veicolo attraverso il quale accediamo alla cultura”, ammonisce il professore.
L’ultima parola spetta a Tamburri che stimola l’immaginazione dei presenti, parlando di amor proprio. Potrebbe sembrare una bizzarria, riferire l’amor proprio alla cultura italoamericana, ma se si guarda per un attimo al modo in cui gli afroamericani hanno fatto proprio questo concetto non sembra poi così strano. Forse in quel caso di amor proprio ce n’è fin troppo, ma – questo il messaggio di Tamburrri – se la cultura afroamericana rischia di chiudersi nell’autoreferenzialità, al contrario, un’iniezione di fiducia in se stessa, magari attraverso l’apertura di centri dedicati a tali studi, non potrebbe che giovare alla cultura italoamericana e al suo rigoglioso sviluppo.












