È freschissimo di stampa, edito da pochissimi giorni. Si tratta di un testo che racconta l’italicità – e già da questo si capisce perché ne parliamo –, che traccia un percorso temporale dalle prime intuizioni di Piero Bassetti, nel 1995, fino alle rielaborazioni più evolute e recenti del 2013. Il libro si chiama La rete italica. Idee per un Commonwealth, edito da Italic digital Edition.
Il testo raccoglie interventi di molti autorevoli studiosi, accademici, giornalisti, ma anche dell’ideatore di Slow Food Carlo Petrini, del direttore del Messaggero di Sant’Antonio, Padre Luciano Segafredo, e anche una discussione con lo stesso Bassetti, attraverso un linguaggio e un approccio generale molto divulgativo e accessibile a tutti. A onore di cronaca, sono presenti anche due testi del sottoscritto.
Ne parliamo con l’ideatore e curatore del libro Niccolò d’Aquino, che da molti anni segue il pensiero di Piero Bassetti e sul quale ha già avuto modo di scrivere altri testi: Italici (Casagrande Editore, 2008) e Lezioni italiche (Casagrande Editore, 2010). Giornalista, inviato per molti anni e corrispondente in Italia e all’estero per l’ANSA, il Giornale, Radio Montecarlo e per un paio di settimanali del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, ora è corrispondente da Roma e Milano di America Oggi, uno dei quotidiani italiani di New York. È anche responsabile editoriale di una casa editrice di ebook e dirige una rivista nel campo umanitario e religioso.
Allora, come nasce il libro?
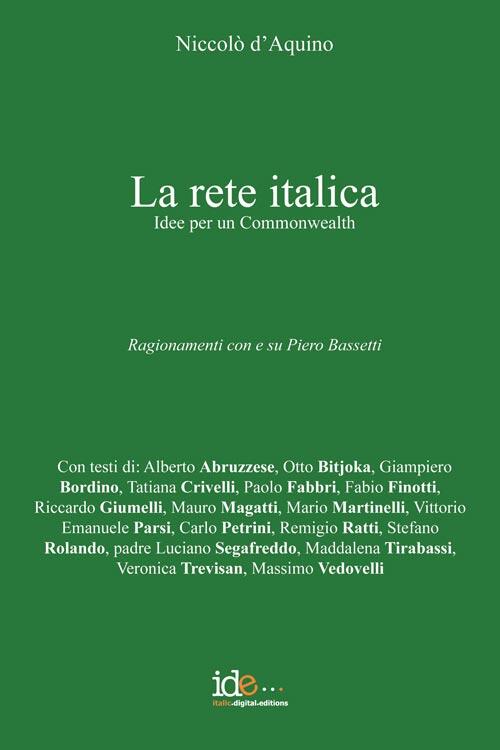 All’origine di questa raccolta-antologia, che supera le 350 pagine – traguardo che non mi sarei aspettato di raggiungere quando ho avviato il lavoro, ma che alla fine avrei potuto facilmente superare se non mi fossi imposto un freno – c’è un mio duplice desiderio. Da una parte, avendo avuto la ventura di assistere, spesso da posizioni non del tutto secondarie, alla nascita e allo sviluppo di un originalissimo pensiero culturale e politico, non ho resistito alla tentazione di fare il mio mestiere: ho voluto fare la cronaca giornalistica della crescita negli ultimi venti anni di questo pensiero, dai primi “balbettii” e dalle iniziali intuizioni fino all’esplodere della consapevolezza che esiste nel mondo un comune sentire che è l’italicità. La maggior parte dei diretti interessati non ne è ancora consapevole. Ma, potenzialmente, sono in grado di dare vita a una rete globale di oltre 250 milioni di persone.
All’origine di questa raccolta-antologia, che supera le 350 pagine – traguardo che non mi sarei aspettato di raggiungere quando ho avviato il lavoro, ma che alla fine avrei potuto facilmente superare se non mi fossi imposto un freno – c’è un mio duplice desiderio. Da una parte, avendo avuto la ventura di assistere, spesso da posizioni non del tutto secondarie, alla nascita e allo sviluppo di un originalissimo pensiero culturale e politico, non ho resistito alla tentazione di fare il mio mestiere: ho voluto fare la cronaca giornalistica della crescita negli ultimi venti anni di questo pensiero, dai primi “balbettii” e dalle iniziali intuizioni fino all’esplodere della consapevolezza che esiste nel mondo un comune sentire che è l’italicità. La maggior parte dei diretti interessati non ne è ancora consapevole. Ma, potenzialmente, sono in grado di dare vita a una rete globale di oltre 250 milioni di persone.
L’altro desiderio che mi ha spinto a questa “fatica” ha motivazioni psicologiche più semplici: volevo rendere giustizia a Piero Bassetti. Il quale è stimato in una cerchia elitaria di pensatori internazionali, da Amartya Sen a Zygmunt Bauman. Ma in Italia – paese in cui larghe fasce dirigenziali sono tuttora vittime di provincialismo e dedite alla vecchia e perdente attività del continuare a guardarsi l’ombelico – Bassetti è sempre stato un politico le cui idee troppo all’avanguardia non ne hanno mai fatto uno particolarmente capito o amato dagli altri suoi colleghi. Facendo la cronistoria del suo pensiero, quasi anno per anno – tant’è che i capitoli sono espressamente titolati con le date dei vari anni – credo di avere voluto dire a questi signori: ecco che cosa vi siete persi, mentre eravate intenti alle vostre polemiche di cortile.
Ma quindi esiste una “rete” italica? O no? Tu stesso hai appena precisato che è “potenziale”…
E lo ribadisco. Sono convinto che una rete italica ancora non esiste. O meglio: esistono, sì, delle reti o delle sotto-reti di italicità o comunque declinabili con il suffisso “ital”. Per esempio quella delle Camere di Commercio italiane all’estero che, infatti, non a caso sono state le prime individuate,“svelate” e, appunto, messe in rete da Bassetti oramai venti anni fa. Ma la Rete nel senso più ampio e stimolante del termine, ancora non c’è. Il sottotitolo di questo volume è: “Idee per un Commonwealth”. Solitamente questo termine inglese viene abbinato alla Gran Bretagna e alla sua espansione non solo economica ma anche culturale e sociale nei vari continenti; e oggi il termine è stato allargato e potenziato con l’aggiunta di “anglosassone”. Recentemente si è cominciato a parlare anche di un Commonwealth ispanico (la Hispanidad) e di uno cinese. Nessuno, invece, parla di Commonwealth italico. Ma questo, in realtà, ha tutte le potenzialità – e anche i “vantaggi” – per esistere. In realtà, abbiamo visto con alcune nostre ricerche che gli “italici”, pur non consapevoli ancora di essere parte di una rete, si muovono spesso – magari anche solo parzialmente – seguendo logiche e interessi di rete. Certo, non basta. Ma è un primo passo.
Quali sono gli ostacoli?
Uno, ma non il solo, è sicuramente la lingua. Non è la prima delle difficoltà e non è neanche particolarmente “pericolosa” ma, forse, è la prima che lo svilupparsi della coscienza italica potrebbe incontrare nel suo percorso. L’inglese, che è l’indiscusso esperanto della globalizzazione e del Terzo Millennio, favorisce il Commonwealth anglosassone. Lo spagnolo è unico in tutta la vastissima rete della Hispanidad. La francofonia arranca ma, comunque, laddove tiene il francese è ancora un buon collante. Gli italici, invece, parlano lingue diverse; hanno cittadinanze diverse, vivono in Paesi e società distanti tra loro, culturalmente e geograficamente. È vero, però, che come dice Bassetti: “Sentono in modo simile. E questo comune sentire è l’italicità”. La lingua, quindi, diventerà un problema secondario. La vera questione, la domanda che ci poniamo è: “Gli italici possono e devono svegliarsi al nuovo ruolo che la globalizzazione e la glocalizzazione stanno offrendo loro. Ma riusciranno a riconoscersi come una grande comunità globale, interconnessa al suo interno da un “comune sentire” molto più che da una comune appartenenza etnico-linguistica e nazionale? La sfida politica è questa.
Oltre ai testi di Bassetti e tuoi, nell’antologia ci sono scritti di saggisti, universitari, intellettuali, accademici, pensatori. Mancano i politici che dovrebbero essere, invece, molto interessati. Come mai?
È la stessa domanda che, a un certo punto nel libro, ho posto a Piero Bassetti. Avendolo seguito per due decenni, mi aveva colpito che proprio i politici non si fossero mai presentati a raccogliere una sfida politica di questa portata. Una sfida magari visionaria e sicuramente in anticipo sui tempi ma decisamente stimolante e, soprattutto – basterebbe pensarci bene – fondata su premesse concrete che un politico non dovrebbe trascurare per non restare indietro: il glocalismo, la Rete, le nuove aggregazioni di interesse, la fine delle vecchie frontiere, le fidelizzazioni emergenti che mandano in cantina appartenenze, alleanze, movimenti e partiti finora ritenuti inamovibili, eccetera. Quando gli ho chiesto perché non ci sia in pratica alcun politico che dimostri interesse alle sue idee, mentre aumentano studiosi, ricercatori, professori e anche imprenditori che iniziano a rizzare le antenne, Bassetti nella sua risposta è stato piuttosto lapidario e, direi, anche feroce: “Mi verrebbe da risponderti: per una questione semantica. Se la politica, come affermano per esempio più o meno tutti i media, è la gestione del potere costituito, allora, dal momento che i politici operano all’interno di un potere costituito che noi vogliamo rivoluzionare, ecco spiegata la ragione della loro diffidenza. I cortigiani del Re non sedevano con i giacobini: i loro interessi e la loro “cultura” erano all’opposto”.
Insomma, tradotto: l’italicità – che è un portato del glocalismo – rivoluzionerà non soltanto le appartenenze ma anche le rappresentanze. Per i vecchi politici – magari anche giovani anagraficamente, ma vecchi “dentro”: nei pensieri, nei progetti, nelle modalità – lo spazio rischia di restringersi. O di autoeliminarsi del tutto. Quindi, il politico medio si cautela come può: meglio stare alla larga, fare finta di nulla, mettere la testa sottoterra come gli struzzi.
Tu hai seguito nascita e sviluppo dell’italicità negli ultimi vent’anni. Il capitolo conclusivo del libro è un’intervista a Piero Bassetti dal titolo: E Adesso? Se fossi tu l’intervistato cosa risponderesti?
Quello che mi ha risposto lui. Partendo da una premessa: scegliere di definirsi italici non significa dover rinunciare a sentirsi italiani, o americani, o canadesi o anche veneti, lombardi, siciliani eccetera. Al contrario: significa accogliere in sé un’identità più ricca e sfaccettata che convive e integra tutte le altre. Che può tranquillamente essere una civilizzazione o aggregazione“seconda”. Perché questo è il fulcro della glocalizzazione. E allora, adesso, sarà compito dei milioni di persone coinvolte raccogliere la sfida, costruire la rete, inventare il commonwealth.
Se non lo faranno, quali saranno i rischi? Tu, per esempio, parlando di civilizzazione italica, scrivi: “Se continua così la strada quasi obbligata è quella di finire nei musei, nelle pinacoteche e nelle biblioteche”. Perché?
Per due motivi. Il primo lo spiegano i demografi con le loro proiezioni e previsioni. Gli italiani non fanno più figli, al massimo quando va bene ne fanno uno. La piramide si sta pericolosamente restringendo. Se continua così pare che nel giro di appena 90 anni gli italiani di passaporto si saranno ridotti dagli attuali 58 milioni a otto o nove milioni.
Il secondo motivo nasce da una constatazione che ben conosciamo: non è che“gli italiani d’Italia” siano famosi per difendere, promuovere e sviluppare le immense ricchezze artistiche, culturali, ambientali di cui il buon Dio, chissà perché, li ha voluti sommergere. Sembra quasi che siano molto più interessati gli stranieri. Allora, se questi non si attiveranno – in particolare quelli tra loro, sparsi per il mondo e ascrivibili alla nuova categoria che abbiamo evidenziato, gli italici, coadiuvati auspicabilmente da qualche italiano coscienzioso e lungimirante – il rischio c’è. La combinazione di questi due “fatti” che ho citato, può far presagire che in un futuro nemmeno tanto lontano ciò che resta della cultura italiana finisca davvero nei musei. Per la gioia e l’arricchimento di qualche topo di biblioteca e, appunto, di museo.
Il tuo libro aveva in origine, me lo hai confessato, un titolo diverso e francamente un po’ curioso. All’ultimo momento lo hai cambiato. Perché?
Sì. Doveva chiamarsi Lo spezzatino di caimano. L’idea mi era venuta da un’intervista che avevo fatto a Carlo Petrini, il padre dello Slow Food e del mangiare e vivere sano e bene. Nell’intervista, che ho pure messo nel libro,“Carlìn” Petrini mi aveva raccontato di un italiano che vive da lungo tempo in Brasile e che un giorno lo aveva invitato a cena: “Vieni, ti cucino uno spezzatino. Ma non di pollo, di caimano. Vedrai com’è buono”. E buono, ricorda Petrini, lo era davvero. Mi era sembrato un esempio, anche allegro, di quella ibridazione costruttiva alla base della italicità di cui andavamo parlando – e, in realtà, di tutte le culture che sono sempre state e sempre saranno frutto di meticciati.
Poi, però, sia pure con un certo rimpianto ho rinunciato a questo titolo: il riferimento al caimano correva il rischio di essere equivocato con il soprannome di uno dei personaggi della scena politica italiana contemporanea. Così ho optato per il titolo attuale che, tra l’altro, completa una trilogia iniziata nel 2008 con Italici e proseguita nel 2010 con Lezioni italiche. Un titolo più serioso ma sicuramente più “professionale”.
La rete italica. Idee per un Commonwealth è disponibile in versione ebook o cartacea su Amazon o su PortaleBook.











