Il 27 gennaio, da sette anni, chi scrive si reca insieme a tanti altri italiani davanti alla sede del Consolato Generale di Park Avenue per leggere i nomi degli ebrei italiani trucidati nei campi di concentramento nazisti. La giornata della memoria, qui a New York, diventa quindi una cerimonia particolare perché, davanti ai microfoni schierati tra l’Istituto di Cultura e il Consolato, ci ritroviamo a leggere quei nomi alternandoci con alcuni degli italiani sopravvissuti alla Shoah e i loro figli, tutte persone che si sono salvate solo perché le loro famiglie erano riuscite a fuggire in tempo in America.
Tra l’approvazione delle leggi razziali nel novembre del 1938 e il rastrellamento degli ebrei nelle città italiane nell’ottobre del 1943, dei 40 mila ebrei italiani solo circa cinquemila riuscirono a mettersi in salvo espatriando. Tra questi, duemila scelsero gli Stati Uniti come loro meta. A New York, Boston, Chicago, in California fino al più sperduto degli Stati dell’Unione, arrivarono dall’Italia professori universitari, intellettuali, medici, scienziati, musicisti, quasi tutti con le loro famiglie. Questa prima “fuga di cervelli” italiani verso l’America non scaturì di certo dalla ricerca di migliori possibilità di carriera, ma dall’istinto combinato alla logica di saper leggere la realtà di coloro che capirono, prima degli altri 35 mila (e che ebbero i mezzi per farlo), che anche il fascismo di Mussolini ormai si sarebbe svelato nella sua essenza di regime criminale, come era stato subito evidente per il nazismo di Hitler.
Se, almeno per i primi che partirono, il viaggio verso la salvezza fu abbastanza agevole rispetto ai milioni di poveri emigranti che negli anni precedenti avevano dall’Italia attraversato l’Atlantico, non lo fu altrettanto l’impatto con il nuovo paese che li ospitava. Gli Stati Uniti sarebbero diventati in futuro la nuova patria per molti di questi italiani di origine ebraica, ma agli inizi si dimostrarono un paese difficile, ostile ai nuovi arrivati, dove l’antisemitismo era diffuso. Soltanto grazie all’aiuto degli ebrei italiani arrivati negli anni precedenti, molti di questi nuovi ebrei italiani fuggiti da Mussolini, tra mille sacrifici e rinunce, riuscirono a sopravvivere in America fino allo scoppio della guerra mondiale. Solo allora, molti di questi “cervelli italiani” furono riconosciuti “utili” allo sforzo bellico contro l’Asse e quindi automaticamente riuscirono ad assimilarsi meglio nella società americana. Molti di questi italiani-ebrei, una volta inseriti anche dentro la struttura governativa di Washington, risultarono poi determinanti nella pianificazione e agevolazione del processo di ricostruzione dell’Italia dopo la disfatta del fascismo.
Gianna Pontecorboli, firma storica del giornalismo italiano a New York, genovese e anch’essa di famiglia di origini ebraiche, in parte toccata da questa fuga verso l’America, ha raccolto in un importante libro le testimonianze di questa “diaspora” negli USA. Edito da Brioschi e arrivato già alla seconda edizione, il libro si intitola America, Nuova Terra Promessa. Storie di ebrei italiani in fuga dal Fascismo.
Con la collega e amica Gianna Pontecorboli, in occasione del giorno della memoria e nel 75° anniversario delle leggi razziali, La VOCE di New York ha realizzato questa intervista.
Gianna, quando e perché hai sentito la necessità di raccontare la storia del gruppo di duemila ebrei italiani che, a partire dal 1938, fuggì dall’Italia per trovare rifugio e salvezza negli Stati Uniti?
La necessità, o almeno la curiosità di ricostruire quella storia l’ho sentita appena sono arrivata negli Stati Uniti e mi sono imbattuta in molti dei personaggi di cui poi ho parlato nel libro. Era l’inizio degli anni ottanta, questa era ancora una vicenda ancora del tutto sconosciuta e molti dei protagonisti non erano pronti a raccontarla, ma io ho cominciato a poco a poco a intervistarli. Poi, facendo alcune ricerche, mi sono imbattuta in personaggi straordinari come Emilio Segrè e Salvador Luria, che hanno vinto il Premio Nobel, oppure Leo Castelli e Vittorio Rieti, che hanno lasciato un segno permanente nel mondo dell’arte e della musica. Così, quando i tempi sono stati maturi, ho messo tutto insieme. Tra l’altro c’erano anche dei motivi personali, perchè una parte della famiglia di mia mamma era venuta a New York, ma mio padre, che aveva appena creato un’azienda di successo, aveva preferito rimanere in Italia, e io mi chiedevo cosa sarebbe successo se anche i miei genitori si fossero imbarcati su una di quelle navi….
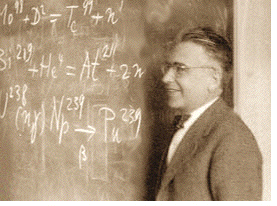
Emilio Segr├¿, durante una lezione in un’universit├á americana
Il tuo libro ha un titolo dal significato forte: “Nuova Terra Promessa”. Ma gli Stati Uniti della fine degli anni Trenta non accolsero proprio a braccia aperte gli ebrei italiani in fuga dalle leggi razziali del Fascismo. Quanto era forte l’antisemitismo allora in America e quanto ne soffrirono i protagonisti del tuo libro?
In effetti, quando arrivarono i primi ebrei italiani in fuga dalle leggi razziali, l’antisemitismo era ancora molto forte e molto diffuso. Anche se per fortuna non esistevano leggi discriminatorie, era normale escludere gli ebrei dalle università più prestigiose, dalle aziende e dagli studi professionali ”wasp”. Le campagne antisemite di padre Coughlin e di Henry Ford avevano lasciato il segno e non era un mistero che lo stesso Dipartimento di Stato vedesse gli ebrei con molto sospetto. In un certo senso, però, gli ebrei italiani, come del resto quelli di origine francese o tedesca, ne soffrirono probabilmente meno degli altri. Erano cosmopoliti, erano spesso colti, non erano molto religiosi e fecero in complesso meno fatica dei loro predecessori russi o polacchi per farsi accettare dall’ambiente circostante.
Scienziati, medici, professori, economisti, avvocati, giornalisti, artisti… Gli ebrei italiani che arrivano negli USA poco prima e allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, sono quasi tutti dei professionisti o comunque hanno già avuto un discreto successo nelle loro attività. Ma in Italia non c’erano forse anche cittadini di origine ebrea con uno status sociale più umile? Perché loro non tentano la fuga?
Certamente, i numeri parlano da soli. Dei circa 40.000 ebrei residenti in Italia, solo poche migliaia riuscirono a varcare l’Oceano Atlantico e a rifugiarsi in Nord e Sud America. La decisione di fare il grande salto richiedeva coraggio, cultura e disponibilità finanziarie, mentre la grande maggioranza della popolazione ebraica, soprattutto nelle città di Roma e di Livorno, apparteneva alla piccola borghesia. Molti, tra i miei intervistati, non erano però ricchi, alcuni erano piccoli e medi professionisti, o insegnanti a cui le leggi razziali avevano fatto mancare lo stipendio. Qualche giovane è arrivato, letteralmente, senza un soldo in tasca.
Hai registrato tra gli ebrei italiani scampati all’Olocausto grazie alla fuga verso la “terra promessa” americana, un qualche “senso di colpa” nei confronti di tutti gli altri rimasti in Italia e poi sterminati nei lager nazisti? Ma questa loro fuga era stata determinata dall’effettiva comprensione dell’imminenza del pericolo o neanche le leggi del ’38 avevano ancor fatto immaginar loro l’immenso crimine che sarebbe accaduto?
Credo che molti abbiano avuto un senso di colpa, o almeno la sensazione di essere stati dei privilegiati. Qualcuno ha vissuto gli anni della guerra soprattutto con un grande senso di angoscia per chi era rimasto indietro, come per esempio il padre di Peter Treves, che non aveva voluto partire per continuare a occuparsi dei beni della famiglia e finì a Auschwitz. Per qualcuno c’è stato anche un senso di colpa per non aver saputo far capire agli altri il dramma che si preparava. D’altra parte, nell’Italia di quegli anni, era fin troppo facile sottovalutare il pericolo e continuare a adagiarsi nella comoda vita di sempre.
Una volta arrivati in America con le loro famiglie, alcuni di questi professionisti e intellettuali italiani di origine ebraica si dovettero spesso arrangiare con lavori molto umili. Ad un certo punto vediamo anche un dentista che vende pentole e tegami… Ma poi la maggior parte avrà successo, qualcuno arriverà a vincere anche il Nobel. Tra tutte le storie raccontate nel libro, quale consideri la più emblematica nel racconto di sofferenza, sacrifici, coraggio e alla fine riscatto dell’avventura degli ebrei italiani arrivati in America prima e durante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale?
Ce ne sono molte, da quella dei sei nipoti poco più che adolescenti e provenienti da tre famiglie diverse che furono ospitati tutti da una zia poverissima e dovettero mettersi a fare i lavori più umili prima di poter tornare a studiare e costruirsi una carriera. Uno di loro finirà anche per morire in guerra in Italia, a pochi chilometri dalla casa in cui si erano rifugiati i suoi genitori. Oppure quella, appunto, del dentista Leoni, che dopo aver venduto pentole si improvvisa, e con un certo successo, commerciante di gioielli a Miami.
Una delle più commoventi, sicuramente, è quella di Massimo Calabresi, che passa da cardiologo del Papa a assistente per un anno, senza garanzie e senza poteri, all’Università di Yale. Anche per lui, il futuro sarà di successo, ma i primi mesi, per sopravvivere, ha bisogno dei piccoli prestiti degli amici.
Nel leggere la memoria che questi italiani di origine ebraica conservano dell’Italia, si denota un profondo legame d’amore per il paese dove sono nati e che hanno dovuto lasciare. In questo sentimento, ad un certo punto del libro fai notare che c’è una grande differenza rispetto agli ebrei in fuga dalla Germania, dalla Francia, dall’est Europa e poi finiti negli USA. Perché secondo te gli ebrei italiani fuggiti in America continuano a sentirsi ancora così italiani nonostante quello che l’Italia ha fatto loro?
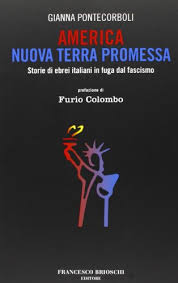 Basta dare un’occhiata alla storia. Gli ebrei risiedono a Roma, continuativamente, da più di duemila anni. In due millenni di storia italiana, ci sono state discriminazioni, ingiustizie, espulsioni e qualche volta violenze, ma gli ebrei hanno sempre in qualche modo fatto parte integrante del tessuto sociale, in tutto il Sud prima dell’espulsione, durante il Rinascimento e poi soprattutto dopo l’apertura dei ghetti e la riunificazione dell’Italia. Malgrado l’ingiustizia subita con le leggi razziali, quasi nessuno ha rotto i ponti con una cultura e una civiltà di cui si sentiva parte.
Basta dare un’occhiata alla storia. Gli ebrei risiedono a Roma, continuativamente, da più di duemila anni. In due millenni di storia italiana, ci sono state discriminazioni, ingiustizie, espulsioni e qualche volta violenze, ma gli ebrei hanno sempre in qualche modo fatto parte integrante del tessuto sociale, in tutto il Sud prima dell’espulsione, durante il Rinascimento e poi soprattutto dopo l’apertura dei ghetti e la riunificazione dell’Italia. Malgrado l’ingiustizia subita con le leggi razziali, quasi nessuno ha rotto i ponti con una cultura e una civiltà di cui si sentiva parte.
Personalmente, ho trovato commovente l’energia con cui alcuni dei personaggi che descrivo, come Max Ascoli o Peter Treves, non hanno mai smesso di dare una mano a favore dell’Italia, prima, durante e dopo la Guerra. Sia nel mondo universitario che in quello degli affari, gli italiani arrivati nel dopoguerra devono loro molto.
Alcuni di questi italiani di origine ebraica fuggiti nel ’38, alla fine della guerra tornano a vivere in Italia. Ma l’Italia non è certo più quella di cui avevano il ricordo. Un paese distrutto, in ginocchio. Altri, la maggior parte, invece non tornano… Questo è dovuto più alle grandi opportunità che l’America cominciava a offrir loro, alle condizioni dell’Italia del dopoguerra, o al risentimento nei confronti di un popolo che aveva accettato supinamente, o peggio nel pieno del consenso, la vergogna delle leggi razziali del ’38?
Sicuramente la constatazione che tanti italiani ”brava gente” avessero accettato la vergogna delle leggi razziali senza protestare e spesso con interessata complicità ha avuto un ruolo nella decisione di rimanere negli Stati Uniti. Come ha avuto un ruolo l’amarezza che tanti hanno provato dopo il primo deludente viaggio nell’Italia del dopoguerra. E la constatazione che la sicurezza finanziaria di prima della guerra non esisteva più. Per molti, però, alla base della scelta ci sono state soprattutto questioni pratiche, una nuova carriera che cominciava a dare soddisfazioni, i figli ormai diventati ”americani” dopo tanti anni di esilio. In molti casi, le famiglie si sono spezzate, i figli sono rimasti, mentre i genitori, che erano arrivati già anziani e avevano fatto molta fatica a integrarsi, hanno preferito rifare le valige. Credo che sia simbolico il caso di Tullia Zevi, che poi diventerà la rispettata presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Suo padre, avvocato, è tornato perché a New York non poteva esercitare e aveva un lavoro modesto, Tullia è tornata per contribuire alla ricostruzione di un’Italia diversa, ma il fratello Eugenio è rimasto negli Stati Uniti perchè aveva cominciato una brillante carriera di professore universitario.
Il rapporto degli ebrei italiani arrivati a New York e nelle altre metropoli del Nord America con gli altri italiani e italoamericani, appare nel tuo libro o inesistente o molto difficile, teso. Questo accadde più per le differenze di classe sociale, o per le tendenze ancora filo fasciste della maggior parte degli americani di origine italiana?
Tutte e due le cose. Non credo che tra gli italoamericani l’antisemitismo fosse particolarmente sentito, almeno a livello personale. Anzi i legami tra la comunità italoamericana e la vecchia comunità ebraica americana sono stati in alcuni periodi molto stretti e i due gruppi hanno combattuto insieme diverse battaglie a favore dei diritti civili e dell’integrazione. Certamente, però, la maggioranza in quegli anni era anche affascinata dal fascismo e non era pronta ad accettare quegli strani italiani così ”diversi” socialmente e culturalmente.
Una certa incomprensione tra i vecchi italoamericani e gli italiani arrivati prima o subito dopo la guerra con una buona sicurezza finanziaria o una laurea in tasca, d’altra parte, non è stata un fenomeno che ha riguardato soltanto gli ebrei italiani…
Il tuo libro sta avendo un meritato successo, è arrivato alla seconda edizione. Ecco, questa ricostruzione storica degli ebrei italiani che si salvarono dal nazifascismo fuggendo negli USA, che messaggio potrebbe trasmettere all’Italia di oggi per aiutare quegli italiani piuttosto depressi non solo dalla crisi economica, ma anche da una crisi di identità e ideali? E conoscere questa storia potrebbe servire anche agli americani?
Nel mio libro, come forse hai notato, ho cercato di raccontare soprattutto una storia di persone, di individui normali di fronte a un problema più grande di loro. Potremmo essere in una situazione simile, domani, io, tu o chiunque altro. Lo sono, in questo momento, infinite vittime della storia in Siria o in Sud Sudan. Credo che questo sia un messaggio importante, per capire quanto sia fondamentale per tutti impegnarsi a guardare quello che ci circonda con gli occhi aperti, senza illusioni, ma anche con la voglia di reagire.












