Secondo i ricercatori, nel mondo c’è abbastanza acqua per tutti. Eppure, secondo le Nazioni Unite, su sette miliardi di abitanti della Terra, quasi 900 milioni di persone non hanno accesso all’acqua salubre e 2,5 miliardi è costretta a vivere con la costante scarsità di risorse idriche. Una situazione che ha fatto definire irraggiungibili l’obiettivo 7 dei Millenium Goals che l’ONU si era fissato nel 2000.
Il problema è che l’acqua non è tutta disponibile per uso antropico: meno del 2 per cento delle riserve idriche mondiali è non salata. A questo si aggiunge che buona parte dell’acqua dolce è disponibile sotto forma di ghiaccio (ma con l’innalzamento delle temperature rischia di finire in mare e diventare inutilizzabile perché salata) o a profondità che finora hanno reso inaccettabile cercare di estrarla. Ma non basta, l’acqua non è equamente distribuita su tutto il pianeta: in alcune zone ce n’è in abbondanza in altre zone fenomeni di desertificazione e periodi di siccità rendono quasi invivibile il territorio (come in alcune zone della California o dell’Africa). A tutto questo sia aggiunge il fatto che la maggior parte delle risorse idriche, circa il 70%, sono utilizzate in agricoltura o per l’allevamento (con consumi eccessivi come dimostra l’analisi della water footprint) o per l’industria e la produzione di energia elettrica, oltre il 25%, mediamente. Solo una minima parte è disponibile per uso diretto: per dissetare la popolazione mondiale e per usi antropici diretti. Se a questo si aggiunge che mentre la quantità d’acqua disponibile si sta riducendo (a causa dell’innalzamento delle temperature medie e della desertificazione) e che la popolazione mondiale (e quindi i consumi) stanno aumentando, non è difficile capire perché secondo i maggiori analisti, l’acqua è uno dei principali fattori che potrebbero scatenare guerre nel prossimo futuro. Tutti questi fattori sono stati analizzati in un libro dal titolo Guerra all’Acqua, edito da Roesenberg e Sellier, del quale chi scrive è coautore e curatore.
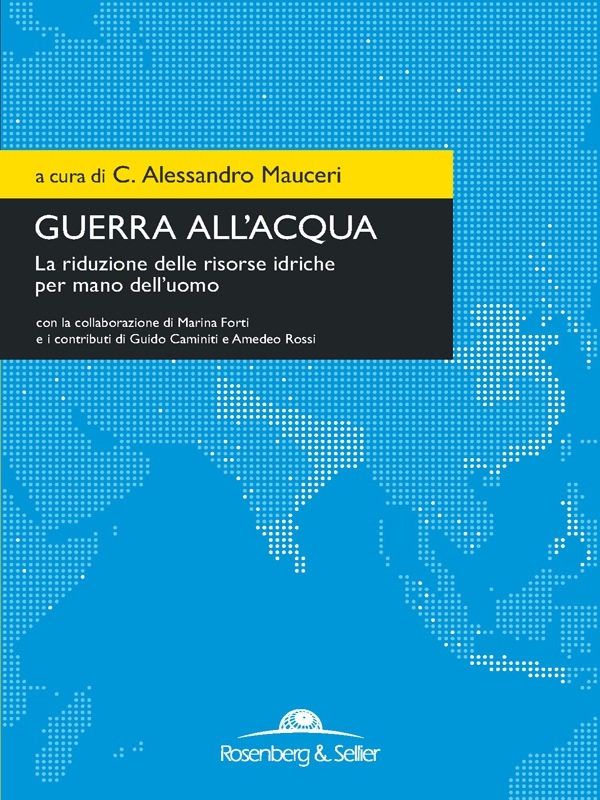 L’acqua è la risorsa più “stressata” in tutto il pianeta: secondo molti è “il petrolio del futuro”. E da molti anni ormai ha assunto il ruolo di variabile strategica in grado di alterare gli equilibri geopolitici anche in aree particolarmente calde come nella striscia di Gaza (dove agli israeliani ne viene fornita in quantità eccessiva e ai palestinesi non ne viene data neanche quanto basta per sopravvivere). Nel 1995 Ismail Serageldin, allora vice presidente della Banca mondiale, disse che “nel prossimo secolo le guerre scoppieranno per l’acqua”.
L’acqua è la risorsa più “stressata” in tutto il pianeta: secondo molti è “il petrolio del futuro”. E da molti anni ormai ha assunto il ruolo di variabile strategica in grado di alterare gli equilibri geopolitici anche in aree particolarmente calde come nella striscia di Gaza (dove agli israeliani ne viene fornita in quantità eccessiva e ai palestinesi non ne viene data neanche quanto basta per sopravvivere). Nel 1995 Ismail Serageldin, allora vice presidente della Banca mondiale, disse che “nel prossimo secolo le guerre scoppieranno per l’acqua”.
Uno dei maggiori problemi riguardanti l’acqua deriva dal fatto che la maggior parte delle grandi riserve idriche sono condivise tra due o più paesi. Cosa che inevitabilmente ha portato a scontri e conflitti armati anche aspri, come quello tra Etiopia e Egitto per il controllo della diga che gli etiopi hanno costruito sul Nilo a monte e che riduce sensibilmente la quantità d’acqua dolce per gli egiziani. Di questo argomento si è parlato durante un workshop che si è svolto nelle scorse settimane al Cairo nell’ambito del progetto Sustainable Use of Transboundary Water Resources and Water Security Management (Water Sum) che si occupa delle sfide legate al settore in questione promuovendo la cooperazione regionale dei Paesi del bacino del Mediterraneo. Diversi paesi, tra cui Egitto, Giordania, Tunisia e molti altri dell’area, si sono confrontati condividendo informazioni ed esperienze per giungere alla messa in atto di protocolli comuni per lo scambio di dati ed informazioni.
Il problema, infatti, è proprio questo: fino ad oggi, non è stato possibile sancire accordi internazionali condivisi da tutti i paesi del mondo riguardanti le risorse idriche. Al massimo si è arrivati alla stipula di accordi bilaterali o tra pochi stati riguardanti problemi specifici (e anche questi spesso non rispettati). Come l’accordo tra i paesi che utilizzano l’acqua del Mekong o come quelli che sono attraversati dal Nilo.
Vista l’importanza che riveste per tutto il pianeta, l’acqua un bene prezioso e tutelato. E invece in molti paesi viene sprecata o resa inutilizzabile. In Cina oltre l’80 per cento dell’acqua dolce è ormai avvelenato da residui e pesticidi che la rendono quasi inutilizzabile per uso antropico. Nel bacino del Mediterraneo i danni causati dall’inquinamento sono ormai irreversibili in molte zone: pochi sanno infatti che questo bacino d’acqua salata è in realtà come un grande lago in cui l’acqua entra dall’Oceano Atlantico e esce dalla stessa porta ma a profondità diverse. L’inquinamento prodotto dai paesi che si affacciano sul Mediterraneo rischiano di arrestare questo flusso continuo e di farne un bacino stagnante.
E anche in Italia (ma anche in molti altri paesi d’Europa e del mondo), inspiegabilmente, buona parte di questa risorsa viene sprecata: molti acquedotti perdono quasi la metà della quantità d’acqua trasportata. Ancora peggiore se possibile la situazione relativa alla “qualità” della risorsa “acqua”: l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in un rapporto dell’inizio 2015 sulle indagini svolte sulle acque italiane superficiali e sotterranee ha messo in evidenza la presenza di 175 sostanze attive nelle falde acquifere esaminate.
Molte, troppe per un bene che serve per irrigare i campi, per gli allevamenti ma soprattutto che serve per decine di milioni di persone che la bevono ogni giorno. Thomson ha detto che il gruppo di lavoro “è stato incaricato da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno riconosciuto che SDG 14 – l’obiettivo oceani – sono necessari alcuni mezzi di sostegno per assicurarsi che vengano completati i cambiamenti previsti” nei Millenium Goals. Obiettivo dell’incontro sarà cercare di trovare un accordo per evitare il declino degli oceani. “Voglio invitare i miei colleghi capi di tutto il mondo di unirsi a noi, e per sollecitare voi, gli uomini e le donne dei media, per sottolineare l’importanza di questa conferenza per tutti sul pianeta, non importa dove essi vivono. Dobbiamo agire subito per salvare i nostri mari e degli oceani. Non solo per noi stessi, ma per il bene delle generazioni a venire “, ha detto Bainimarama, primo ministro delle Fiji. Il suo paese è stato uno dei primi a ratificare gli accordi di Parigi ed è probabilmente uno dei maggiori interessati ad interrompere gli effetti dei cambiamenti climatici in atto.












