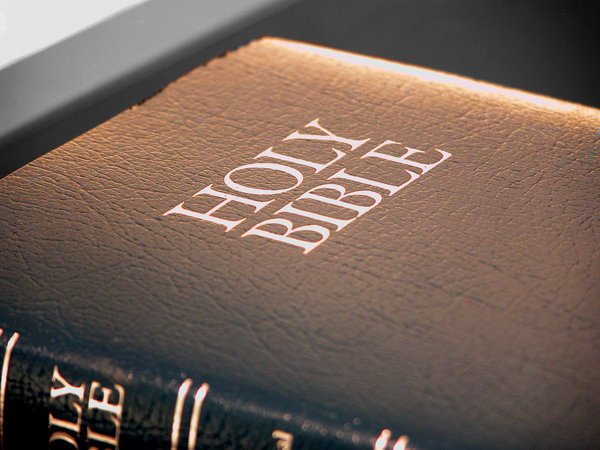Quando da ragazzo immaginavo l’America e gli americani, pensavo sempre ad un popolo estremamente pragmatico; al carattere marcatamente materialista della cultura d’oltreoceano e, in generale, ad una mentalità semplice, diretta e schiva dagli intellettualismi che, dalle nostre parti, erano tanto di moda nel periodo a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80.
Quando poi, anni dopo, ho attraversato l’Atlantico e ho conosciuto in prima persona la realtà americana, mi sono accorto che, per molti aspetti, le cose non si discostavano di molto da come me le ero immaginate. Su una cosa tuttavia, mi ero sbagliato di grosso: malgrado il materialismo ed il pragmatismo della sua gente, in questo Paese, Dio non era affatto dimenticato anzi, veniva chiamato continuamente in causa per suffragare questo o quel punto di vista, come se ogni argomento dovesse necessariamente trovare la sua legittimazione ultima nella religione anzi, per meglio dire, nelle religioni.
Nel Vecchio Continente, la Chiesa rappresenta, col monolitismo della sua autorità, un punto fermo che si può scegliere di abbracciare o rifiutare ma dal quale non si può prescindere. Come italiani, noi possiamo dichiararci credenti, atei o agnostici ma resta il fatto che le radici profonde della nostra cultura cristiano-cattolica, ci contraddistinguono in ogni aspetto della nostra vita, che ce ne rendiamo conto o meno.
Come europei, la nostra cultura religiosa è dentro di noi, ad un livello profondo e, paradossalmente, proprio per questo motivo, dalle nostre parti, di Dio e di religione, non si parla più di tanto nella vita di tutti i giorni.
L’europeo rimane invece interdetto di fronte alla varietà confessionale tipica dell’America dove convivono decine di chiese e culti, anche i più bizzarri.
Storicamente, i motivi di questa particolarità americana sono facilmente individuabili. Nei secoli scorsi infatti, in Europa, tutti coloro che avevano concezioni poco ortodosse e idee religiose che si distaccavano troppo da quelle ufficiali, venivano perseguitati ed erano costretti a fuggire. Dove? Ma in America ovviamente, in un Nuovo Mondo con regole ancora da stabilire e, soprattutto, grande abbastanza per tutti.
L’America del XVII secolo dunque, nasceva fondandosi su molteplici basi spirituali, diverse tra loro ma tutte fondamentalmente ispirate ad una comune identità protestante e puritana. L'aspetto più caratteristico di questa dimensione spirituale anglosassone americana é il suo “frutto sociale”: l’individualismo, che è anche il tratto dal quale, più che da ogni altro, noi latini ci sentiamo estranei.
Durante il Medioevo, l’individuo non aveva spazio o importanza in un ordinamento politicamente e socialmente subordinato alla Chiesa, nel quale ciò che contava non erano tanto le personalità, le differenze o le opinioni, quanto piuttosto la più ampia prospettiva universale della Salvazione e delle leggi divine alle quali conformarsi per assicurarsela.
Con l’avvento della Riforma, la situazione cambia e personaggi come Martin Lutero e Calvino cominciarono a sostenere che l’ingresso al Paradiso non era poi una questione di semplice conformismo a regole esterne ma piuttosto di una autentica rettitudine interiore espressa nel condotta dei singoli.
Questa teoria ebbe l’effetto di far risaltare, in quei Paesi dove attecchì, il ruolo dell’individuo stabilendo per esso, un rapporto più diretto e meno mediato con Dio.
Grazie alla nostra fomazione cattolica, noi latini non ci siamo mai aspettati di dover rendere conto delle nostre azioni in un “faccia a faccia” privato con Dio, al contrario, abbiamo sempre contato sull’intercessione di un vero e proprio esercito di preti, anime e santi in grado di “mettere la buona parola” per noi con il Padreterno.
Il protestante invece, affronta Dio da solo, prendendo su di sè tutta la responsabilità delle proprie azioni.
Individualismo e senso di responsabilità sono due delle caratteristiche principali che contraddistinguono la mentalità americana e che la differenziano maggiormente dalla nostra.
Noi italiani infatti, spesso sorridiamo di quel senso di esagerata rettitudine degli americani; dell’importanza che attribuiscono al fatto di non mentire e di quello zelo quasi fanatico con il quale applicano le proprie regole e leggi. Sorridiamo di tutto ciò con un atteggiamento che è un po' un misto di scherno e sufficienza simile a quello che, a scuola, il furbo della classe ha per il secchione, quello che è sempre preparato, che mantiene una condotta impeccabile e che, perciò è il favorito dei professori.
Noi “furbi”, con secoli di storia alle nostre spalle ci sentiamo ormai disincantati abbastanza da guardare a tutta questa dirittura morale con ilarità, tuttavia, proprio come avveniva a scuola, faremmo bene a ricordare che, alla fine, era sempre il secchione ad ottenere i voti più alti, agli esami e nella vita.