Nonostante la promessa di riaprire gli sportelli e i bancomat entro il 6 luglio, molte banche elleniche hanno deciso di prolungare la chiusura anche dopo che erano stati resi noti i risultati del referendum. Una decisione significativa per molti motivi. Innanzitutto perché, sebbene le banche abbiano parlato di non ben definiti problemi tecnici, in realtà le cause di questa decisione forse sono da ricercare altrove: nella precisa volontà di dare un segnale forte ai greci e al governo ellenico (poco importa quale sia stato il risultato del referendum, a decidere sono sempre le banche e chi le controlla). Ma anche nel tentativo, finora non riuscito, di fermare la fuga di capitali che, da settimane, caratterizza pesantemente l’economia di questo Paese: basti pensare che, nell’ultimo mese, i greci hanno ritirato dalle banche quasi cinque miliardi di euro. Una somma enorme, considerato che il totale dei depositi ammonta a poco più di 130 miliardi di euro.
Una fuga di massa legata alla mancanza di fiducia sull’esito del referendum e sulle sue conseguenze (cosa succederà alla fine della settimana? La Grecia deciderà di avviare le procedure per uscire dall’Euro o cercherà di creare una moneta parallela, come ha suggerito Tsipras?). Ma la vera causa di questa fuga di massa di capitali potrebbe essere un’altra: la gente non si fida più delle banche. Non crede più che i propri soldi, depositati nei caveau delle banche, sono al sicuro.
Alexis Tsipras
Una situazione che fa sorgere spontanea una domanda: cosa succederebbe se anche negli altri Paesi europei i clienti decidessero di fare la stessa cosa? Del resto, non si può certo dire che il rapporto tra cittadini e istituti bancari negli ultimi anni sia stato idilliaco. E di certo in Europa la situazione è peggiorata ulteriormente dopo l’imposizione, da parte dell’Unione Europea, di adottare il regolamento comunitario che autorizza le banche in difficoltà a scaricare le conseguenze della propria cattiva gestione sui clienti e a prelevare dai loro conti correnti somme per risanare i bilanci ed evitare, così, le sanzioni da parte della Banca centrale Europea (l’Italia l’ha fatto pochi giorni fa in gran silenzio, come vi abbiamo raccontato qui).
Il tutto considerando che la ‘salute’ delle ‘casse’ di molti degli istituti bancari europei è tutt’altro che rosea e il rischio di vedere le banche appropriarsi dei soldi dei clienti non è meramente teorico. In Italia a confermarlo sono i dati forniti dall’ABI 8Associazione Bancaria Italiana): “A maggio 2015 l’ammontare dei prestiti alla clientela erogati dalle banche operanti in Italia, 1.815 miliardi di euro, è nettamente superiore, di 111 miliardi, all’ammontare complessivo della raccolta da clientela, 1.704 miliardi di euro”. In altre parole, le banche hanno concesso prestiti per una somma superiore a quella che hanno incassato. E questo senza parlare degli altri investimenti, quelli che le banche effettuano utilizzando come garanzia proprio i soldi dei clienti (la famosa e molte volte discussa “riserva frazionaria”). Che cosa succederebbe se i clienti, stanchi di fare un favore alle banche senza ricevere in cambio le dovute garanzie (l’ultima norma approvata dal Parlamento lo dimostra), decidessero di riprendersi i propri soldi e svuotassero i caveau delle banche?
Queste non potrebbero più concedere prestiti e non potrebbero più beneficiare degli interessi che incassano sui mutui (a volte al limite, se non oltre, dell’anatocismo). Ma la cosa più importante è che sarebbero costrette a ridurre i propri investimenti speculativi. Come, ad esempio, i derivati che, nonostante vietati a Comuni, Province e Regioni, sono ancora largamente diffusi sia a livello nazionale che a livello privato. Un mercato che viaggia al di fuori delle regole borsistiche e che ha raggiunto dimensioni spaventose e, sotto molti aspetti, preoccupanti.
Qualche tempo fa un giornalista americano, Michael Snyder, cercò di valutare questo rischio analizzando i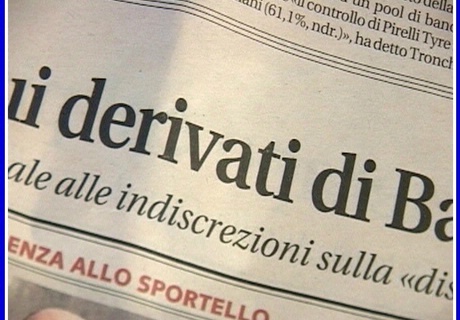 rapporti trimestrali delle banche americane pubblicati dall'Office of the Comptroller of the Currency (Occ). Alla fine venne fuori che le esposizioni ai derivati di ciascuna delle prime cinque banche americane era superiore a 40 mila miliardi di dollari (40 trilioni). Una somma smisurata e irrazionale, se si pensa che l'intero debito pubblico degli Stati Uniti è di 17.700 miliardi di dollari (17,7 trilioni), meno della metà dell'esposizione ai derivati di ciascuna banca. La prova che questa è una situazione tremendamente pericolosa è che la crisi che ancora affligge mezzo mondo è nata nel 2007 proprio a causa degli investimenti sbagliati fatti da una di queste società. 'Errori' di gestione che sono costati quasi un decennio di crisi globale.
rapporti trimestrali delle banche americane pubblicati dall'Office of the Comptroller of the Currency (Occ). Alla fine venne fuori che le esposizioni ai derivati di ciascuna delle prime cinque banche americane era superiore a 40 mila miliardi di dollari (40 trilioni). Una somma smisurata e irrazionale, se si pensa che l'intero debito pubblico degli Stati Uniti è di 17.700 miliardi di dollari (17,7 trilioni), meno della metà dell'esposizione ai derivati di ciascuna banca. La prova che questa è una situazione tremendamente pericolosa è che la crisi che ancora affligge mezzo mondo è nata nel 2007 proprio a causa degli investimenti sbagliati fatti da una di queste società. 'Errori' di gestione che sono costati quasi un decennio di crisi globale.
Per strano che possa sembrare, il rischio che ciò accada di nuovo e che coinvolga in prima di tutti gli europei è tutt’altro che remoto. Le banche in assoluto più esposte al rischio derivati non sono quelle americane: sono quelle tedesche. Solo Deutsche Bank, nel 2013, era “esposta” (termine che fa comprendere che loro stessi considerano questi titoli un rischio) per 55.605.039.000.00 di euro. Una somma che è venti volte il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Germania (poco superiore ai 2.600 miliardi di euro), la prima economia dell'Europa.
Un ‘rischio’ – perché questo sono i derivati – che ‘rischia’ di far fallire non una, ma tutte le banche del mondo. Una preoccupazione che finora è stata abilmente tenuta nascosta (agli azionisti, ma anche ai clienti) grazie a bilanci redatti con grande maestria. Una situazione che la Banca Centrale Europea fino ad ora ha cercato di ridurre, in parte con l’emissione della valuta e in parte grazie all’acquisto e alla vendita indiretta di titoli o ai finanziamenti pubblici. Soldi che spesso sarebbero dovuti servire al rilancio dei Paesi europei e a finanziare lo sviluppo dell’economia e delle imprese. Salvo poi essere utilizzati per tutt’altro. Come nel caso di alcune decine di miliardi di euro entrati nelle ‘casse’ delle banche italiane nel mese di marzo. Salvo poi uscirne subito dopo (come confermato da una pubblicazione della Banca d’Italia) diretti all’estero. “Questo potrebbe essere in parte dovuto a trasferimenti bancari esteri di tipo speculativo da parte delle banche italiane, che ora stanno investendo fuori d’Italia i soldi che hanno ricevuto dalla BCE nel quadro del programma di QE”, ha spiegato Hans-Werner Sinn, presidente del Ifo Institut.
Chissà cosa penserebbero i clienti di queste banche o quanti avevano richiesto un mutuo o un prestito, magari per avviare una nuova attività, sapendo che i soldi dati alle banche nazionali dalla BCE per favorire la crescita dell’economia sono stati utilizzati dalle banche per speculazioni fuori dai rispettivi Paesi. Soldi che, ha aggiunto Sinn, “non è chiaro dove siano finiti”.

Mario Draghi
Già, dove sono finiti i miliardi di Euro del Quantitative Easing varato nei mesi scorsi dalla BCE di Mario Draghi? C’è chi dice che potrebbero essere finiti nelle ‘casse’ di alcune banche tedesche (lo dimostrerebbero alcuni dati dichiarati dalla Bundesbank). Del resto, anche se nessuno ne parla, sono anni ormai che le banche tedesche (e molte altre) cercano di non investire più nelle economie di Paesi come la Grecia o l’Italia. Lo dicono i numeri della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI): a metà di quest'anno, le banche tedesche risultavano esposte verso le attività italiane per appena 99,5 miliardi di euro, il minimo storico.
Una situazione tutt’altro che rosea, quella delle banche europee, che è sempre stata considerata “riservata”. Almeno fino ad ora. Adesso, però, la situazione per le banche potrebbe cambiare e in peggio: gli aiuti della BCE non bastano più e anche l’imposizione dell’Unione Europea di caricare i costi delle speculazioni dei banchieri sui cittadini (con Bad Bank e con il Bail In) potrebbe non essere sufficiente a colmare i ‘buchi’, vere e proprie voragini, causati da investimenti troppo azzardati.
Una situazione che alcuni hanno cominciato a comprendere: è dalla fine dell’estate 2014 che i mercati rilevano quella che non può non essere considerata una vera e propria fuga dall’Italia. Non una fuga di aziende o di cervelli, ma una fuga di capitali. Gli investitori di Borsa (da sempre più attenti all’evolversi della situazione che non i singoli risparmiatori) stanno portando i propri capitali all’estero. In pochi mesi alla fine dello scorso anno il Ftse-Mib, il principale listino della Borsa di Milano, ha perso il 9,5% ovvero circa 40 miliardi di euro. E questo solo in una Borsa. Un processo che potrebbe avere un’impennata nel caso in cui la Grecia decidesse di uscire dall’Euro: la banca francese Société Générale ha stimato perdite di capitali pari al 20-30% dei depositi in Italia e altrettanti in Spagna. E una situazione analoga per le banche portoghesi.
La fuga dalle banche è già cominciata, ma nessuno si azzarda a dirlo per evitare epidemia analoghe a quelle che si stanno verificando in Grecia. Epidemie che, in Italia, avrebbero conseguenze ben più devastanti.












