La nomina di un giudice federale, soprattutto quella di un Justice della Corte Suprema, ha sempre rappresentato un momento molto sentito per la comunità giuridica statunitense, ha spesso segnato una svolta nella storia delle istituzioni politiche americane e, da qualche decennio, viene vissuto anche come appuntamento di profondo e sempre più lacerante confronto tra le principali forze politiche.
Un interessamento così popolare a un processo tanto delicato trova origine in numerose considerazioni, molte delle quali osservabili nello scenario che si è venuto a configurare negli ultimi mesi, dopo scomparsa del giudice Scalia e nel vivo di un’accesa campagna per l’elezione presidenziale che si avvia al confronto finale.
È opportuno fare un breve cenno alla procedura di nomina.
La Costituzione, all’articolo I, sez. 2, riporta una disposizione molto semplice: il Presidente degli Stati Uniti, con il consiglio (advise) e il consenso (consent) del Senato, nomina i giudici federali.
Solo a volersi soffermare sulla natura di questi due organi (Presidenza e Senato) e sul fatto che il Presidente riceve un mandato popolare individuale ogni quattro anni e che il Senato è composto da due senatori per ognuno dei cinquanta stati e un terzo dei suoi seggi viene rinnovato ogni due anni, si possono cogliere alcune delle più grandi potenzialità conflittuali derivanti dal coordinamento tra questi due poteri: il primo incarna in un’unica persona fisica l’autorità e l’unità della federazione; il secondo esprime un’assemblea che rappresenta equamente le sovrane diversità degli stati che alla federazione hanno dato vita; il primo tenderà ad accentrare e unire le forze, eseguendo il programma di governo che ha sottoposto agli elettori; il secondo tenderà alla fuga e alla rapida rinnovazione delle proposte politiche.
La prassi costituzionale e la legislazione successiva hanno poi reso operativa la disposizione costituzionale citata, specificando alcuni passaggi:
1. Quando in una corte federale una posizione si rende vacante, il Presidente degli Stati Uniti è tenuto a scegliere (a “nominare”) una persona che la ricopra; prima di esporre la propria scelta, il Presidente effettua apposite valutazioni, in particolare consultando i senatori del distretto coinvolto, e in generale considerando la conformità del suo candidato alla linea politica dell’amministrazione che rappresenta (i Presidenti nominano giudici appartenenti alla loro stessa area ideologica, a cui, tranne che in rarissimi casi, rimangono fedeli) e le capacità del suo candidato di resistere alle pressioni cui verrà sottoposto.
2. Così maturata, infatti, la nomina viene inoltrata alla commissione giudiziaria (Judiciary Committee) del Senato, la quale (dal 1925) studia tutte le possibili informazioni sul giudice proposto dal Presidente, comprese quelle appositamente raccolte dall’FBI, e prepara le questioni da sollevare nell’audizione (confirmation hearing) a cui viene regolarmente sottoposto dal 1955: le domande hanno a oggetto principalmente le sue posizioni sui precedenti più rilevanti della giurisprudenza statunitense, e in generale sulla politica giudiziaria a cui, se confermato giudice, intende attenersi.
3. Il Committee quindi vota per raccomandare al plenum del Senato la conferma o la bocciatura della nomina proposta dal Presidente. Viene così ingaggiato un confronto parlamentare, che può essere dichiarato concluso solo col voto favorevole di 3/5 dei senatori: a questo punto il Senato si può esprimere sulla nomina, con un voto a maggioranza semplice.
4. Se la persona che è stata nominata dal Presidente ed esaminata dalla commissione giudiziaria, viene così confermata dal Senato, essa diventa giudice federale e rimane in carica finché mantiene un “buon comportamento” (during good behavior): ovvero, a vita.
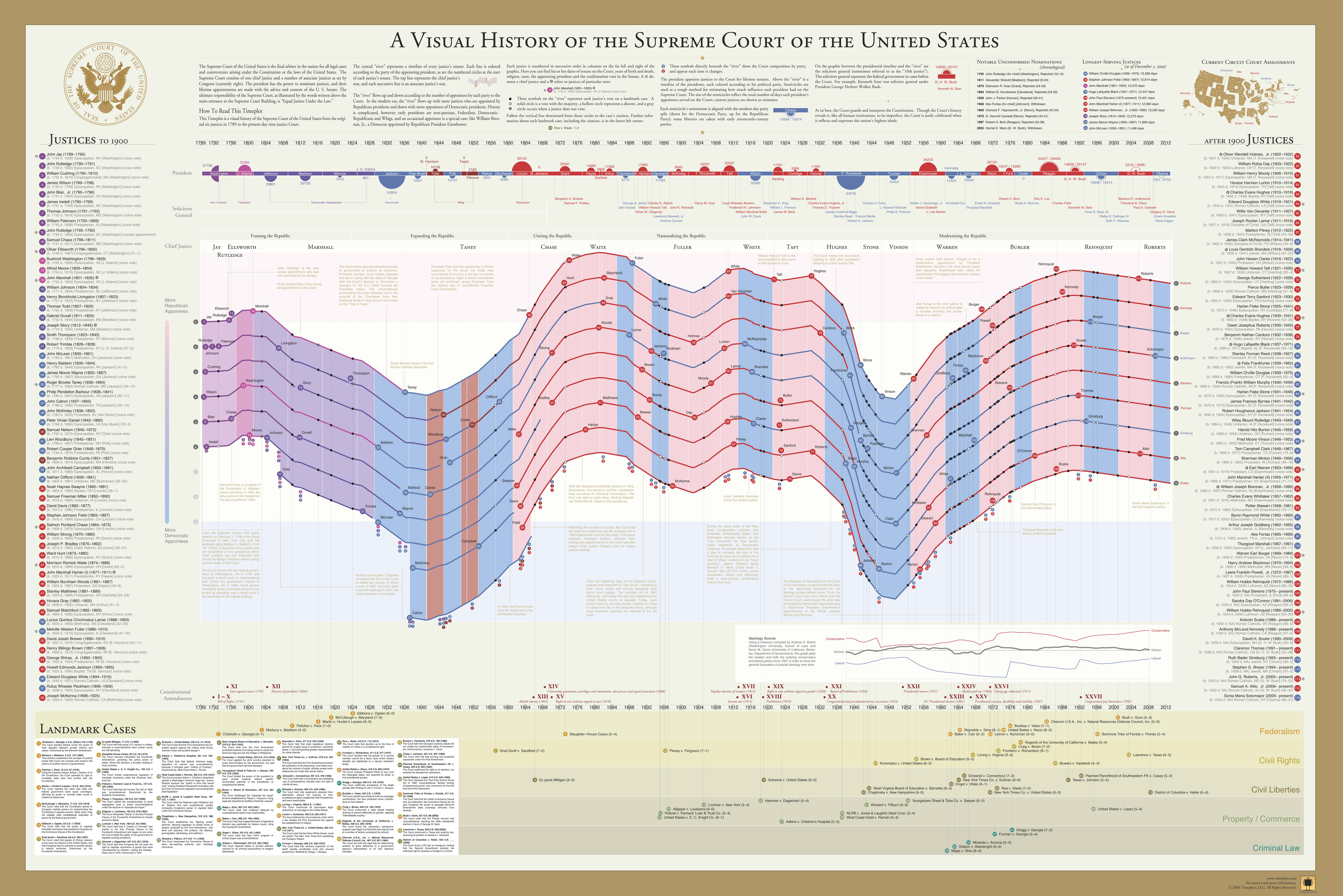
Se oggi un cittadino americano di mezza età, nato in un paese in cui alcune leggi gli proibivano di sposarsi con una persona di colore, si trova a vivere in paese in cui può sposare una persona dello stesso sesso, deve questi rapidi mutamenti anche (secondo molti, principalmente) agli interventi della Corte Suprema. È sufficiente questa semplice constatazione per percepire il grado di influenza di questi giudici nella cultura americana.
Il dibattito politico attorno al ruolo della Corte nel sistema politico e istituzionale americano si è acceso nella seconda metà del Novecento, dopo l’adozione di decisioni tanto articolate e decisive da non trovare quasi paragone negli interventi legislativi sulle stesse questioni: sull’intervento pubblico nel mercato, sulla lotta per i diritti civili, su educazione, affirmative action, aborto e diritti delle donne, e su altri temi altrettanto sensibili si sente la penna pesante dei giudici della Corte Suprema.
Nominato da Reagan per succedere al giudice Powell nel 1987, Robert Bork (che contro il dinamismo giudiziario di quelle sentenze aveva apertamente sostenuto che la sola guida legittima per interpretare la Costituzione fosse l’intenzione originaria di chi la scrisse) non fu confermato da un Senato a maggioranza Democratica: a questo episodio si fa convenzionalmente risalire l’inizio della polarizzazione politica nella selezione dei giudici della Corte Suprema. Reagan avrebbe fatto del contenimento dei giudici (judicial restraint) un suo cavallo di battaglia amministrativa e nel pieno fermento culturale post-modernista sarebbero state elaborate le più ingegnose ‘dottrine giudiziarie’ che lo argomentassero: quella del cosidetto Originalism appunto (la costituzione va interpretata come intesa da chi la scrisse o secondo il significato che allora avevano le parole impiegate), quella del Living constitutionalism (la costituzione è un documento vivente che va letto d’accordo con i mutamenti sociali), quella del Living originalism (era intenzione di chi scrisse la costituzione che alcune sue parti venissero considerate flessibili) e altre ancora.
Queste formule divennero presto dei brand politici con i quali classificare le posizioni di vari giudici. Passò l’idea che l’attivismo giudiziario (mai teorizzato con precisione) fosse profondamente anti-democratico. La capziosa affermazione secondo cui i giudici devono “intrepretare” e non “creare” il diritto (judges should interpret the law, not make the law) iniziò così a circolare diffusamente anche fuori dall’accademia e oggi è talmente entrata nel linguaggio popolare che lo stesso Obama, logorato dai continui duelli ingaggiati con la Corte guidata dal Chief Justice Roberts, si è sentito in dovere di ripetere questo motto rassicurante nell’anticipare la nomina di Merrick B. Garland.
Tra i meriti dell’ufficio ricoperto per trent’anni da Antonin Scalia verrà sicuramente annoverato proprio quello di aver costretto giudici e giuristi statunitensi a interrogarsi sulle loro fondazioni teoriche e a spiegarsi a un uditorio sempre più sensibile e coinvolto dalle decisioni prese da una élite di nove persone educate nelle più esclusive università americane: secondo alcuni, Scalia ha reso la teoria costituzionale sexy.
Ma consacrazioni postume e mitologiche a parte, Scalia andrebbe pur sempre considerato un figlio legittimo del sistema che lottava per cambiare: oltre ad aver egli stesso firmato alcune delle sentenze dal più alto tasso ideologico, è stato un genuino giudice di Common Law che, sposando l’Originalismo, innalzatosi a interprete autentico di sistema di valori distante oltre duecento anni e dedicatosi a studi linguistici e tecniche oratorie, ha fomentato il personalismo normativo che è espressione di quella fase primitiva della “creatività giuridica” sulla quale si è assestato l’ordine costituzionale americano.
Probabilmente è proprio la più affascinante delle peculiarità di questo sistema quella di aver versato nella forma razionale di una costituzione scritta il contenuto delle immemoriali tradizioni britanniche e delle tecniche della Common Law che le hanno alimentate (principio del precedente giudiziario, supremazia del diritto, giusto processo tra eguali), generando quel senso di normatività che pervade l’intera società e le sue rappresentazioni: si badi, comprese quelle sue rappresentazioni espresse nelle corti, e in quella Suprema a maggior ragione. Il procedimento di nomina e conferma brevemente visto dimostra infatti che il giudice federale non è un individuo astratto, politicamente sterile, qualificato solo da un’elevata e neutra formazione giuridica, che accede alla carica con concorso pubblico, ma è prima di tutto una persona che deve essere scelta e confermata da due poteri dello stato indipendenti, dal mandato politico spesso differente e quindi facilmente confliggenti. E sulla base di questa necessaria concordanza istituzionale non sono mancati, nella storia della Corte Suprema, ulteriori innesti volti a marcare altri tipi di diversità che qualificano l’eterogeneità culturale di questo paese: da quelle geografiche (soprattutto dopo la Guerra Civile, con l’accurata nomina di giudici provenienti dagli stati del Sud) a quelle religiose (dopo un bilanciamento tra protestanti, cattolici ed ebrei, per sostituire Scalia è stato provocatoriamente suggerita la nomina di un giudice ateo), passando per quelle relative a sesso, razza ed etnia.
D’altro canto, un incarico che (salvo impeachment) può mantenere finché ritiene di essere in grado di svolgerlo e un compenso che non può essere alterato nel corso della sua carica, permettono al giudice federale americano di assicurare il rispetto della Costituzione, libero dalle contingenze politiche: ovvero, indipendente.
Sul caso americano – su questo delicato intreccio tra l’illuministica separazione dei poteri su cui si basa l’architettura del paese e le mai sopite tradizioni di Common Law che rendono l’interprete costituzionale partecipe della dichiarazione dei diritti – si continua a studiare.
Nel frattempo però risulta evidente l’imbarazzo istituzionale in cui versano i due schieramenti politici e, a viverlo peggio sembra essere proprio l’ala conservatrice che detiene la maggioranza nel Senato: costretti dalla natura delle cose ad affrontare prassi e statistiche sulla conferma dei giudici federali a loro avverse, i rappresentati Repubblicani si sono trovati a fondare la volontà di ostruire il relativo procedimento su un’evidente incoerenza. Da un lato si assiste alla difesa della memoria e dell’eredità del più virtuoso predicatore della neutralità giudiziaria: i giudici, rimproverava Scalia, non avrebbero la “legittimazione democratica” per adottare le sentenze che tanto avversava, legittimazione di cui godono solo i rappresentanti del popolo appositamente eletti. Dall’altro però si afferma l’assoluta necessità che spetti al nuovo Presidente, da eleggere a novembre, provvedere a riempire il posto lasciato da Scalia: i cittadini, viene detto, devono potere esprimere la loro voce in capitolo.
Al di là della difficoltà di analizzare questa argomentazione in punto di diritto, o in qualche modo di ricondurla alla storia costituzionale di questo paese, ciò che può preoccupare non è tanto l’esplicita strategia ostruzionistica (non rara nei rapporti tra Presidenza e Senato, soprattutto nella selezione dei giudici federali) quanto il fatto che chi l’ha ingegnata non sembra consapevole della sua portata distruttiva sugli equilibri costituzionali: invocare la voce degli elettori nella nomina di un nuovo giudice della Corte significa sottoporre al contenzioso elettorale la candidatura politica non solo dell’aspirante presidente, ma anche quella del “suo” giudice, trasformando così la scelta del giudice della Corte Suprema in una sorta di referendum.
Ironicamente, affermare che il futuro Presidente potrà benissimo nominare lo stesso giudice oggi proposto da Obama – lasciando intendere che il problema non è rappresentato dalla persona che Obama ha nominato, ma dal fatto che sia questo Presidente ad averlo nominato – potrebbe suggerire all’eventuale nuovo Presidente Democratico di riproporre proprio lo stesso nome, dando così vita a un precedente che rischia di realizzare il peggior incubo di Antonin Scalia: un giudice, “unto” dagli elettori, siederebbe sul seggio dell’organo costituzionale supremo degli Stati Uniti per il resto della sua vita e senza possibilità di essere rimosso con lo stesso processo con cui vi è stato collocato. “That will be the source of tyranny”.
 Nicola Cezzi è un dottorando in Diritto Pubblico presso la Sapienza di Roma. Durante il corso di laurea è stato exchange student presso la Columbia Law School, dove ha fatto ritorno nel 2016 come visiting scholar. Nicola si occupa di diritto pubblico comparato e sto svolgendo ricerche sulla storia dell’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti. E’ fondatore dei Sapienza Legal Papers
Nicola Cezzi è un dottorando in Diritto Pubblico presso la Sapienza di Roma. Durante il corso di laurea è stato exchange student presso la Columbia Law School, dove ha fatto ritorno nel 2016 come visiting scholar. Nicola si occupa di diritto pubblico comparato e sto svolgendo ricerche sulla storia dell’interpretazione costituzionale negli Stati Uniti. E’ fondatore dei Sapienza Legal Papers









