Se il viaggio è desiderio di conoscere l’altro e, al tempo stesso, possibilità di riconoscere se stessi, si può osservare che la Sicilia rappresenta per chi non vi è nato un’attrazione irresistibile, calamitando fantasie e immaginari dei viaggiatori stranieri che, forti della propria identità, vengono in Sicilia per capirne la conclamata diversità e forse trovano per lo più quello che credevano di voler trovare secondo la loro formazione, i loro desideri. In passato, l’identità univoca dei centri da cui provenivano i viaggiatori, bagaglio e ideale di cultura di cui erano portatori e di cui cercavano conferma in Sicilia, si è scontrata con l’identità plurale dell’isola in cui giungevano, quella pluralità tipica delle periferie e pure delle dimore di frontiera, con il loro intreccio di genti e di culture. Invero, dovevano saperne cogliere la multietnicità antropologica, il suo eclettismo artistico. D’altra parte, se il viaggio è stato ed è una modalità fondamentale per la conoscenza, per lo scambio e lo sviluppo delle civiltà, è particolarmente vero che nel passato senza i viaggiatori stranieri e i loro resoconti avremmo avuto un’immagine limitata della Sicilia e la sua civiltà non sarebbe stata conosciuta adeguatamente, contribuendo altresì, quei viaggiatori e le loro opere, a stimolare negli isolani una conoscenza diretta della società da cui essi provenivano, una consapevolezza diversa da quella provocata dagli scambi artistici e culturali.
Come è noto, l’Italia è meta di viaggiatori sin dal secolo XVII. Ma il viaggio in Italia diviene un fenomeno di costume dal Settecento in poi, assumendo un carattere sistematico e diffuso dalla seconda metà del secolo XVIII. La Sicilia entra in ritardo tra le tappe del Grand Tour, costituendo un’attrattiva per palati fini, a causa della sua posizione remota, difficilmente raggiungibile, all’alone di mistero e d’incognito che l’avvolge, all’ingente patrimonio artistico, all’antichità e consistenza delle sue tradizioni. Benché già a partire dal Cinquecento non manchino diari e resoconti di viaggiatori inglesi e francesi, è solo a partire dal Seicento che la Sicilia diventa meta costante e non sporadica di viaggiatori tedeschi, inglesi, francesi, polacchi, rumeni, che attraverso il Grand Tour si confrontano con i grandi temi dell’arte e della bellezza.
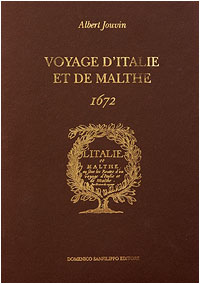 Nel 1672 Albert Jouvin de Rochefort, nel suo Voyage d’Italie et de Malthe, sa apprezzare gli spazi barocchi, gli apparati fastosi di Palermo, in rapporto con la Roma di Bernini, e soprattutto con la sontuosità e la grandiosità degli edifici madrileni. Ma bisogna aspettare i viaggiatori del Novecento, perché alla formalizzazione barocca si assegni la centralità che le spetta nell’immaginario collettivo siciliano, dove i confini tra finzione e realtà si intrecciano. Peraltro, l’approccio alla società e alla cultura dell’isola è avvenuto in maniera diversa, anche in uno stesso secolo, nel grande e articolato Settecento, con la conseguenza che la ricezione della Sicilia si presenta sostanzialmente duplice, come doppia è l’anima siciliana, divisa tra ordine e regola che presiedono al classico, eversione ed eccezione, che conformano il barocco. Tale diversità dell’isola induce al contrasto degli esiti delle ricognizioni dei viaggiatori: positivi sono lo sguardo e le considerazioni sull’antico, negativi quelli sul presente.
Nel 1672 Albert Jouvin de Rochefort, nel suo Voyage d’Italie et de Malthe, sa apprezzare gli spazi barocchi, gli apparati fastosi di Palermo, in rapporto con la Roma di Bernini, e soprattutto con la sontuosità e la grandiosità degli edifici madrileni. Ma bisogna aspettare i viaggiatori del Novecento, perché alla formalizzazione barocca si assegni la centralità che le spetta nell’immaginario collettivo siciliano, dove i confini tra finzione e realtà si intrecciano. Peraltro, l’approccio alla società e alla cultura dell’isola è avvenuto in maniera diversa, anche in uno stesso secolo, nel grande e articolato Settecento, con la conseguenza che la ricezione della Sicilia si presenta sostanzialmente duplice, come doppia è l’anima siciliana, divisa tra ordine e regola che presiedono al classico, eversione ed eccezione, che conformano il barocco. Tale diversità dell’isola induce al contrasto degli esiti delle ricognizioni dei viaggiatori: positivi sono lo sguardo e le considerazioni sull’antico, negativi quelli sul presente.
Bisogna anche ammettere che, se mostravano un gusto chiuso, un occhio miope nel trascurare o addirittura condannare la produzione artistica non classica, fino ad arrivare al paradosso di Dominique Vivant Denon che, nel suo resoconto sul Viaggio a Palermo, rifiuta la ricostruzione di Catania dopo il terremoto perché fatta nel segno del barocco, i viaggiatori stranieri avevano però ben ragione a criticare le istituzioni politiche e sociali della Sicilia del loro tempo, tanto più che ben sapevano apprezzare le librerie cittadine siciliane, la dottrina degli studiosi aristocratici, la conoscenza delle lingue e delle letterature straniere, soprattutto di quella inglese, come fece Patrick Brydone. Questi è uno dei più idonei fra i viaggiatori a cogliere il clima intellettuale siciliano ed è capace di sottile ironia quando, nel Viaggio in Sicilia e a Malta nel 1770, parla del “corpo di guardia” composto da furfanti e del rapporto clientelare di primo stampo mafioso fra il principe che protegge i banditi e costoro che proteggono lui, indossandone la livrea “gialla e verde, e portando anche un distintivo dell’inclito corpo cui appartengono, che conferisce loro di diritto il timoroso rispetto di tutti”.

La ricerca della Sicilia del mito classico attraversa tutta la letteratura del Settecento ed è incredibile ed esaltante che la Sicilia sia vista come grecità che continua, come Grecia ritrovata prima della Grecia stessa. Viaggi nel viaggio, d’altra parte, sono da considerarsi le rituali, tuttavia assai diverse, ascensioni dell’Etna e le visite al palazzo bagherese del principe di Palagonia. Il racconto dell’Etna ha un’impennata nella prosa letteraria di Patrick Brydone, pure così attenta nelle notazioni sociologiche. È una narrazione agile, molto inglese nello spazio che si dà alla preparazione del tè, eppure, tra osservazioni scientifiche e ritratti di piccoli personaggi, si capisce che lo scrittore mira ad altro. La salita al monte con il raggiungimento della vetta, nonostante Goethe insinui che l’inglese non era “andato molto in su”, vuole qualificarsi nell’esito di un’ascensione spirituale, perché “se sulla terra esiste quella che si chiama filosofia, questa deve essere la sua dimora”. Una meta obbligata del tour settecentesco è, inoltre, il palazzo dei Gravina di Palagonia, verso cui i viaggiatori mostrarono più o meno tutti una carenza di sensibilità, un’incapacità ad aprirsi ad una concezione estetica a loro estranea, coinvolgendo nel loro rifiuto altri esemplari dell’arte barocca, dell’arte non classicista nel suo insieme. Al solito è Brydone che, pur nell’analisi critica negativa, se la cava meglio degli altri, per la sua disposizione fantastica, per cui la villa gli appare un “castello incantato”: egli, pur incerto “se rimanere più stupito per l’assurdità dell’immaginazione che ne è stata la creatrice, o per la sua prodigiosa fertilità”, ha la sensazione “di essere capitato nel paese dell’illusione e dell’incantesimo”. Con Denon ci troviamo davanti a una stroncatura della villa, ma egli, a causa del suo gusto antiquario, non comprende neppure la bellezza della Cattedrale di Palermo e non ha interesse per la Cappella Palatina. Anche Jean Houel, nel suo famoso testo Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, fu respinto decisamente dalla costruzione bagherese, dalla sovrabbondanza degli oggetti che la gremivano, ma al suo testo dobbiamo descrizioni precise e alla sua mano di grafico l’incisione puntuale e insieme poetica del vialone d’accesso alla villa.

Tra i più illustri viaggiatori del secolo XVIII va citato il poeta e scrittore Wolfang Goethe che durante il suo Viaggio in Italia visita la Sicilia nel 1787. Contrariamente alla visione mitizzata che accomuna molti viaggiatori di quel periodo, Goethe indaga tra le zone d’ombra dell’isola e della città di Palermo arricchendo le acute riflessioni sui luoghi, i costumi e i personaggi che incontra, con schizzi e disegni. Nel suo Tour fu affiancato dal pittore Heinrich Kniep. Nel caso di Goethe, l’interesse del lettore è catturato dalla rappresentazione del conflitto implicito tra due forti personalità, il grande scrittore tedesco e il principe di Palagonia, due diverse concezioni della vita e dell’arte: un barocco tormentato, un rococò insistito, contro un classicismo esasperato. Goethe, analizzando la statuaria della villa di Bagheria, scrive che “le figure stanno insieme a caso e non per opera di riflessione o di volontà”, e riferisce di una mitologia incredibile che vede “Achille e Chirone in compagnia di Pulcinella”, con un’inventiva priva di senso e di criterio. D’altra parte, suonano come una confutazione goethiana a distanza le riflessioni del russo Andrej Belyi che, nei suoi Taccuini di Sicilia del 1922, individua con acume nella “terribile duplicità” di riso e pianto, di irridenza e gravità l’essenza ossimorica delle deformità palagonesi.

É nell’Ottocento che il numero dei viaggiatori in Sicilia s’infoltisce di personaggi di fama che pubblicano carnet e diari di viaggio. Da Hessemer, che nelle sue lettere dalla Sicilia all’inizio del secolo XIX scrive: “La Sicilia è il puntino sulla i dell’Italia…il resto mi par soltanto un gambo posto a sorreggere un simil fiore”; a Tocqueville (1826) e a Dumas (1835); da Viollet le Duc (1836) a Ruskin (1874) a Maupassant (1885) che, nelle pagine della sua Sicile, parla della qualità eclettica dell’arte siciliana e scrive: “…tutti questi monumenti […] non sono né arabi, né gotici, né bizantini bensì siciliani, e si può dire che esiste un’arte siciliana e uno stile siciliano, che è certamente il più affascinante, il più vario, colorito e ricco di fantasia tra tutti gli stili architettonici”. Da una rivisitazione geniale di quello che egli chiama uno strano e divino museo di architettura, di cui egli sa comprendere, diversamente da pur grandissimi scrittori del Settecento, esempi come la Cappella Palatina o il tempio di Segesta, si passa ad una straordinaria e particolare lettura della figura scultorea della Venere Landolina di Siracusa o alla notazione sociologica sullo sfruttamento dell’infanzia che avviene nelle miniere di zolfo dell’agrigentino: “Dove finisce la collina dei templi di Girgenti, comincia una sorprendente regione che sembra il vero regno di Satana…la Sicilia fornisce quasi tutto lo zolfo del mondo. Le miniere di zolfo si trovano a migliaia in quest’isola di fuoco…”.

L’amore dell’antico persiste in Roger Peyrefitte, che certo conosce la cultura classica della civiltà isolana e tenta di leggerla nella sua complessità. Si veda, a tal proposito, l’incipit della parte siciliana della sua opera Dal Vesuvio all’Etna: “nessun’altra isola alza una fronte più radiosa sull’orizzonte della nostra civiltà. Anzi un frontone, come quello di un tempio…È stata il centro più splendido del mondo mediterraneo. Una terra simile non poteva non essere il paese delle favole…”. Ma si leggano ancora due luoghi del suo esordio: “Il paesaggio siciliano è un miscuglio di esuberanza italiana e di sobrietà greca […] Quella che per i Romani era l’isola del grano, è per noi l’isola dei limoni, dei mandarini e degli aranci”. Peyrefitte vuole celebrare il rapporto che si è realizzato in Sicilia tra natura e storia: una natura riletta e rivissuta nella storia e la storia che s’invera nella natura. Ovvero la simbiosi tra la fisionomia naturalistica dell’isola e le fasi diverse della sua civilizzazione, come se tale fisionomia avesse somatizzato i segni delle presenze “altre” nel tempo.
E la capitale dell’isola? Palermo “è città greca per le sue origini, per la sua luce, per le metope del suo museo, degne di quelle di Olimpia. È romana per il ricordo delle sue lotte contro Cartagine e per i mosaici della villa Bonanno. È araba per le piccole cupole di alcune sue chiese, eredi delle moschee. È francese per la dinastia degli Altavilla che l’abbellirono. È tedesca per le tombe degli Hohenstaufen. È spagnola per Carlo V. É inglese per Nelson e Lady Hamilton…”. Dopo questa sintesi che mira a riunire le componenti della civiltà siciliana, quasi a respingere l’esaltazione classicistica ma per promuoverne un’altra, nel Viaggiatore amoroso del 1980 Dominique Fernandez ritiene che delle forme più note della cultura artistica siciliana la più autentica sia quella barocca, anzi che questa sia la più significativa in quanto più legata alle modalità del sentire, dell’atteggiarsi, dell’angoscioso interrogarsi di “un popolo che dubita tragicamente di se stesso e richiede alle forme create una prova della propria esistenza”.
In definitiva, “la Sicilia taglia in due il Mediterraneo” scriveva Braudel per spiegare il destino storico dell’isola: di crocevia di strade di mare, di incroci di viaggi e approdi provvisori. È forse difficile, prima di tutto per i siciliani stessi, immaginarsi come terra di semplici immigrati, come immobile luogo di accoglienza. Più naturale vedersi come terra di stranieri, in cui nuovi approdi aggiungono altre lontananze alla lontananza essenziale, nuovi esotismi ai già esistenti. In cui il viaggio per arrivare si interseca con altri viaggi, senza concludersi con un definitivo arrivo.












