Finora i fossili, in quanto resti integri o parziali di organismi animali o vegetali un tempo viventi, hanno rappresentato la principale testimonianza di vita geologicamente passata. Il processo di fossilizzazione di un organismo vivente può richiedere milioni di anni ed è un evento raro, in quanto i processi di decomposizione che subentrano alla morte dell’organismo determinano la sua distruzione e anche le sue componenti più resistenti, quali ad esempio ossa, conchiglie, denti, o legno, sono spesso disgregati da agenti naturali.
L’estrazione di DNA dai resti fossili permette di elaborare nuove informazioni sulle popolazioni e la loro storia evolutiva. Tuttavia, la difficoltà nel reperire materiale fossile e il processo di estrazione di DNA, che danneggia spesso in modo irreversibile il campione, contribuiscono a rendere incompleta la documentazione, specialmente per i periodi più lontani nel tempo e per le specie che vissero a basse densità di popolazione.
Recentemente, però, un’importante scoperta scientifica ha evidenziato che il DNA di popolazioni passate si può reperire direttamente dai sedimenti del suolo ed ha rivoluzionato il metodo per lo studio della genetica e della filogenetica delle antiche popolazioni, a tal punto da essere stata definita “lo sbarco sulla luna della genetica”. Il nuovo approccio, noto come “environmental DNA (eDNA) research, si basa sul sequenziamento di frammenti di DNA ottenuti da cellule eliminate da tessuti, peli, feci e urine e che sono rimasti conservati nei sedimenti.
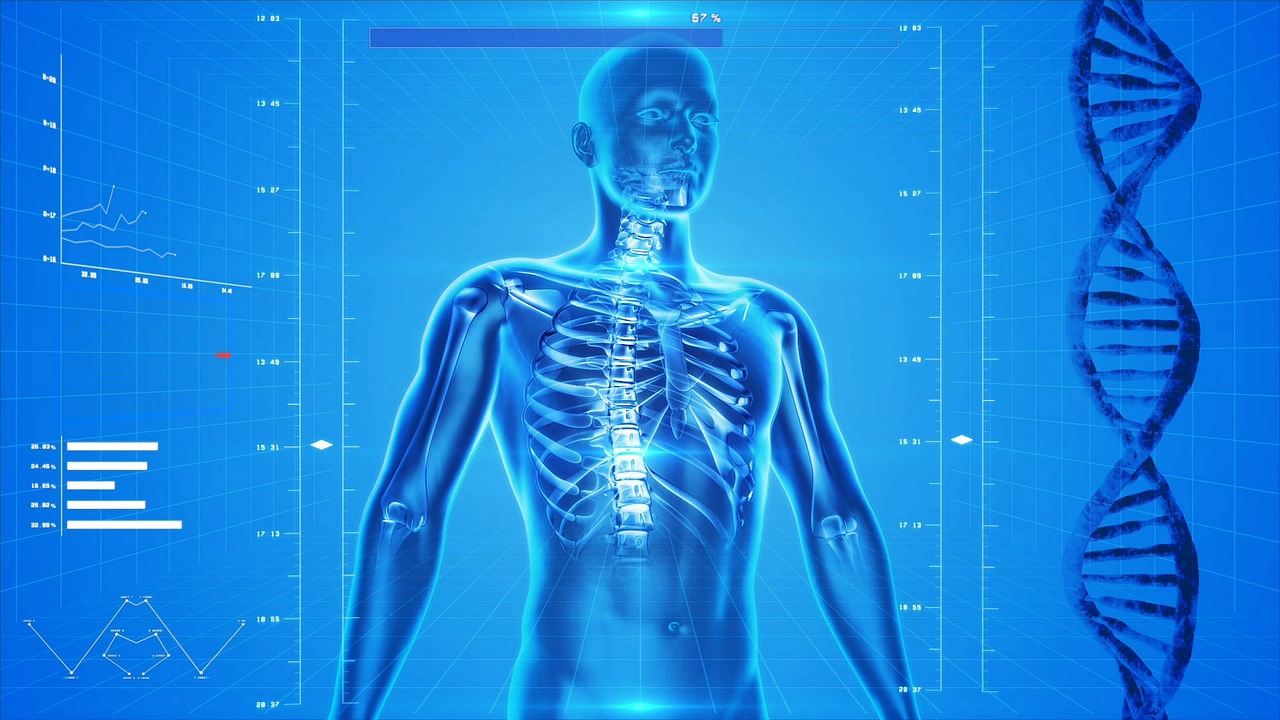
Questo approccio permette di determinare la composizione delle specie in assenza di macrofossili in una varietà di ambienti: sedimenti, grotte, ghiacci, laghi, fiumi ed oceani. Tuttavia, l’analisi di eDNA è per ora ristretta al DNA mitocondriale e cloroplastico, oppure a sequenze di DNA corte, altamente diversificate e ottenute con la tecnica di sequenziamento “shotgun” (mitragliatrice), termine che indica la creazione non controllata di frammenti di DNA a cui è necessario poi assegnare un ordine di assemblaggio ottenibile tramite metodi computazionali. Il professor Willerslev, ricercatore presso il dipartimento di zoologia dell’Università di Cambridge e presso il Lundbeck Foundation GeoGenetics Centre dell’Università di Copenaghen ha spiegato che le feci e le urine di uomini e animali contengono anche cellule dell’organismo.
I frammenti di DNA derivanti da queste cellule sono presenti nei campioni di suolo e possono essere analizzati attraverso l’utilizzo di potenti tecniche di sequenziamento, rendendo possibile la ricostruzione di profili genetici. Willerslev ed i suoi collaboratori hanno dimostrato che il materiale genetico di questi frammenti cellulari, nelle giuste condizioni, può sopravvivere oltre 10.000 anni. Presso la Chiquihuite Cave nelle Astillero Mountains in Messico, infatti, il team di ricercatori ha rinvenuto materiale genetico in sedimenti di 14.000-16.000 anni e attraverso specifiche analisi ha ricostruito che la popolazione dell’orso nero del Messico del Pleistocene tardivo è ancestralmente correlato alla popolazione attuale dell’orso nero americano orientale; allo stesso modo, i ricercatori hanno rilevato che l’estinto orso gigante dalla faccia corta presente in Messico è profondamente divergente dalla precedente popolazione di orsi neri del Canada nord-occidentale.

Per gli studiosi di DNA antico la possibilità di ricostruire genomi da frammenti reperiti nel suolo o nei sedimenti è di importanza fondamentale e lo studio del DNA degli orsi rinvenuto nella grotta messicana rappresenta un esempio eccellente di come la ricostruzione genomica a partire da frammenti di eDNA trovati nel suolo abbia reso immediatamente disponibili nuove informazioni. Questa scoperta ha aperto una nuova frontiera che, con il perfezionamento delle tecniche e delle metodologie, renderà il reperimento fossile non più necessario, ma soprattutto si avrà la possibilità di espandere la narrativa in diversi settori, dall’evoluzione delle specie, allo sviluppo dei cambiamenti climatici e altro.












