In quel di New York, collocati in ogni angolo e buco dei suoi cinque boroughs, esistono più di otto milioni di persone. Vengono da tutte le parti, e vanno da tutte le parti. C’è chi si alza prestissimo, e chi praticamente esiste solo di notte. Ci sono tutti i lavori del mondo, dal paninaro, all’artista, al banchiere, all’operaio. Esistono pochi tessuti urbani svariati e disomogenei come quello new-yorkese. Per questo la città non dorme mai, e per questo attrae a sé personalità da ogni fessura del pianeta, finendo per apparire incomprensibile. Dentro la sua giunga di grattacieli, però, c’è anche un gruppo di scienziati che prova a trasformare questa incomprensibilità in qualcosa di appetibile ad analizzabile. The Human Project, ideato da uno dei più apprezzati professori di Neuroscienze della New York University, è, non a caso, uno dei progetti di ricerca più ambiziosi e futuristici che il mondo accademico abbia mai ideato.
Paul Glimcher, insieme al suo squadrone di scienziati ed analisti, orchestra in fatti lo studio ravvicinato della “condizione umana” di 10,000 soggetti new-yorkesi, provenienti da ogni diversa sfaccettatura della vita. In altri termini, il progetto studierà l’individuo da vicino e registrerà informazioni riguardanti ogni sfaccettatura della vita dei suoi diecimila soggetti, dal lato biologico, a quello sociale, a quello finanziario. Lo scopo, che a primo impatto può sembrare malvagio se non Orwelliano, è quello di arrivare ad una conoscenza più profonda dei processi generali con i quali noi umani arriviamo a prendere decisioni. Questo campo, nominato in inglese quello del decision-making, si è sviluppato, nell’ultimo decennio, ben oltre la psicologia o i limiti neurochimici delle nostre cervella, rendendosi applicabile su scala maggiore in termini politici e societari. Imparare ciò che comportano le decisioni giornaliere di un gruppo d’individui così vasto e svariato ci aiuta ad apprendere come migliorarne le condizioni, che questo sia nel campo finanziario, quello scientifico, quello biologico, o quello psicologico. Il Human Project vuole creare un ritratto vivente ed analizzabile di una popolazione Americana urbana.
Per questo, ognuno dei diecimila soggetti verrà sottoposto ad ispezioni costanti non per un anno, o due, o tre, bensì per venti. Dal lato medico, come prima cosa ogni soggetto sarà sottoposto al sequenziamento del genoma e del microbioma interno, cioè la registrazione del proprio DNA e della flora batterica interna. I soggetti dovranno inoltre offrire alla ricerca tutte le proprie cartelle cliniche, e discutere tutti i loro contatti con droghe o prodotti chimici. Periodicamente, inoltre, saranno sottoposti ad analisi dell’attività celebrale via elettroencefalogramma, e ad altre ancora riguardanti il ritmo metabolico, quello del sonno, e quello dell’attività fisica. Mai, nella storia, si sono registrate così tante metriche diverse, con questa costanza, per un periodo di tempo così prolungato. Per i ricercatori medici, questo registro di dati arriva come manna dal cielo: dalla dietologia alla farmacologia, i campi medici che ne potranno trarre vantaggio paiono sconfinati, al punto da fare veramente impressione. Ciò che però fa ancora più clamore è che questa tipologia di informazioni biologiche sono solo una piccola parte dell’arsenale di dati che questo progetto ambisce a ricevere dai propri soggetti.
Oltre a queste analisi biologiche, in fatti, tutti i partecipanti verranno sottoposti a periodiche valutazioni psicologiche, che includeranno analisi dei tratti della personalità, del quoziente intellettivo, della memoria, e della salute mentale. Tutto sommato, se finissero qui si tratterebbe di un set di metriche psicologiche relativamente standard. Il Human Project, però, spinge oltre, andando a registrare delle metriche appena nate dal campo della Neuro-economia. Si andrà ad analizzare, in fatti, anche la preferenza o avversità verso il rischio, i metodi di attualizzazione temporale (un modo di capire come varia il valore di una ricompensa se posticipata), e le reattività attentive, affettive, ed emotive. In altre parole, si andrà a ritrarre un’immagine concreta ed analizzabile dei parametri celebrali con i quali un individuo affronta le decisioni personali e finanziarie. Naturalmente, queste saranno controbilanciate da un accesso completo a tutte le operazioni finanziarie dei soggetti, in modo tale da poter relazionare i processi psicologici con gli esiti reali. Completano il quadretto vivente un assessment della rete sociale dell’individuo, ed un resoconto completo del proprio percorso accademico, criminale ed umanitario. Spingendo tutte queste metriche all’interno di uno spazio matematico concreto, lo scopo di fondo dell’Human Project diventa quello di rappresentare la complessità umana di un individuo in maniera puramente statistica. Il profilo matematico che questo insieme di dati va a creare, moltiplicato per i diecimila soggetti disponibili, serve, in sé, a scovare relazioni causali tra un campo e l’altro che siano generalizzabili a livello sociale. Queste, una volta identificate, possono a loro volta essere prese di mira da svariate politiche e legislazioni con lo scopo di migliorarne la condizione di base.
Non a caso, l’autodefinito scopo del progetto è quello di “creare le fondamenta statistiche per risolvere i problemi della comunità”. Questa piattaforma di ricerca, dunque, promette una collezione di dati orientata verso il miglioramento delle condizioni che sembrano incidere di più sul benessere della città. Dall’educazione scolastica, alla medicina, quindi, i dati registrati attraverso questa piattaforma diventano digestibili ed applicabili per una miriade di enti di politiche diverse. “Incorporare tutti questi pezzi del puzzle della condizione umana ci porterà un’immagine più completa del benessere umano. Ci renderà abili di localizzare più a fondo le fonti di svariati problemi e dunque di attaccarli con efficienza e precisione”. Dunque, l’ambito di questo studio longitudinale, a differenza di altri in passato (e.g. lo studio longitudinale che negli anni ’60 e ’70 smascherò l’effetto del fumo e dell’obesità sugli episodi cardiaci), non accende i riflettori su alcun dettaglio particolare. Invece, il Human Project è intento ad illuminare con dei penetranti fendinebbia tutte le piccole fessure dell’esperienza umana.
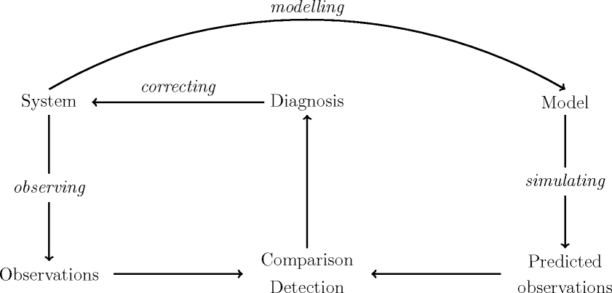
Nonostante di questi tempi il termine Big Data sia diventato sinonimo di eccessivi, malintenzionati processi di monitoraggio, Paul Glimcher non ha paura di categorizzare il suo progetto come tale. Effettivamente, è uno dei (se non il) più ambiziosi e completi progetti di questo genere che il mondo abbia mai concepito. Al giorno d’oggi, questo tipo di dati viene prevalentemente utilizzato da giganti come Google e Facebook a scopo economico-finanziario. Analizzano l’attività dell’individuo sulle proprie piattaforme ed usano dei super computer dotati d’intelligenza artificiale per stabilire delle causalità sulle proprie abitudini. Queste creano un profilo dell’individuo vivente, che poi viene di conseguenza usato per suggerire prodotti, servizi, o esperienze. Logisticamente, il Human Project funziona in maniera quasi uguale. Attraverso l’uso di supercomptuer dotati d’intelligenza artificiale si creano le causalità descritte in precedenza. La differenza, oltre alla natura dei dati ricevuti, è che questi rapporti vengono utilizzati non a fine promozionale, bensì a fine scientifico, politico, e sociale. Anche per questo motivo, il progetto si basa su un compasso morale strettissimo, con il rispetto della privacy, tutelata dal Certificate of Confidentiality del National Institute of Health (NIH), come direzione cardinale.
Anche se l’aderenza a questo codice sarà da attestare, un progetto di questa magnitudine è impossibile da ignorare. L’ambizione di stabilire un modello matematico dell’esperienza di vita di un individuo è futuristica quanto presente. Tantissime aziende ne adottano già la tecnologia. La nascita di un progetto del genere era solo questione di tempo ed organizzazione. Pur parendo Orwelliano e contorto, è un processo necessario e naturale, se non interamente inevitabile al giorno d’oggi. L’importanza etica del Human Project è racchiusa nella sua natura non-profit. Un progetto del genere, esistente al di fuori da profitti e ricavati delle aziende private, può effettivamente lanciare le fondamenta per costruire ponti tra l’umanità, le scienze, la matematica, e le politiche sociali che ci sono ancora completamente sconosciuti.












