Edito da HarperCollins, è uscito Diario Diurno, nel quale Enrico Vanzina, seguendo le orme dell’amato Flaiano, ha raccolto appunti su un decennio 2011-2021 parlando di sé, ma anche della storia dell’Italia, di cinema, di politica e di tanti personaggi a noi familiari, creando aforismi degni dei più grandi. “Sono innamorato degli altri”, dichiara. All’interno c’è anche un Diario Americano.
Parlando delle nostre memorie, oggi spesso le affidiamo ai social rischiando di perderle facilmente.
“Per questo ho scritto un diario, il diario rimane. Come dico nel libro, quando mi chiedono cosa è successo in questi dieci anni, io non faccio bilanci perché non è il mio genere (anche se un piccolo bilancio l’ho fatto al termine del libro) ma noto che c’è una rassegnazione al presente e i social sono una delle armi terrificanti che ci fanno vivere un presente continuo che non diventa quasi mai ricordo, viene spazzato via da un nuovo presente che non è nemmeno mai futuro. Invece il diario è una consegna al tempo di alcune impressioni e poi verrà valutato, verrà amato verrà capito, servirà magari a qualcuno tra vent’anni per capire meglio questo paese. È qualcosa di duraturo. Io l’ho fatto proprio perché è un viaggio nel tempo e io considero il tempo la dimensione più importante della nostra vita, dove bisogna cercare di costruire il presente per cercare di farlo divenire un ricordo.”
Sì, il tempo è una delle tante dimensioni…
“È una dimensione, ma siccome noi non abbiamo il cervello di Einstein, non possiamo capire quanto la dimensionalità sia importante, la tridimensionalità, quattro cinque dimensioni, ce ne sono tante. Sicuramente la scrittura ti fa entrare in una dimensione che nemmeno tu che scrivi riesci a capire dove ti porta, però è importantissima, tant’è vero che il mio autore preferito è Proust, perché il tempo ritrovato è proprio la chiave di volta di tutta la vita. Ritrovare il tempo, non solo viverlo, non solo immaginare quello futuro, ma è importantissimo ritrovarlo. E quando scrivi, lo ritrovi”.
In Diario Diurno si scaglia contro i social, mentre vedo che adesso è un campione di Instagram.
“Quando si è più vecchi si può dire anche che hai sbagliato. Ho capito che è nella mia indole, benché quello che ho scritto sui social continuo a pensarlo, però mi diverte molto questa sfida di misurarmi con qualcosa che mi è totalmente alieno e portaci dentro qualcosa di molto personale. E non lo faccio per interesse, come queste ragazze che hanno ottocentomila follower, alle quali scrivono “ti sogno tutte le notti”, ma io cerco di metterci dei contenuti e condividere, come ho sempre fatto nella mia vita. Anche lì si possono raccontare delle cose in maniera meno estesa, però si possono dare delle emozioni al terminale e per quel poco che posso, fare voglio portare gioia riflessioni agli altri. Io sono innamorato degli altri.
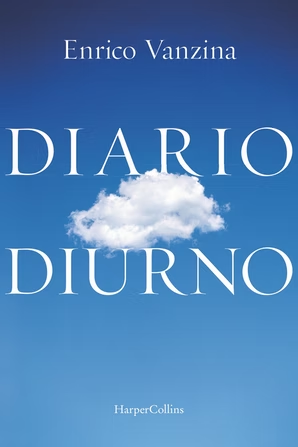
Poi su internet si scoprono dei personaggi straordinari, ricevo migliaia di messaggi ogni giorno, impressionante, non riesco a leggerli tutti ma c’è gente che mi ritrova delle cose andate perse, anche cinematograficamente, delle versioni che ignoravo, consigli preziosi di libri. I miei followers hanno un livello alto, sono molto attenti”.
La vita è un viaggio sperimentale durante il quale perdiamo molti compagni, e ho apprezzato il fatto che lei sul Diario abbia dedicato, a volte anche solo due righe, ma sempre un pensiero sentito agli amici che ha perso in questi 10 anni. Com’è scrivere del dolore?
“Io venivo dalla scrittura del libro su mio fratello (Mio fratello Carlo) che accenno sul Diario, dunque ho convissuto moltissimo con lo scrivere sul dolore e non lo voglio più fare, tant’è vero che non volevo neanche parlare delle persone che se ne andavano, poi quando è scomparsa Mariangela Melato ho avuto una specie di piccolo shock e da quel momento in poi ho capito che questo è un libro sull’amicizia, amicizia mia con alcune persone che però sono amiche anche di chi legge in un certo senso, allora pensavo che nell’articolo 1 della costituzione dell’amicizia c’è scritto: “è un dovere ricordare gli amici”. L’amicizia è il sentimento più bello che c’è, molto più importante dell’amore perché è trasversale, non chiede, dà quando vuole e c’è il dovere di ricordare chi non c’è più, anche con due righe. Riportare quell’emozione forte che ti ha suscitato nella vita un amico è importante e secondo me è condivisa anche da chi legge. C’è anche ammirazione. È una ricompensa postuma al fatto che mi hanno dato tanto e anche in poche righe si capisce che ho ricevuto molto da loro. Anche tante persone semplici che hanno popolato la mia vita e li ricordo a ondate. La scomparsa te li fa diventare quasi più amici di prima, perché stanno proprio lì con te”.
Non si parla mai di morte, la teniamo da una parte, è un tabù.
“Il Covid che ha distrutto vite e ne ha cambiato radicalmente tante, ha avuto un solo merito: ci ha riportati alla consapevolezza che nella vita esiste la morte. I ragazzi pensavamo fossimo immortali e invece hanno visto che muoiono i genitori, gli amici, i nonni soprattutto, per cui hanno ripreso il contatto con quest’altra importantissima dimensione che è la morte. Bisogna vivere sapendo che si muore, è proprio una cosa socratica, perché vivi meglio, non bisogna averne troppa paura. Avevamo preso una sbornia d’immortalità. La vita ci ha riportati a riconsiderare il punto più nodale dell’esistenza”.
Hai scritto che con Charles Aznavour ha perso un amico, anche se non eravate amici. Quanti altri amici hai che non sono tuoi amici?
“Tantissimi perché ho tantissimi idoli. Vivo di grandi emozioni, e invecchiando sempre di più. Io sono amico di Mozart. Quando lo ascolto è come se lui fosse con me. Sono amico dei Beatles e di Chet Baker. Ho tantissimi amici anche nella letteratura e nel cinema, naturalmente. Io penso di essere un grande amico di Stanlio e Ollio, ogni tanto ci parlo, ora ho davanti a me una statuetta di Chaplin“.

Il suo libro inizia con una citazione attribuita a Kenneth Williams: “Un diario parla di solitudine”. Qual è la sua solitudine preferita?
“Il mio lavoro! Sono stato fortunato, ho scelto un lavoro che bisogna fare da solo. Scrivere, immaginare, inventare delle storie. Io non ho paura della solitudine, mi piace andare al ristorante da solo, leggere il giornale mentre mangio… l’unica cosa che non mi fa paura è la solitudine, perché sono talmente pieno di altri che mi popolano dentro che non sono mai solo”.
Quale episodio le ha fatto capire che tutto è possibile nella vita?
“Quando è morta mia madre. Ho avuto un rapporto difficilissimo con lei. Non ci parlavamo più. Poi lei avuto un problema di salute, era depressa e ha avuto una dilatazione del cuore, è rimasta un mese immobile sul letto e poi e morta. Durante quel mese tutti i giorni andavo a parlarle e ho risolto i miei problemi con lei. Io le parlavo e lei mi capiva e ci siamo parlati. Per cui tutto è possibile”.
È bellissimo il suo stream of consciousness passeggiando per i Parioli un pomeriggio, che mi ha ricordato un po’ Caro Diario di Nanni Moretti: attraversare la città e pensare….
“Sì, è vero. Victor Hugo andava in giro alla mattina con sua moglie per i boulevards attorno a casa sua e si fermavano davanti a ogni palazzo. Non commentavano quello che vedevano, ma dicevano un nome, ad esempio ‘Charlers François, médecin, Eugenie Labiche, cocotte de Faubourg’, ogni nome era un ricordo. Ecco a me ogni cosa ricorda qualcuno, un fatto storico, una persona, un episodio di un libro o di un film che è stato girato lì e lì ravvolgi davvero il tempo. Camminare non significa solo far bene al fisico, ma anche ricordare e stupirsi”.
Nel suo libro c’è anche spazio per un “Diario Americano”. Nel 2013 lei vinse il Premio America che dice di meritare per il suo grande amore per gli States.
“Se per Gaetano Afeltra era Milano amore mio, per me è United States my great love! Quando mi sono laureato, mio padre ha insistito per farmi un regalo e io ho scelto di fare il viaggio descritto da Kerouac in Sulla strada. Io da solo in macchina ho percorso il viaggio di Dean. Una meraviglia: gli spazi, la frontiera. Conosco benissimo l’America, ci ho fatto un sacco di film, l’adoro pur vedendone tutte le miserie, però è il Paese che più mi ha colpito. Sono stato spinto a scrivere da due romanzi: Il giovane Holden e On the Road. Amo anche la Francia, ho fatto la scuola francese, ho studiato al Lycée Chateaubriand a Roma, poi ho fatto la Sorbonne per due anni a Parigi, ma l’America, il cinema e letteratura americani, Scott Fitzgerald, Hemingway mi hanno cambiato la vita. Quando girai il film Sognando la California, i Navajo mi fecero montare a cavallo: mi sembrò un sogno! Nel 2013 in South Dakota per il film Mai Stati Uniti, con mio fratello, ci siamo trovati sotto il Monte Rushmore e siamo rimasti a fissarlo credo per mezz’ora, perché ci ricordava Intrigo internazionale di Hitchcock e ci sembrava di vedere Cary Grant. Per me gli Stati Uniti sono ancora il luogo del sogno.
Vale anche per la recitazione?
«Sono pazzo dell’Actor Studios: Meryl Streep, Paul Newman, Dustin Hoffman, Marlon Brando, di quel modo di entrare quel personaggio, ma sono cresciuto in un cinema europeo che trova la sua giustificazione in un famoso saggio di Diderot della fine del ‘700: Le paradox du commedien. Dice che l’attore più è distante dal suo personaggio e meglio lo recita. La cosa trova esempi straordinari: Jean Gabin, Marcello Mastroianni. In tutti i film di Fellini, si sente che c’è dietro lui che fa Fellini ma anche lui che è lui, soprattutto ne La dolce vita. E poi Sordi, soprattutto. Lui faceva diecimila personaggi però era sempre lui. Io ho lavorato con premi Oscar, professionisti straordinari, come Faye Dunaway che si è presentata al provino preparando quattro versioni diverse del copione. Stessa cosa per Rupert Everett. Detto questo, sono più pazzo della vertigine del National Theatre di Londra o di Lawrence Olivier e Charles Laughton».

ANSA/ALESSANDRO DI MEO
Scrive che New York non le piace più. Come amante della Grande Mela mi dispiace molto saperlo. Come mai, cosa è successo?
“Mi è piaciuta tanto. Ora non più e mi permetto di dirlo perché ho avuto una vita lunghissima e a New York sono andato decine e decine di volte. Volevo trasferirmi lì, mia moglie e io avevamo persino trovato una casa da comprare, ho avuto una vita intensissima lì… Assieme a Parigi, New York è stato il grande amore della mia vita. L’ultima volta che sono andato l’ho trovata ostile, per cui non mi piace più, non c’è più quella New York che piaceva a me, ma questo accade con tutte le città. È una questione soltanto di età”.
Tornando all’Italia e parlando di Gervaso, diceva che aveva un talento internazionale e questa è una cosa che il nostro Paese non sa decifrare.
“Lui aveva questa visione umoristica contro il potere becero, il conformismo. Noi siamo un Paese molto conformista, questo è il nostro grande difetto. Invece il vero umorismo è anticonformista, sempre, e lui lo era. Su posizioni però non radicale, di centro. Ho avuto una grande amicizia con Roberto”.
Lei dice che a Roma non ci sono più personaggi. Se è vero sarebbe una mezza tragedia (a parte quei personaggi serissimi che sono i cani, cosa che condivido).
“Non solo a Roma, i personaggi veri sono pochi ormai. Si è persa l’autenticità, siamo troppo globalizzati oramai”.
Oggi come ci fa notare, non ci si aspetta più niente. Non come un tempo che si aspettava la lettera dell’amato. Lei oggi cosa aspetta?
“Io sono arrivato alla conclusione che è meglio non aspettarsi nulla. Come diceva Einstein “Non m’interessa il futuro perché arriva troppo presto”. Arrivano sempre delle cose inaspettate. Tutti i grandi fatti che sono successi in questi ultimi dieci anni erano tutti inaspettati, quasi tutti. Inutile stare lì ad aspettarli. Io mi aspetto solo una cosa: che io possa essere felice. Ho capito che l’unico scopo della vita, al di là delle grandi questioni trascendentali, è la ricerca della felicità. In uno degli ultimi film che ho fatto ho messo una frase di Prévert: “Bisogna cercare di essere felici, se non altro per dare l’esempio”. Noi siamo sulla terra per essere felici e dobbiamo cercare di trovare il modo per esserlo, sennò non ha senso”.












