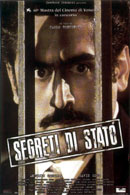Tra polemiche, veleni, ripicche e controripicche, al Festival del cinema di Venezia è andato in scena il film Segreti di Stato, prodotto dalla “Fandango”, per la regia di Paolo Benvenuti. E’ il racconto, in certi passaggi inedito, della strage di Portella delle Ginestre. L’eccidio si consumò in Sicilia la mattina dell’1maggio 1947. A Portella delle Ginestre – una località che si snoda tra le montagne di San Giuseppe Jato e Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo – ignoti spararono su una moltitudine inerme di braccianti agricoli, uomini e donne che si erano recati lì per celebrare la festa dei lavoratori. Per oltre cinquant’anni la tesi ufficiale – accettata da tutti, e accettata soprattutto da quasi tutta l’intellighenzia italiana, storici in testa – è che a sparare sui braccianti, ammazzandone undici e ferendone una ventina, siano stati gli uomini della banda comandata dal fuorilegge Salvatore Giuliano, il celebre bandito di Montelepre. Oggi questa tesi non regge più. Il film di Benvenuti cerca di dimostrare il perché la verità su Portella delle Ginestre deve essere cercata altrove.
Dove? Con molta probabilità, lungo l’asse Italia-Stati Uniti d’America. La strage, in altre parole, potrebbe essere stata compiuta da personaggi – forse mafiosi, o comunque figure mai identificate – che si erano mescolati alla folla e che, a un certo punto, aprirono il fuoco. Giuliano e gli uomini della sua banda, in parole ancora più semplici, quella mattina vennero spediti sulle alture che sovrastano Portella della Ginestra per coprire un’operazione stragista. Certo, qualcuno da sopra le alture di Portella sparò sulla folla, forse all’insaputa di Giuliano. Ma i colpi mortali, come si evince dalla lettura degli atti del processo per la strage celebrato qualche anno dopo a Viterbo, vennero sparati ad altezza d’uomo: chi sparò, ammazzando undici braccianti, era probabilmente mescolato alla folla.
Va detto subito che la tesi del regista Benvenuti non è nuova. Non a caso sui giornali siciliani, nei giorni precedenti la proiezione del film, le polemiche si sono sprecate. A dare fuoco alle polveri, forse non a torto, è stato Giuseppe Casarrubea, di professione preside e storico per passione.
Casarrubea, che è nato e vive a Partinico, è comunista da una vita. Suo padre è stato ammazzato dai mafiosi quando lui era ancora un bambino. E lui è cresciuto con la voglia di ricostruire la verità sui fatti che ha vissuto nella fanciullezza. Perché quando Casarrubea era ragazzino Partinico era sotto il dominio criminale della banda Giuliano. Ed era soprattutto sotto l’egida altrettanto criminale della mafia, che dal 1943 alla fine degli anni Cinquanta ammazzò decine di sindacalisti (compreso il padre di Casarrubea) in tutta la Sicilia.
Perché Casarrubea ha polemizzato con il regista Benvenuti? Perché sostiene che il regista avrebbe utilizzato una parte dei suoi studi senza citarlo. Anzi, per essere precisi, sostiene di essere “la fonte del film”. Vero? Falso? In queste polemiche è meglio non entrare. Però qualcosa la possiamo affermare con la certezza di non offendere nessuno. Chi scrive, nel 1997, intervistò Casarrubea, che aveva da poco dato alle stampe un volume sulla Strage di Portella delle Ginestre (Portella delle Ginestre – Microstoria di una strage di Stato). Un libro che Casarrubea ha scritto lavorando per lunghi mesi proprio sugli atti del processo di Viterbo e su altri documenti (Casarrubea, tra le altre cose, di recente è riuscito a consultare l’archivio della Cia a College Park, nel Maryland, sull’attività in Sicilia dell’Oss, l’Office of strategic services, il servizio segreto Usa). La tesi dei colpi mortali partiti da personaggi mescolati tra la folla e non dalle alture che circondano Portella è già nel suo libro di sei anni fa. Chi scrive ricorda anche la solitudine di Casarrubea, il silenzio che si era creato attorno a lui e, perché no?, anche l’ostracismo di alcuni suoi compagni di partito inseriti a pieno titolo nell’intellighenzia più o meno siciliana.
Nel dialogo con l’autore traspariva pure la delusione per la mancata apertura degli archivi custoditi presso il Ministero degli Interni. Un anno prima, e cioè nel 1996, le sinistra italiana avevano vinto le elezioni (la vittoria dell’Ulivo). Ci si attendeva l’apertura degli archivi segreti e le possibili rivelazioni su Portella e su altro ancora. Invece quegli archivi restarono chiusi. Sotto questo profilo, in Italia, anche con la vittoria dell’Ulivo, non era cambiato molto.
Il dibattito sulla strage di Portella si è arricchito di un altro particolare che, in verità, è stato del tutto ignorato dalla stampa italiana. Circa tre mesi fa un giornalista, Andrea Ballerini, ha pubblicato un’intervista postuma al Michele Pantaleone, uno dei più famosi scrittori di cose di mafia del mondo. L’intervista è stata pubblicata sul mensile l’Euromediteraneo. Pantaleone, che era nato a Villalba, in provincia di Caltanissetta, è l’autore di Mafia e politica, il primo, grande libro rivelazione sulla mafia, pubblicato all’inizio degli anni Sessanta da Einaudi. Pantaleone, oltre che scrittore, è stato un prestigioso dirigente della sinistra siciliana (era socialista) negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale, quando, come abbiamo già ricordato, tanti dirigenti della sinistra, e tanti sindacalisti, venivano ammazzati dalla mafia. Lo stesso Pantaleone, in quegli anni, fu oggetto di un attentato: la mafia di Don Calogero Vizzini, “capo dei capi” dell’onorata società, proprio a Villalba, durante un comizio, tentò di ammazzare lui e Girolamo Li Causi, altro prestigioso dirigente della sinistra comunista siciliana.
Cosa racconta di nuovo Bellerini nell’intervista rilasciatagli da Michele Pantaleone poco prima di morire? Pantaleone dice che nei giorni precedenti all’attentato erano tanti, in Sicilia, a sapere che l’1 maggio si sarebbe consumata una strage a Portella delle Ginestre. Lo stesso Pantaleone lo disse a chiare lettere, circa dieci giorni prima della strage, nel corso di una riunione politica alla quale erano presenti i più alti dirigenti della sinistra siciliana. Per motivi ignoti le parole di Pantaleone caddero nel vento. Perché?
Qui entriamo nel labirinto dei misteri italiani. Da dove si rischia di non uscire più. L’Italia, questo non finiremo mai di ripeterlo ai lettori americani, non è l’America. L’Italia, da Yalta fino alla caduta del Muro di Berlino, è stato un Paese che non è esagerato definire a sovranità limitata. E in questo scenario è oggettivamente difficile ristabilire la verità su certi fatti di sangue. A cominciare proprio da Portella. Casarrubea sostiene che a ordire la strage di Portella furono i servizi segreti americani che avevano sede a Palermo (l’abbiamo già scritto su questo giornale in un articolo pubblicato sei mesi fa). Con molta probabilità, alcuni politici siciliani con i quali Giuliano era in contatto, quella mattina, convinsero il bandito e i suoi uomini a recarsi a Portella. Forse, chissà, quando si ritrovò sulle alture che sovrastano Portella e vide quello che stava succedendo, il bandito capì d’essere stato giocato: capì, magari, che la responsabilità della strage sarebbe caduta sulla sua testa. E’ per questo, per vendicarsi d’essere stato utilizzato come copertura di un’operazione stragista, che nelle settimane successive alla strage cercò, senza riuscirci, di ammazzare un uomo politico democristiano? Questo non lo sapremo mai. Anche perché l’unico testimone che avrebbe potuto raccontare qualcosa sui segreti di Portella, Gaspare Pisciotta, cugino e componente della banda Giuliano, venne ammazzato nel 1953 nel carcere dell’Ucciardone di Palermo. Avvelenato dalla celebre tazza di caffè “corretto” con la stricnina.
Che dire alla fine di tutte queste storie? Il film di Benvenuti è comunque una finestra su una storia controversa. Ma è anche la prova che in Italia, su certi temi, a fare una figura non bella, per non dire altro, è il mondo della storia. Basti pensare che c’è voluto uno storico per passione – Casarrubea – e un regista, cioè Benvenuti, per raccontare una storia che già era in parte negli atti del processo di Viterbo. Per gli storici accademici italiani, invece, la strage di Portella delle Ginestre è stata compiuta dalla banda Giuliano e basta.
Perché questo silenzio? Forse lo snodo di questa inquietante vicenda è politico. Forse la chiave di lettura dei falsi storici confezionati su Portella (e su altre storie di mafia) è nell’eredità del separatismo siciliano, movimento paramafioso che prese piede nell’Isola nel 1943. Quando si decise che a governare l’Italia sarebbe stata la Dc, con la “bendizione” americana, una parte di questo movimento confluì nel partito cattolico. Ma un’altra parte, non certo secondaria, confluì nella sinistra per lo più comunista. La mafia, così, “colonizzava” sia il governo, sia l’opposizione. Cosicché né il governo, né l’opposizione hanno avuto interesse, in questi cinquant’anni, a fare luce su Portella e su altre vicende di mafia. E la storia? Beh, la storia è andata a farsi benedire…