Ci sono persone che, per la coerenza di una vita spesa al servizio della comunità, vanno ascoltate con attenzione. Già deputato e senatore socialista, figura storica del sindacalismo italiano, l’attuale presidente della fondazione Bruno Buozzi affida (con Antonio Maglie) al libro I sommersi – lavoratori disarmati nella sfida con i robot, appena uscito da P.S., quasi 250 fitte pagine di riflessioni sul nostro tempo, partendo dalla dimensione che gli è più congeniale, il lavoro e i lavoratori.
Da lì il complicato itinerario di un libro che non ha nessuna intenzione di sfuggire ai problemi, il primo dei quali è che di lavoro, almeno in Italia, ce n’è poco, il che comporta sempre meno lavoratori e, di conseguenza, minore rappresentanza dei sindacati. L’ultima non è una buona notizia: sul fronte politico i partiti perdono il referente storico che ha loro consentito di elaborare politiche sociali e salariali potenzialmente adeguate alla transizione verso una società meno ingiusta (la cosiddetta economia sociale di mercato è nata da quel dialogo), sul fronte economico l’impresa capitalistica e lo stato elaboratore e gestore del budget perdono l’interlocutore necessario per il consenso popolare alle macro-politiche economiche e fiscali.
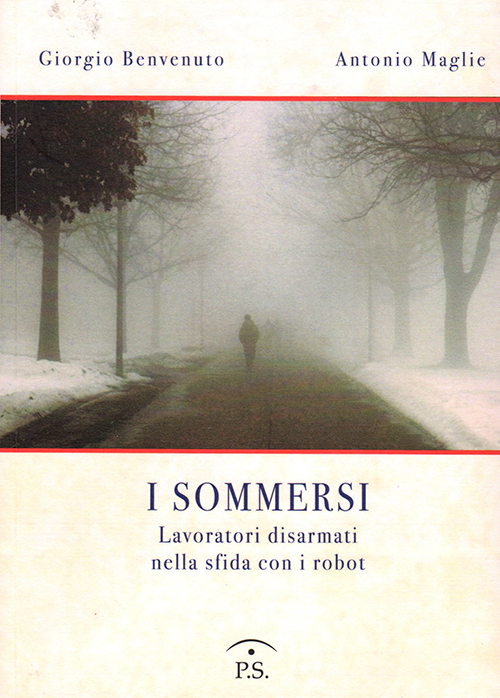
I singoli prestatori d’opera, atomizzati e meno tutelati, si ritrovano invasi da continui processi di aggiornamento tecnologico e ricollocazione professionale, in un mercato del lavoro che non ha certezze a disposizione e che risente di varianti velocissime, spesso stravolgenti. Strumenti che in Italia hanno fatto la storia sociale, come lo Statuto dei lavoratori che prende il nome del socialista Giugni, appaiono desueti e persino sconosciuti ai più. Sia chiaro che il problema non è la scomparsa di ciò che è vecchio. Il problema è che – come documenta Benvenuto – la “nuova società” di diretta filiazione thatcheriana e reaganiana, è peggiore di quella che ha voluto sostituire, in termini di crescita delle disuguaglianze (reddito medio annuo lombardo €25.330, calabrese €15.630), abolizione delle protezioni verso poveri e indifesi, blocco dell’ascensore sociale e culturale, caduta dei salari, insicurezza e precarietà del lavoro. Mettiamoci anche la proletarizzazione del ceto medio, pilastro dello stato democratico e dello stato sociale: si guardi alla condizione di maestri e professori nelle scuole, e a quelle delle partite Iva o dei medici di base, per farsene un’idea.

I “sommersi”, in un contesto del genere, sono quelli che non ce la fanno. Non riescono a nuotare, e affondano. Nella constatazione darwiniana, come nella competizione capitalistica, i meno forti, i marginali è bene che colino a picco, come capita al cagnolino gracile che mamma cagna scansa per poter allattare bene chi nella cucciolata è quel tanto robusto da essere destinato a sopravvivere. Ma può valere una regola del genere, nel contratto sociale che ogni essere umano stipula, per legge di natura, con i simili all’interno di una nazione e di uno stato? Certamente no, quindi occorre fare in modo che chi non ce la fa, chi rischia di essere travolto dalla rarefazione dei posti di lavoro possa riprendersi e tornare a contribuire dignitosamente allo sviluppo della società.
Benvenuto fa qualche proposta ai sindacati: riforma dello stato sociale con la continua alternanza lavoro-formazione, incentivi per la prosecuzione dell’età lavorativa, salario minimo UE contro il dumping sociale, controllo etico sui fondi pensione, dirottamento di esuberi su azioni di utilità sociale. Fa qualche proposta allo stato, come riformare la sanità pubblica e puntare su un fisco equo e condiviso con i partner UE.
Mentre molti capi partito continuano ad azzuffarsi, in una campagna elettorale dove sembra che tutti siano contro tutti e nessuno per la Repubblica, e per questo tutti promettono elargizione di soldi pubblici, abbuoni, regalie, esenzioni, sussidi e chi più (non) ne ha, più ne metta, Benvenuto ricorda che la dignità dell’essere umano proviene dal lavoro e dal merito, e che le politiche pubbliche dovrebbero concentrarsi non nella “corruzione” del rapporto tra cittadino e stato attraverso reciproci favori ma nella creazione di opportunità strutturali per lavoratori, professioni e imprese. Le elargizioni fanno solo danni, servono investimenti nel sociale e per il lavoro.












