Ripartire, ricostruire e rinascere. Sono queste le parole d’ordine de I cantieri della storia (Mondadori 2020) di Federico Rampini. L’autore passa in rassegna gli ultimi duemila anni di storia alla luce del decadimento e della rinascita delle civiltà. Selezionati alcuni snodi cruciali del passato, Rampini definisce questi come cantieri della storia, momenti da cui si è partiti per costruire nuove civiltà. Costruire cantieri della storia vuol dire ripartire dopo il disastro. «Civiltà intere sono sopravvissute a eventi terribili. Dopo ogni guerra c’è stata una ricostruzione. Dopo ogni depressione arriva un’età dell’ottimismo e del progresso». I successi partano dalle macerie: da lì si raccolgono energie, forze, idee per costruire un avvenire migliore. La consapevolezza delle proprie capacità è l’ingrediente alla base di ogni rinascita nella Storia umana.
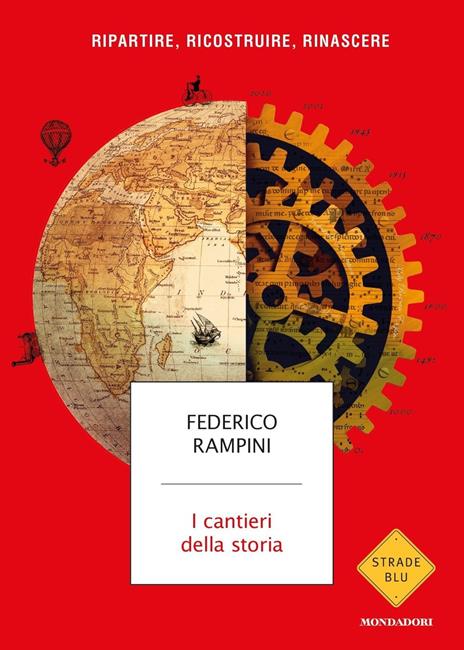
Primo di sette momenti, la caduta dell’impero di Roma rappresentò la decadenza occidentale. Lo racconta Kyel Harper, che descrive gli ultimi secoli dell’impero come una concatenazione di epidemie e danni ambientali. Questi indebolirono la resistenza romana alle invasioni barbariche. Al che si arrivò all’arretramento politico, sociale, tecnologico e culturale del 476, quando Odoacre depose Romolo Augustolo. «Una caduta senza rumore», nella formula di Arnaldo Momigliano. «L’alleanza tra guerra, invasioni straniere, peste e cambiamento climatico cospirò per invertire un millennio di progresso materiale e trasformò l’Italia in una zona arretrata dell’Alto Medioevo», spiega Harper. L’incapacità di rinnovarsi da parte dell’impero si vide anche nei bilanci dello Stato. Due terzi dei 250 milioni di denarii erano allocati a difesa ed esercito. «Le spese militari diventano una causa di collasso finanziario, strangolano l’economia e non riescono neppure più garantire sicurezza», scrive Rampini.
Ibn Khaldūn spiegò che quando un impero si stabilizza a furia di conquiste è come se annacquasse la propria cultura. La sua classe dirigente diventa più incline a consumi voluttuari. In effetti, l’Impero romano aveva abbassato la guardia di fronte alle minacce esterne e aveva dunque seminato le premesse per la sua decadenza. Una cosa simile accade anche all’Impero britannico dopo la Prima Guerra Mondiale. Ogni impero «che ha rinunciato a possedere colonie, a un certo punto della sua parabola storica comincia a temere di fare la fine di Roma», spiega Rampini. «Il declino di una potenza talvolta si identifica con la fine di una intera civiltà dei suoi valori». Oswald Spengler (Il tramonto dell’Occidente) fece riferimento alla caduta di Roma per spiegare l’arretramento delle civiltà europee. Durante la Rivoluzione francese i capi giacobini si sentivano gli eredi dei senatori romani. Napoleone Bonaparte voleva fare il nuovo Giulio Cesare.

A minare alla base l’Impero romano è stato anche l’affermarsi di una religione monoteista. Il cristianesimo aveva spostato il centro dell’universo, mentre «quella dei romani era una religione civica e politica, al centro del culto c’era in fondo Roma stessa. Per quanto Gesù Cristo avesse detto “date a Cesare quel che è di Cesare”, nella Roma cristianizzata la devozione, l’obbedienza, la civiltà dei cittadini si erano trasferite altrove». Pian piano i barbari si sarebbero convertiti al cristianesimo, cosa che diede una spallata all’impero decadente. Nel 410 i Visigoti avevano fatto razzia dell’Urbe e poi si sommarono le epidemie. Raccontata anche nelle memorie di Marco Aurelio, l’epidemia di Galeno o antoniana aveva colpito l’impero nel 165. Seguì quella del 542, la prima peste medievale. «Il bilancio della pandemia si sovrappone a quello delle invasioni». Arriva anche l’analfabetismo di massa, a cui però i monaci pongono rimedio.
Il secondo cantiere della storia vede gli Stati Uniti dallo schiavismo alla secessione, fino alla ricostruzione lincolniana. Il modello di superamento della crisi non avviene soltanto con l’abolizione della schiavitù che era la questione più controversia tra i due campi, tra Nord e Sud degli Stati Uniti. Abraham Lincoln riuscì a far passare nel 1862 tre pezzi di legislazione che cambieranno la storia d’America. Il Pacific Railways Act, che avviò la costruzione della ferrovia da New York alla California; l’assegnazione delle terre occidentali ai coloni; il finanziamento del sistema universitario. Questo anche per mettere un tampone alla guerra americana e unire la nazione. «Di tutti i conflitti che gli USA hanno combattuto, quello che ha fatto più morti oppose gli americani ad altri americani», ricorda Rampini. «Più delle due guerre mondiali, più del Vietnam, a riempire i cimiteri negli Stato Uniti è stato un massacro tutto interno». Settecentomila caduti.
La questione razziale è stata al centro delle controversie politiche. Nel 2019 il New York Times ha lanciato il “1619 Project”, una serie di reportage che mettono lo schiavismo al centro della Storia. Questo, dovrebbe essere considerata la data di origine della nazione, secondo i promotori. «Lo schiavismo mantenne l’economia del Sud in una situazione di arretratezza. La disponibilità di manodopera così a buon mercato ritardò la modernizzazione. I latifondisti erano a loro volta in una “trappola ereditaria”: avevano ricevuto in lascito un sistema di sfruttamento redditizio, ma degradante e instabile. Perfino […] Thomas Jefferson – proprietario di schiavi – finì per convincersi che bisognasse liberarli». La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe, ricorda Rampini, contribuì «a diffondere nel Nord l’empatia verso i neri e lo sdegno per la crudeltà inflitta agli schiavi, fino a diventare una sorta di manifesto letterario dell’abolizionismo».

Quando il 9 aprile 1865 ad Appomattox il generale Robert E. Lee si arrese al nordista Ulysses Grant venne garantito onore ai vinti. Si capì che la guerra ad oltranza non conveniva a nessuno. Il Military Reconstruction Act del 1867 fu il primo atto dell’inizio del cantiere della storia in America. Il Sud venne diviso in cinque distretti ognuno governato da un generale nordista per creare assemblee costituenti e inaugurare nuovi governi locali. In opposizione alla riunificazione statunitense, alla Vigilia di Natale del 1865, in Tennessee, nacque il Ku Klux Klan contro la repubblica e le leggi egualitarie imposte dal Nord. Il KKK praticò linciaggi e torture, raid notturni e roghi delle case dei “collaborazionisti” bianchi. Se la prese con i neri, poi con agli ebrei e gli italiani. Ad oggi, «molti bianchi del Sud non credono che con Abraham Lincoln abbiano trionfato valori etici e di giustizia».
Rimanendo in America del Nord, tra i cantieri della Storia si annoveri anche l’epoca della Grande Depressione e del New Deal roosveltiano. La crisi del 1929 è stata la madre di tutte le crisi economiche. Eppure, gli anni che l’hanno preceduta – i Golden Twenties o Jazz Age – erano caratterizzati dalla spensieratezza. Raccontati da Francis Scott Fitzgerald ne Il grande Gatsby or Ernest Hemingway in Fiesta, furono anche tempi in cui «la distanza tra i ricchi e la maggioranza della popolazione arrivò a dilatarsi mostruosamente». Alan Krueger, numero due del Tesoro sotto Barack Obama, coniò il termine la “curva del Grande Gatsby”. E dimostrò che le disuguaglianze di oggi sono tornate a quelle dei livelli degli anni Venti del secolo scorso. Se quella del 1929 fu la più dura di tutte, già nel 1907 ci fu la prima crisi globale del Novecento.

Nell’ottobre 1929 l’indice di Wall Street perse il trentasette per cento in tutta l’America i risparmiatori assaltarono gli sportelli paralizzando il sistema del credito. Teddy Roosevelt decise dunque di fare pulizia del sistema finanziario sregolato in cui alcuni banchieri potevano decidere la sorte di milioni di risparmiatori. Il Congresso istituì la Federal Reserve e anni dopo approvò la legge Glass-Steagall, pietra miliare della finanza globale. Questa «crea una grande muraglia fra il mestiere della banca commerciale (che raccoglie depositi e fa prestiti) e quello della banca d’affari, che […] opera in borsa assumendo rischi in proprio». Rinascita del 1907 e crollo del 1929. Ancora oggi si crede che il “re dei cattivi” fosse Herbert Hoover e che il “principe azzurro” fosse Franklin Delano Roosevelt. In realtà il presidente repubblicano aveva già prefigurato alcune delle politiche del New Deal, ma fu sconfitto alle urne dall’avversario dem nel 1932.
FDR si rivelò un genio della comunicazione; si ricordino i suoi fireside chats. I suoi primi cento giorni sono un successo. Come era già successo con il suo lontano parente Teddy, anche FDR sarà giudicato non solo autorevole, ma anche autoritario. Prima della vittoria degli Stati Uniti della Seconda Guerra Mondiale, FDR non solo aveva creato il New Deal, ma attuò una politica economica protezionistica e autarchica. Isolazionista. L’America di FDR usò dazi e barriere doganali, svalutazioni competitive e politiche restrittive nei confronti dell’immigrazione. Poco a che vedere con quel John Maynard Keynes a cui spesso FDR viene associato. L’influenza dell’economista britannico trovò più fortuna degli accordi di Bretton Woods del 1944, architrave dell’economia mondiale post-bellica. Una grande rinascita partita da un cantiere della Storia. Lo Stato divenne dunque lo strumento principale della nuova stabilità.

Altro snodo della storia che vide gli Stati Uniti protagonisti e ricostruttori di civiltà è stato il Piano Marshall. L’emissione di prestiti americani agli stati europei distrutti, Germania inclusa, è stata la benzina della rinascita europea. Obbligò Bonn a rinascere sotto una forma democratica, civile e pacifista. Dodici milioni di tedeschi vennero cacciati dall’Europa centro-orientale e rimandati in Germania. Questa, post-bellica, era un cimitero. Molte donne chiesero addirittura aborti spontanei ai medici americani sul luogo, dal momento che non erano in grado di allattare i propri neonati. In Italia, un cittadino assumeva 2500 calorie al giorno nel 1939; 1800 nel 1945. Allora il New York Times parlò di “New Dark Continent”. Il Dopoguerra come un Medioevo moderno, fatto di sofferenza e violenza. Razionamenti anche a Londra nel gelido inverno del 1946-1947. Tony Judt disse che la Seconda Guerra Mondiale era stata anche e soprattutto un’esperienza civile. Aveva ragione.
Senza il Piano Marshall per la ricostruzione dell’Europa, questa non sarebbe come la conosciamo oggi, ammonisce Rampini. I prestiti al Vecchio Continente rappresentavano un decimo del bilancio federale americano. E resero possibile il miracolo tedesco, francese ed italiano. La Germania, la Francia e l’Italia risorsero dai rispettivi cantieri della storia. «In America l’importanza del Piano Marshall non viene capita subito dall’opinione pubblica e una parte della classe politica lo osteggia», ricorda l’autore. «In Europa viene circondato dai sospetti, soprattutto da parte di quelle forze di sinistra che attribuiscono una superiorità politica e morale all’Unione Sovietica». George Marshall era un militare, poi segretario di Stato di Harry Truman. Il quale rifletté sugli errori di Woodrow Wilson alla fine della Grande Guerra e capì che questa volta non si poteva abbandonare gli sconfitti ed alimentarne crisi e rancore. All’epoca, «fallita la gestione della vittoria, gli americani si erano ritirati nell’isolazionismo».
Marshall «è convinto che l’America debba aiutare l’Europa a unire le proprie forze in un nuovo ordine pacifico che includa la Germania stessa». Tuttavia, gli europei avrebbero dovuto aiutarsi tra di loro innanzitutto. E così fecero: la Comunità del Carbone e dell’Acciaio (CECA) fu il primo embrione dell’Unione Europea. Le due materie erano alla base della Germania militaristica: per evitare nuove guerre, si decise di metterle in comune con altri stati. D’altra parte, l’America si era ben armata. Le bombe atomiche che misero fine al conflitto nel Pacifico erano un avvertimento a Stalin e un’accelerazione della fine della guerra contro Tokyo. George Washington era isolazionista e non voleva immischiarsi nei conflitti europei. Così inizialmente anche FDR, che cambiò idea con l’attacco a Pearl Harbour, nel dicembre 1941, quando si circondò di nuovi teorici della politica estera come Dean Acheson e George Kennan.
FDR ricevette molte critiche per l’interventismo oltre i due oceani sia dalla destra xenofoba-isolazionista che dalla sinistra pacifista-isolazionista. Dopo la Guerra si parlò anche di Piano Morgenthau, da Henry Morgenthau, segretario al Tesoro di FDR. Egli voleva rendere la Germania inoffensiva a livello militare per sempre. Molti furono contrari al piano Marshall: Eleanor Roosevelt in testa. Truman e Marshall vennero accusati di essere filotedeschi. Tuttavia, i due si difesero spigando che il vero nemico da combattere non era il Fascismo morto in Germania, ma il Comunismo vivo in Europa centrorientale. La Germania post-Terzo Reich, che aveva debiti pari al quattrocento per cento del PIL, doveva essere alleata dell’Occidente libero e democratico. Gli aiuti a Bonn, a sua volta rinata dal cantiere della storia, posero le basi per la creazione di quello che Geir Lundestad definì l’“impero su invito”. Un’adesione europea al soft empire washingtoniano su base volontaria.
Il quinto dei cantieri della storia di Rampini è la Francia dopo la Guerra. Dal Nord occupato e il Sud collaborazionista, la sfida francese è stata quella di ricompattare la nazione. La rinascita di Parigi avvenne a seguito della battaglia in Indocina e in Indonesia. “Je ne regrette de rien”, cantava Édith Piaf, all’epoca, simbolo della riscossa di una Francia macchiata dalla Vichy di Philippe Pétain e dalle deportazioni degli ebrei. Piaf non rimpiangeva nulla ed era pronta a rinascere. Dopo aver cantato in tournée nella Germania nazista e aver frequentato degli ufficiali tedeschi nel bordello di lusso L’Étoile de Kléber a Parigi, negli anni Cinquanta era rinata come star musicale del paese. All’epoca, Charles De Gaulle diventò un mito, simbolo della République. Aveva organizzato la resistenza da Londra e portò poi la Francia ai vertici della geopolitica mondiale.

La politica estera attiva dei francesi di oggi, dal Mali alla Libia, alla volontà di costruire un esercito europeo, deriva dalla rinascita francese targata De Gaulle. Rampini definisce la Francia “un’Italia con gli steroidi”. La postura debole del Belpaese nelle relazioni internazionali va vista alla luce di un’assenza di un De Gaulle. Il quale, una volta assunto il governo dopo la Liberazione, perdonerà gli industriali, i funzionari e i capi di polizia collaborazionisti per assicurare la continuità dello Stato. Nel 1945 esce “La vie en rose” della Piaf. L’anno dopo “La mer” di Charles Trenet – anch’egli compromesso con i nazisti, siccome cantava alle Folies Bergère davanti alla Wermacht. Le loro sono canzoni «non parlano del presente, anzi lo evitano, esprimono la voglia di tornare a godersi la vita, di amare». Tuttavia, anche la Francia deve fare i conti con il passato.
Una delle nipoti di De Gaulle era stata imprigionata a Ravensbrück, così come Catherine Dior, arruolata nella Resistenza già nel 1941, a ventiquattro anni. Dagli anni Cinquanta, in piena rinascita, Parigi «ruba il ruolo che era stato di Vienna e Berlino prima del Nazismo». Nei cafè di Saint-Germain s’incontrano Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, André Breton, Pablo Picasso, Alberto Giacometti. Da oltre oceano arrivano i jazzisti Duke Ellington e Charlie Parker. La destra gollista e la sinistra marxista si scontrano sulle guerre della Francia all’estero, ma convergono sul fatto che la Coca-Cola sia uno strumento di neo-colonizzazione americana. Dai cantieri della storia si passa al benessere. Inizia il consumismo di massa: a colorare la vita dei cittadini arriva la plastica in tutte le sue forme. Tutto il contrario di quello che succede in Indocina, da cui la Francia si ritura.
Dopo duemila morti e dodicimila soldati feriti in loco, chiama l’America affinché s’incarichi di contenere il Comunismo dilagante nella regione. Quanto alla guerra d’Algeria nel 1956, questa dissanguò la fragile Quarta Repubblica e costrinse il franco a svalutarsi. La crisi del canale di Suez umiliò ancora i francesi. In molti vogliono il ritorno del generale De Gaulle, che inaugurò la Quinta Repubblica nel gennaio 1959. Un sistema presidenziale, con l’elezione diretta del capo dello Stato a suffragio universale. Un sistema nuovo per una stabilità e una rinascita, che prevedeva anche l’alternanza. De Gaulle tornò ai vertici della politica. Il generale non capì il maggio francese, ma risorse ancora. Dopo essere scomparso durante il vertice della crisi del 1968, tornò a Parigi e sfilò per le strade con André Malraux e François Muariac. La Francia era rinata.

L’ascesa del Giappone è da considerare pure un altro cantiere della storia. La sua rinascita è un esempio di nation building di successo a seguito di una dura occupazione militare americana. Gli americani riuscirono in maniera inedita ad esportare la democrazia e con successo. Tant’è vero che i giapponesi ancora oggi molto sono affezionati a questo modello, pur non rinnegando le proprie tradizioni. Il licenziamento di Douglas MacArthur l’11 aprile 1951 fu uno shock per i nipponici. Il 2 settembre 1945, sulla portaerei USS Missori attraccata alla baia di Tokyo aveva ottenuto la resa incondizionata di Tokyo. Divenne quindi il plenipotenziario delle forze d’occupazione sull’isola. L’imperatore Hirohito venne ridotto ad un ruolo cerimoniale, ma era rispettato da MacArthur. Nonostante fosse pur sempre rappresentante di un paese che aveva usato contro il Giappone nell’agosto 1945 per due volte l’arma più devastante della storia dell’umanità.
MacArthur era il De Gaulle giapponese. Egli impostò il cantiere di un Giappone che negli anni Ottanta avrebbe dato molto filo da torcere all’amministrazione di Ronald Reagan in materia commerciale. Scrisse la Costituzione del Giappone ed impose riforme economiche e politiche. Rampini ricorda che all’epoca maturò un’inedita “dittatura militare americana”, ma vennero poste le basi per una liberaldemocrazia moderna fondata sul pacifismo. Sotto MacArthur, quella giapponese divenne una democrazia eterodiretta. Truman si vide costretto a licenziare il generale «perché quest’ultimo è arrivato quasi sulla soglia di un colpo di Stato», ricorda Rampini. Il generale aveva cumulato due incarichi: capo delle forze d’occupazione in Giappone e capo dei combattimenti in Corea. Diventò anche una figura storica per l’amministrazione democratica di Washington, dal momento che voleva attaccare il mandante della Corea del Nord, la Cina Comunista, con la tentazione di scaraventarle addosso la bomba atomica.
Profondamente religioso, i repubblicani pensano di candidarlo alla Presidenza della Repubblica. Quando partì, Hirohito ruppe ogni protocollo e va di persona ad omaggiare il militare, spogliato di ogni incarico. MacArthur aveva ricevuto nel complesso oltre 441 mila lettere dai giapponese. Sintomo di un paese che era cambiato molto, pronto a rinascere. D’altronde, il Giappone ascese ai vertici del pianeta in termini di rilevanza geopolitica già nel 1895. L’allora impero nipponico sconfisse i cinesi nell’isola di Formosa e dieci anni dopo la Russia zarista. Vittoriosa a Versailles, aveva conquistato la Corea e la Manciuria nel 1931. Dal 1937 iniziò l’invasione della Cina. Dopo la Seconda Guerra Mondiale contò i morti: tre milioni. Da sommare anche i malnutriti e i malati brancolanti in un’economia e un paese distrutto. Poi la resurrezione: nel 1960 divenne la quinta potenza mondiale.
Nel 1968 arrivò al secondo posto, dietro gli Stati Uniti in termini di PIL. I dirigenti comunisti cinesi hanno studiato molto il sistema di rinascita giapponese. Gli strumenti che Reagan usò a suo tempo per scongiurare la concorrenza della creatura che gli americani avevano creato e fatto risorgere, saranno usati poi anche da Donald Trump nei confronti della Cina. A differenza di quello trumpiano, quello reaganiano fu di successo. Toyota dovette fabbricare auto negli Stati Uniti assumendo manodopera locale. Cosa che creò problemi all’industria giapponese. Il miracolo economico nipponico finì nel 1989. Questo, un anno importante per la Cina, l’ultimo dei cantieri della Storia analizzati dall’autore. Dopo il massacro della Rivoluzione Culturale di Mao Zedong, il Dragone rinacque con Deng Xiaoping. E dopo Deng l’isolamento internazionale a seguito di Tienanmen, la Cina rinacque ancora dopo il castigo dell’ordine unipolare americano.
La repressione degli studenti costò alla Cina una condanna corale. Colpita dalle sanzioni europee ed americane, all’epoca sembrava che gli anni delle aperture cinesi fossero stati buttati alle ortiche. Tuttavia, a differenza dell’URSS che proprio all’epoca implose, la Cina si risollevò con lo stupore di quasi tutti. Dal cantiere della Storia al grattacielo. Piazza Tienanmen sembrava distruggere ogni speranza, ma allora il Dragone è rinato più forte che mai. Tienanmen «fu l’inizio di una ricostruzione, l’antefatto di una rinascita, la vigilia di una ripartenza, a cui allora pochi credevano», ricorda Rampini. Dopo gli anni bui del Maoismo la Cina si è rimessa in cantiere ed è decollata. Le premesse erano devastanti. La rivoluzione culturale fu una serie di eventi barbarici. Vecchi obbligati ad indossare magliette con scritte le loro colpe, processi sommari agli oppositori e ai monaci, cappucci della vergogna, violenza in tutto il paese.

La rivoluzione culturale fu una battaglia ideologica tra il bene e il male, come ricorda la scrittrice Lu Xin. «Io ero sinceramente convinta che il preside della mia scuola fosse un individuo cattivo. Per me criticarlo significava difendere i miei ideali più alti». L’arrivo di Deng dopo la morte di Mao – e la scomparsa otto mesi prima di Zhou Enlai – fu sia un atto rivoluzionario che di conservazione. Da una parte Deng riuscì a prendere le distanze sufficienti dal Maoismo e aprì la Cina al mondo. Dall’altra, nonostante la modernizzazione, il Partito Comunista Cinese mantiene il monopolio della politica e la sua assenza venne sempre tutt’ora spacciata come un invito al caos. La paura per il caos è una costante nella storia cinese. Ed è quello che accadde nel 1989. Deng si sentì quasi obbligato a reprimere il caos degli studenti.
La strage venne dimenticata dall’Occidente. A tal proposito, Rampini parla di un ricatto del tiranno comunista. «L’alternativa ai carri armati in piazza Tienanmen e il collasso generale che lascerà ad americani ed europei l’incombenza immane di organizzare il salvataggio finanziario di una nazione di un miliardo di abitanti in bancarotta». Nel giugno 1990 Deng stesso disse: «Se la Cina è instabile, il mondo sarà instabile; se dovesse scoppiare una guerra civile in Cina, nessuno avrà i mezzi per fermarla». L’ex VP di Reagan, già capo della CIA e ambasciatore in Cina, George H. W. Bush era convinto che Deng non andasse mollato, ma che fossero necessarie sanzioni minime per placare l’opinione pubblica occidentale. Sarà poi il suo successore Bill Clinton che accoglierà la Cina della WTO, nel momento in cui Pechino cresceva al ritmo del dieci per cento annuo.
Quella della Cina post-Mao e post-Deng è una Cina che risorge. I due cantieri della storia hanno creato la Cina che abbiamo oggi sotto gli occhi di tutti oggi. Quando a Xi Jinping e il lascito di Tienanmen, il presiedente cinese ha capito una cosa. «La prepotenza paga. Sanzioni a parte, l’attenzione della comunità internazionale sulla tragica sorte di Hong Kong è di breve durata […]. Colpirne uno per educarne cento, lo slogan di Mao Zedong, sembra ispirarlo anche nei confronti delle minoranze etniche». Rampini ricorda che Deng è stato in grado di capire il momento giusto in cui aprire la Cina al mondo e approfittare della globalizzazione e le opportunità che questa offriva. D’altronde, capire il proprio momento e rimboccarsi le maniche è la premessa di ogni rinascita, di tutti i cantieri della storia.











